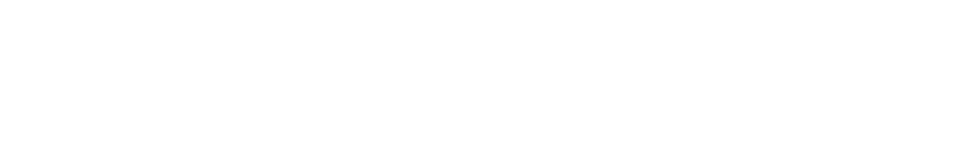Marco Vannini
Da Sulla verità , Paradosso – quadrimestrale di filosofia – numero 2-3/1997 - Il Poligrafo casa editrice s.r.l.
La domanda è un po' vecchia, non solo nel senso che appartiene all'essenza stessa del pensare, ma in quanto fu rivolta da Pilato a Gesù (Gv 18, 38), dopo che questi aveva affermato di essere venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità per cui «chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18, 37).
L'evangelista non riporta la risposta di Gesù, ma è probabile che questa risposta non sia proprio stata pronunciata — del resto era stata data in anticipo, quando Gesù stesso aveva affermato: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), enunciando così, come direbbe Hegel, il concetto più elevato del mondo moderno e della sua religione: che la sostanza è essenzialmente soggetto, e che, dunque, l'Assoluto è spirito, dovendosi considerare la verità non come sostanza, quanto piuttosto come soggetto.