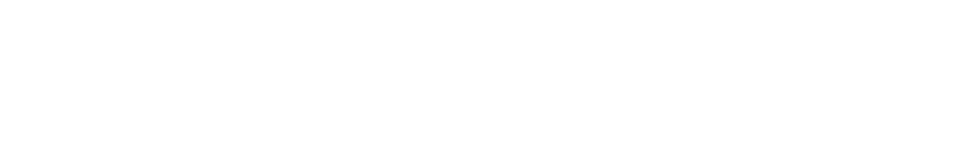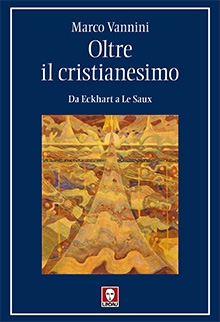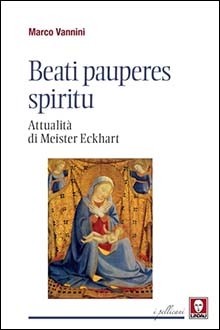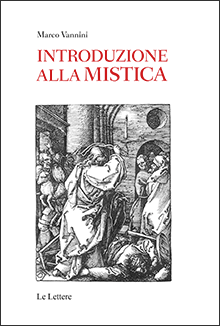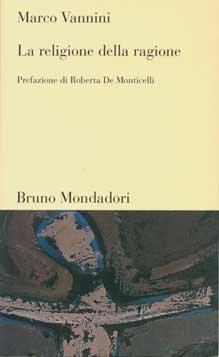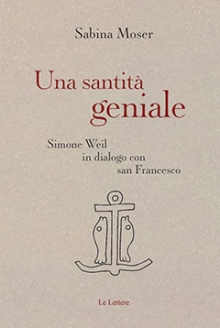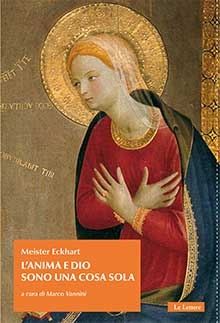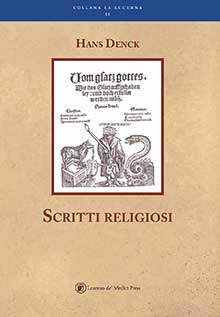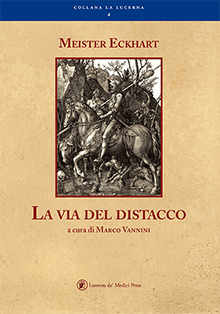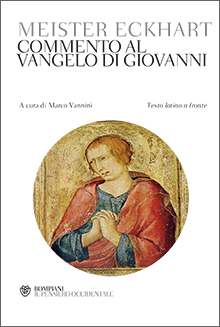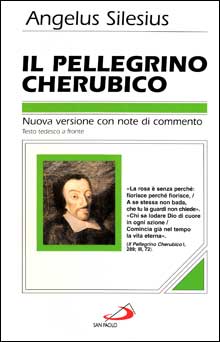Che cos'è la verità?
Marco Vannini
Da Sulla verità, Paradosso – quadrimestrale di filosofia – numero 2-3/1997 - Il Poligrafo casa editrice s.r.l.
La domanda è un po' vecchia, non solo nel senso che appartiene all'essenza stessa del pensare, ma in quanto fu rivolta da Pilato a Gesù (Gv 18, 38), dopo che questi aveva affermato di essere venuto al mondo per rendere testimonianza alla verità per cui «chiunque è dalla verità, ascolta la mia voce» (Gv 18, 37).
L'evangelista non riporta la risposta di Gesù, ma è probabile che questa risposta non sia proprio stata pronunciata — del resto era stata data in anticipo, quando Gesù stesso aveva affermato: «Io sono la via, la verità e la vita» (Gv 14, 6), enunciando così, come direbbe Hegel, il concetto più elevato del mondo moderno e della sua religione: che la sostanza è essenzialmente soggetto, e che, dunque, l'Assoluto è spirito, dovendosi considerare la verità non come sostanza, quanto piuttosto come soggetto [1].
Sarò ampiamente scusato perciò se neppure io darò una risposta, almeno diretta, alla domanda, svolgendo piuttosto alcune riflessioni intorno ad essa. In primo luogo possiamo dire che la domanda stessa ha qualcosa di artificioso, giacché il primo senso della parola "verità" è sempre un senso concreto, specifico, ossia come verità di qualcosa, di qualche fatto, per cui la domanda corretta è del tipo: "Hai mangiato o no le fragole? Qual è la verità?" — e tale domanda corretta ha una risposta altrettanto corretta, un sì o un no. In effetti il problema della verità tanto meno sussiste, o tanto più facilmente è risolto, quanto più la questione è determinata, fattuale, come la distinzione tra la mano destra e la sinistra. Quanto più invece il problema è ampio e generale, tanto più la domanda assume un carattere artificioso, complesso — richiederebbe essa stessa una spiegazione —, e tanto più anche la risposta è complessa e spesso insoddisfacente. Ma è chiaro che proprio questo è il caso della domanda filosofica (o religiosa) su cosa sia la verità: proprio la verità senza specificazioni, in generale, o in assoluto, e non certo la verità di questo o quel fatto.
Questa domanda riguarda infatti il valore più alto, perché tale verità eventualmente trovata non nega le verità modeste, ma sicure, relative ai singoli fatti, ma vuole invece ordinarle in un ordine gerarchico, tenendole tutte in pugno. È infatti la domanda sul senso della vita, sul valore , o, come si dice in filosofia, sull'essere, sulla realtà ecc. A tale domanda sono state date molte risposte, e la storia stessa della filosofia (e della scienza) lo sta a testimoniare: tutte risposte in qualche modo sensate, ovvero delle quali si comprende bene il significato e il valore, ma tutte altrettanto insoddisfacenti, ossia valide solo parzialmente, relativamente ad ambiti e a fini determinati.
Chi capisce questo può cadere nel relativismo, ma se continua a interrogarsi religiosamente sulla verità, ovvero se continua a chiedersi se non vi sia, nonostante tutto, un valore assoluto, comincia invece a vedere non la risposta alla domanda, ma il suo vero senso — e perciò anche a mettersi sulla strada giusta per la risposta. La domanda infatti è una vera e propria domanda di potenza dell'io, del soggetto, che vuole organizzare la sua dominazione del mondo — naturalmente del proprio mondo interiore prima di tutto, ossia prima ancora di quello esterno, e come condizione necessaria alla conquista di quest'ultimo. La "verità" appare allora chiara come strumento essenziale di cui l'io si serve, per rendersi forte e per imporsi. Si comincia allora a comprendere il profondo rapporto che lega l'esigenza di "verità" alla sussistenza del soggetto, a quella che la mistica medievale tedesca chiama eigenschaft, e che possiamo tradurre con "egoità" o "appropriazione". Ma in effetti questa consapevolezza stessa si fa luce solo quando la eigenschaft termina; quando, per motivi e con dinamiche su cui la mistica stessa ha cercato in molti modi di fare luce e su cui non possiamo qui tornare, il soggetto "muore" in quanto soggetto psicologico determinato, centro di appropriazione: l'uomo povero del sermone eckhartiano Beati pauperes spiritu , infatti, è quello che «niente vuole, niente ha, niente sa» [2]. A questa consapevolezza diviene allora anche chiaro il carattere in fondo servile della "verità" di cui ci si faceva forti — e di cui le verità religiose sono gli esemplari più importanti e significativi —, proprio perché tale verità serviva sempre a qualcos'altro (anche a fini "nobilissimi", si intende), dipendeva sempre da un sottile e spesso sottaciuto "perché" — ed era questo l'essenziale.
Possiamo dire allora — e l'apparente paradosso non deve spaventare, come tra breve diremo — che proprio la più profonda esigenza di verità, per la quale si è scavato nel profondo del nostro io, alla ricerca dei moventi spesso inconfessati, e per cui si sono fatte naufragare tutte le determinazioni cui eravamo più legati, riconoscendole tutte dipendenti dalla eigenschaft , porta essa stessa alla liberazione dalla verità, ovvero alla fine di quella smania appropriativa che cerca di "conoscere", cioè possedere la verità. Commentando Rm 6, 22, «Nunc vero liberati», Meister Eckhart parla perciò della necessità di liberarsi dalla verità, sia da quella che è tale per partecipazione, o per denominazione esteriore, sia dalla verità stessa; e questo sia perché l'idea di verità è più pura della verità stessa, sia perché è l'essere nudo — privo di ogni idea che lo imita, in corrispondenza dei nostri modi di pensarlo e di coglierlo — a portare beatitudine e salvezza [3]. In altre parole, la fine della pretesa di verità nel senso appropriativo, correlata indissolubilmente alla fine del soggetto come centro di volizione e di sapere, porta a quella verità del proprio essere (possiamo infatti ancora continuare ad usare la parola "verità", così carica di significato di valore) che non sta più nella conoscenza e nel possesso della verità, ma nell'essere la verità stessa. In questo senso si esprime Margherita Porete all'inizio del suo capolavoro, Lo specchio delle anime semplici : «Capiranno male tutti quelli che lo udranno, se non sono questa cosa stessa»; e poi: «Nessuno lo crede, se non è questa cosa stessa. Colui che è quel che crede, crede veramente, ma chi crede quel che egli non è, non vive quello che crede» [4], ed Eckhart le fa eco più volte, anche nel sermone che abbiamo sopra citato: «L'uomo non può comprendere questo discorso, finché non diventa uguale a questa verità. Infatti si tratta di una verità senza veli, che giunge immediatamente dal cuore di Dio»; e altrove: «Chi crede non è ancora Figlio» [5].
È facile riconoscere qui l'eco del versetto giovanneo citato all'inizio: lo «Ego sum veritas» di Cristo, proprio accanto all'impossibilità di rispondere con un discorso alla domanda "cosa è la verità?". Perché non avrebbe senso rispondere "l'io è la verità", oppure "tu sei la verità", o cose del genere, in quanto questo tipo di risposta è equivoca: sembra avvalorare quella pretesa di potenza, di valore, di appropriazione dell'io, che è invece proprio quel che deve scomparire perché si possa dire "io sono la verità". Infatti l' io che qui compare non è più affatto il piccolo soggetto determinato dello psicologico, ma — ci si perdoni l'apparente bestemmia — l'"io" stesso di Dio, ovvero lo spirito. Che Dio sia il solo a poter dire "io" con correttezza, di fronte all'insussistenza ontologica del soggetto umano, è proprio Eckhart a sostenerlo, e, non a caso, è ancora con lui che il termine e il concetto di "io" comincia a circolare nel linguaggio filosofico [6]: in lui infatti è chiaro ed esplicito il discorso dei due livelli costituivi dell'uomo quello accidentale, inessenziale, insussistente, dello psicologico, e quello sostanziale, essenziale, reale, dello spirito, il vero "io" al nostro fondo, che è Dio stesso.
È la scoperta di questo fondo ad essere esperienza di verità nel suo senso più profondo — esperienza di essere l'essere, come Silesius la chiama in uno dei suoi distici [7] ; non un "sapere" che, come tale, rimanda sempre ad altro, all'oggetto conosciuto, e dunque sancisce la lontananza dall'essere, la sua alterità. Anzi, al posto della dimensione possessiva del sapere, si sostituisce qui quella dello spogliamento, del distacco da ogni elemento accidentale del nostro io, fino, a giungere nel fondo essenziale, che è il vuoto, il nulla. È a partire da questo nulla che la vita quotidiana acquista un valore infinito, e che torna perfettamente il senso normale e comune di "verità" cuí accennavamo all'inizio: l'essere questa penna qui sul tavolo, ad esempio, appare ora una verità degnissima, di valore infinito, e fonte di gioia altrettanto infinita. La sua importanza è nulla, o quasi, ai fini di questo o quell'elemento di potenza (e perciò era una verità spregiata dalla eigenschaft ), ma appare senza limiti — proprio nel suo essere "senza perché", come la rosa del distico silesiano [8] — all'uomo nuovo che ha rotto la dura scorza della eigenschaft , e che guarda al mondo senza più appropriazione.
Se qualcuno interrogasse per mille anni la vita, chiedendole perché vive, ed essa potesse rispondere, non direbbe altro che questo: io vivo perché vivo. Per il fatto che la vita vive del suo fondo proprio e sgorga dal suo proprio essere, per questo essa vive senza perché , perché vive per se stessa. A chi domandasse ad un uomo sincero, che opera a partire dal suo fondo proprio, perché opera le sue opere, questi, per risponderè giustamente, non dovrebbe rispondere altro che: "io opero per operare". Così Meister Eckhart scrive nel sermone 5b, «In hoc apparuit caritas dei» [9]: l'uomo sincero, ossia l'uomo veritiero, l'uomo vero (wahrer mensch ), come la vita, non rimanda ad altro, non ha un perché dell'agire diverso dall'agire stesso, ma ha in se stesso — nel suo fondo — il più profondo perché. L'uomo vero è l'uomo giusto, il Figlio, chi cerca Dio senza modo e lo coglie come è in se stesso: un tale uomo — scrive sempre Eckhart prima delle frasi citate «vive nel Figlio ed è la stessa vita». Come si vede, anche il maestro medievale riprende il versetto Gv 14, 6, ove sono strettamente unite via, verità e vita nel soggetto, ormai non più soggetto psicologico, ma spirito.
In effetti, solo il concetto dello spirito permette di fondere termini di per sé tanto diversi come verità, via e vita — e, ancora una volta, soltanto Hegel lo ha compreso, quando, nella Fenomenologia dello spirito, appunto, scrive che «esso è quel che si muove, è il soggetto del movimento ed anche lo stesso muovere, o la sostanza attraverso cui passa il soggetto... è, quanto soggetto, altrettanto sostanza, ed è perciò essa stessa lo spirito, proprio perché è in quanto è questo movimento».
E la sostanza si fa soggetto passando per la negazione di tutta se stessa, della propria egoità, per la finitezza e la morte: «nella notte in cui fu tradita, la sostanza divenne soggetto» [10].
Il paradosso e la contraddizione apparente di queste celebri frasi, in cui il soggetto del movimento — lo spirito — coincide con l'atto del muoversi, anzi, il suo essere è solo in quanto si muove, non deve spaventare. Anzi, alla tradizione mistico-speculativa cui ci siamo riferiti è ben chiaro, ed essenziale, che «tranne che l'uomo non comprenda due contraria congiuntamente in uno, in verità non è facile parlare con lui di tali cose, perché, quando egli comprende ciò, allora solamente ha percorso la metà del cammino di vita che io intendo» — come scrive Suso nel Libretto della verità (titolo assai pertinente al tema!) [11].
Qui mi fermo, sia per non debordare dallo spazio assegnatomi, sia per non ricadere nel vizio delle citazioni e dei riferimenti filosofici. Per non sfuggire comunque alla domanda proposta, non posso fare altro che rimandare a quanto accennavo all'inizio: non credo ci sia risposta migliore del silenzio con cui Gesù non rispose a Pilato — cogliendo il senso presuntuoso, polemico, pieno di sé, della domanda postagli dal procuratore. Ma la verità nel senso più forte, la Verità, questo sta a ciascuno scoprirla in se stesso, essendola . Personalmente non aggiungo niente di nuovo, salvo attestare la validità (la verità!) dei maestri che ho citato in queste righe, non avendo — appunto — nulla di personale da dire.
Note:
[1] Cfr. G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito. Prefazione, a cura di V. Cicero, Milano, Rusconi, 1996, pp. 67 e 75.
[2] Cfr. Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Milano, Adelphi, 1985, p. 131.
[3] Cfr. Meister Eckhart , I Sermoni latini, a cura di M. Vannini, Roma, Città Nuova, 1989, n. 169, p. 130.
[4] Cfr. Margherita Porete, Lo specchio delle anime semplici, a cura di R. Guarnieri, G. Fozzer, M. Vannini, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, pp. 131 e 381. La nota 9, p. 130, fornisce ulteriori chiarimenti e riferimenti in merito.
[5] Cfr. Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, cit., p. 138, e Commento al Vangelo di Giovanni, a cura di M. Vannini, Roma, Città Nuova 1992, n. 159, p. 129.
[6] Cfr. ad es. i sermoni "Ego elegi vos de mundo" e "Ecce mitto angelum meum", in Sermoni tedeschi, cit., pp. 94, 232-235. Si veda anche il saggio di Marie-Anne Vannier, Déconstruction de l'individualité ou assomption de la personne chez Eckhart?, in Miscellanea Medievalia . Veröffentlichungen des Thomas-Institutes der Universität zu Köln, Band 24: Individuum und Individualität im Mittelalter, a cura di A. Speer, Berlin-New York, 1996, pp. 622-641.
[7] Cfr. Angelus Silesius, Il pellegrino cherubico, a cura di G. Fozzer e M. Vannini, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1992: «Praticare l'amore è grande fatica: non solo si deve amare, ma essere, come Dio, l'amore stesso». Il distico, I, 71, è intitolato, appunto, "Si deve essere l'essere".
[8] Cfr. ivi, I, 289: «La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce. A se stessa non bada, che tu la guardi non chiede». Il distico è intitolato "Senza perché".
[9] Cfr. Meister Eckhart, I sermoni, a cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2002, p. 127.
[10] Cfr. Hegel, Fenomenologia dello spirito, cit., pp. 1029 e 929.
[11] Cfr. Enrico Suso, Il libretto della verità, a cura di M. Vannini, Mondadori, Milano 1997, p. 47.