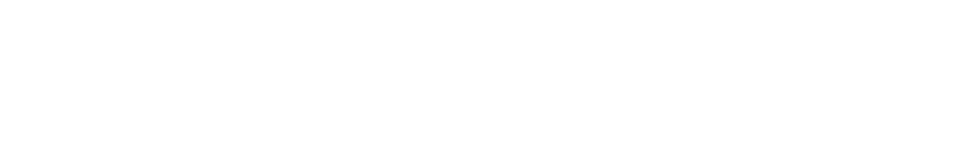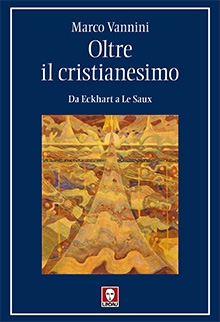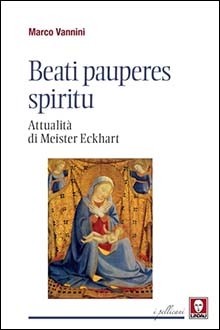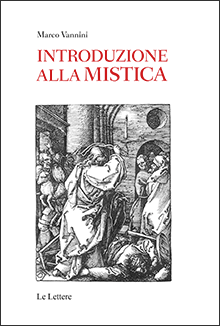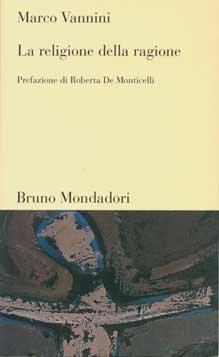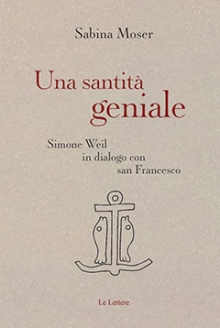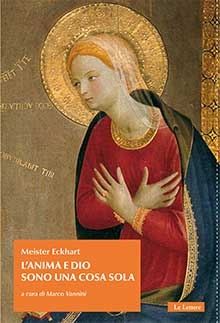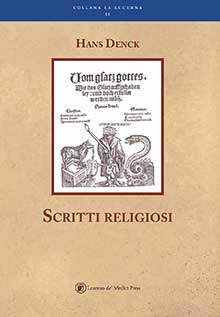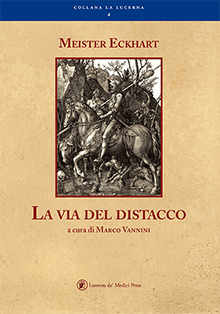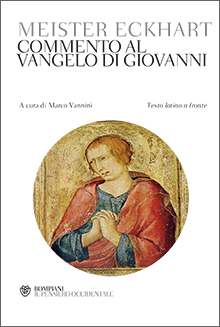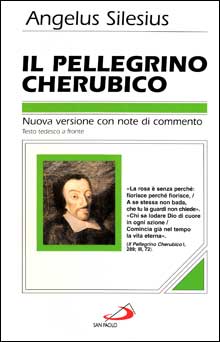Nobiltà

“Chi è degno di grandi cose, è uomo nobile”, scrive Aristotele[1].
Dovendo parlare di dignità, è bene parlarne per così dire nel suo grado più alto, nella persuasione, come dice Platone nella Repubblica, che le cose si vedano meglio quando sono più grandi[2], e che da esse sia poi più facile comprenderne anche il grado più piccolo. Ho scelto perciò il termine nobiltà, nel suo senso morale, spirituale, che è quello appunto che Aristotele indica col termine megalopsichìa (alla lettera: anima grande, reso in latino e poi in italiano con magnanimità).
Nobiltà è una parola ormai desueta, perché il nostro mondo è pervaso dal mito dell’uguaglianza. Ormai persuaso che la democrazia sia un valore assoluto – peraltro senza averci pensato, e senza sapere che si tratta in realtà della forma di governo peggiore di tutte le altre, ad eccezione della tirannide (noi diremmo la dittatura) e che il totalitarismo democratico[3] è la forma peggiore di totalitarismo, nel quale il cittadino è ridotto a una marionetta nelle mani dei veri poteri, che sono quelli forti ma occulti dei detentori dei media – considera cosa riprovevole la aristocrazia. E, non a caso, insieme a nobiltà è pressoché scomparsa la parola virtù, che ha nella sua origine greca (aretè) la radice stessa di eccellenza, nobiltà (aristeia).
La cosa curiosa è che l’egocentrismo, individualismo dell’uomo democratico, descritto una volta per tutte nella Repubblica di Platone[4], il mito del successo a ogni costo in cui la società democratica vive, spinge alla ricerca sfrenata del primato, della superiorità, ma solo nell’ambito economico, del potere, del prestigio sociale, appunto - e per nulla affatto in quello morale, spirituale, ove, anzi, è considerato riprovevole addirittura pensarla, nonché sostenerla o attribuirsela.
Certo, l’aristocrazia non c’è più, nel senso che non c’è più la nobiltà di sangue, che è tramontata perché doveva tramontare, non avendo più vero fondamento, ovvero non avendo più ragioni storiche per sussistere, e quella superstite, in Italia o altrove, è oggetto da operetta. Senza fare riferimenti al presente, ricordiamo l’ironica lucidità con cui, nei Miserabili di Victor Hugo, il vecchio zio, che ha visto Ancien Régime, Rivoluzione e Restaurazione, ricorda all’ingenuo nipote Mario che non si può essere insieme barone e avvocato, ovvero nobile e borghese.
Il vecchio zio vuol dire infatti che non si tratta solo di puri nomi o attributi, ma di diversi stili di vita, diversi e finanche opposti modi di essere. Se guardiamo, come intendiamo fare qui, non certo al sangue e alla razza, ma all’animo, nobiltà vuol dire infatti magnanimità, ove borghesia e democrazia vuol dire pusillanimità (micropsichìa, anima piccola). La prima ha come oggetto l’onore, la seconda l’utile.
L’uomo nobile, spiega Aristotele, è colui che nulla stima grande ed ha come fine principale l’onore, e perciò non sarà mai ingiusto: perché dovrebbe infatti commettere un’azione turpe lui, per il quale nulla è grande? Del tutto ridicolo sarebbe quel nobile che non fosse un uomo giusto. E neppure sarebbe degno di onore se fosse corrotto, giacché l’onore è premio della virtù, ed esso è tributato ai giusti[5].
La nobiltà sembra dunque un ornamento/ordinamento (kòsmos) delle virtù, che le rende più grandi e non sussiste senza di esse. Perciò è difficile essere nobili in verità, giacché non è possibile esserlo senza una perfetta virtù (kalokagathìa)[6].
È molto significativo però che per il nobile, che pure pregia soprattutto l’onore, anche esso è cosa di poco conto (mikròn), perché egli da tutto è distaccato, tanto da passare per uomo sdegnoso[7]. Perciò non ama accedere ai posti d’onore, né dove gli altri primeggiano. Niente è per lui grande, e perciò non è incline a meravigliarsi[8].
Né è incline a serbare rancore, infatti non è proprio dell’animo nobile conservare risentimento nella memoria, soprattutto i mali, ma passarvi a lato[9].
Non parla degli uomini, né di se stesso né di altri: infatti non gli sta a cuore di essere lodato, né disprezzare gli altri. È altezzoso verso i potenti e coloro che godono i favori della sorte, ma misurato verso gli altri, perché è difficile e glorioso essere superiore ai forti, mentre è ignobile mostrarsi forte contro i deboli[10] .
Non è incline a lamentarsi o a chiedere, perché non vuole aver bisogno di nessuno, ma viene in aiuto con slancio. È capace di fare del bene, ma si vergogna di ricevere benefici e vuole contraccambiare più benefici di quanti riceve[11].
Con l’attenzione psicologica che gli è propria, Aristotele nota anche che l’uomo nobile ha un muoversi lento, una voce grave, un’espressione calma, perché non si affretta chi si cura di poche cose e non sta in tensione d’animo chi non ritiene grande nulla, e la voce acuta e la fretta sono causate da queste cose[12].
Sottolineiamo, della medesima trattazione aristotelica, come l’uomo nobile non cerchi il pericolo, specie dove non ne vale la pena, dal momento che ha in onore poche cose, ma “affronti grandi pericoli, e quando li affronta non fa conto della vita, nella convinzione che essa non è cosa degna di vivere a tutti i costi”[13]. Questo, infatti, ossia la subordinazione della vita al valore, all’onore – e non il contrario – è il tratto più evidente dell’anima grande, e in questa descrizione dell'uomo nobile Aristotele ricorda da vicino la delineazione della figura del filosofo in Platone[14].
Niente lo mostra come gli esempi classici: pensiamo ad esempio al racconto che Erodoto fa della battaglia delle Termopili, quando narra della decisione di Leonida di restare al passo con i soli spartani, congedando gli alleati, una volta saputo che erano accerchiati e che sarebbero morti tutti. Il re prese questa decisione, dice lo storico, sia perché aveva ricevuto quell’ordine ed era disonorevole disobbedire, sia per salvare buona parte dell’esercito greco, sia perché l’oracolo di Delfi aveva predetto che Sparta sarebbe stata distrutta, a meno che non fosse morto un suo re della stirpe di Eracle, quale egli era, appunto. “Ma - conclude Erodoto - io ritengo che Leonida volesse così assicurare la gloria dei soli Spartani”[15].
Concludiamo con il punto più importante: la sincerità, la veridicità. Aristotele scrive:
“È per l’uomo nobile necessità essere manifesto nei suoi odi e nelle sue amicizie, giacché il nascondersi è proprio di chi ha paura, e perciò parla e agisce apertamente, abituato a dire la verità e a disprezzare, a meno di non dissimulare ironicamente la sua superiorità - e difatti fa uso dell’ironia con la massa”[16].
“Noi uomini sinceri – così i nobili si chiamavano nell’antica Grecia”, conferma Nietzsche.[17]
È chiaro che ciò non è affatto utile – la finzione è necessaria per il potere, a tutti i livelli, da quello banale economico del commercio a quello propriamente politico (“chi non finge, non regna”, dice il proverbio) – e questo ci conduce direttamente al cuore del nostro tema, come abbiamo già accennato: nobile è l'uomo distaccato dal proprio utile, di ogni tipo, ivi compresa la stessa vita.
Questa immagine dell’uomo nobile non finisce con Aristotele. Nello stoicismo essa prosegue sostanzialmente invariata sottolineando però quelle caratteristiche di virtù che essa già portava in sé, per cui invece di parlare di nobiltà, magnanimità, si preferisce parlare di virtù. Rileviamo infatti come la imperturbabilità stoica, ossia il mantenere uguale animo di fronte alla sorte, qualsiasi essa sia, si trovi già nella trattazione aristotelica:
“l’uomo nobile si comporta con misura anche nel campo della ricchezza, del potere e di ogni fortuna o sfortuna, qualsiasi cosa succeda, e non sarà eccessivamente felice se ha buona sorte, né eccessivamente addolorato se ha cattiva sorte”[18].
Abbiamo citato lo stoicismo perché esso è la corrente di pensiero che più ha influenzato, sotto questo profilo, anche il mondo cristiano degli inizi. Si può dire che la morale cristiana è, con qualche variazione, la morale stoica. Ambrogio, ad esempio, scrive il De officiis ministrorum seguendo pari passo il De officiis di Cicerone, che, a sua volta, è un compendio di opere stoiche. Si ricordi l’alta stima dei medievali per Seneca - “Seneca morale”, come lo chiama Dante[19] - messo addirittura in rapporto epistolare con san Paolo.
Quando poi l’Etica di Aristotele fu nota in Occidente, i filosofi scolastici – basti pensare a Tommaso d’Aquino – la commentarono attentamente, approvandola quasi senza riserve.
Se pensiamo che la mistica è – come rileva giustamente Pierre Hadot[20] – la continuazione vera – l’unica – della filosofia antica, non ci meraviglia scoprire che essa continua a pregiare sommamente la nobiltà, rilevandone, ancor più acutamente che Aristotele, l’intima connessione con la virtù, e soprattutto con la giustizia.
Tra i molti riferimenti che si potrebbero fare, ne scegliamo due. Il primo è quello di una donna, Margherita Porete, che nel suo Specchio delle anime semplici fa intervenire come protagonista il “nobile amore” (la, femminile, fine Amour), e dunque l’“anima nobile” che lo pratica e lo ospita. Come in quello che noi chiamiamo stil novo, la Minnemystik, la mistica d’amore renano-fiamminga, che lo precede, stima infatti soprattutto quell’amore che non consiste in appropriazione, in volontà di possesso, ma – al contrario – in dedizione, distacco, lieta indifferenza alla propria sorte, che quasi viene dimenticata, tanto si è presi dall’amore, che è allora, appunto “nobile amore”. Tanto è distaccato questo nobile amore, da distaccarsi anche da se stesso, proprio in quanto ancora desiderio, legame, e da farsi così non-amore[21].
Il “nobile amore” è testimonianza della parentela[22] profonda – anzi, dell’identità, che l’anima ha con Dio, che è egli stesso – amore.
Questo concetto di origine platonica e neoplatonica, che la dignità dell’uomo, celsa creatura in capacitate maiestatis, è elevatissima perché partecipe della stessa natura divina, continua a operare nello stil novo e poi nella stagione feconda dell’umanesimo fiorentino: pensiamo a due celebri opere: l'orazione De hominis dignitate di Giovanni Pico della Mirandola e il De dignitate et excellentia hominis di Giannozzo Manetti[23]. Purtroppo questa “alba del rinascimento” rimase “incompiuta”, come titola Henri de Lubac il suo studio proprio su Giovanni Pico[24]; seguì invece il tempo cupo della Riforma e della Controriforma, quando l'immagine dell'uomo, e proprio l'immagine religiosa, fu ispirata al più schietto utilitarismo: la “salvezza”, i “meriti”, ecc.
Dobbiamo tornare al medioevo, e veniamo al secondo riferimento. Riguarda un uomo, ma che proprio da quella donna fu potentemente ispirato, ovvero Meister Eckhart. E qui siamo fortunati, perché troviamo un testo intitolato proprio Dell’uomo nobile, accanto, del resto, a molti altri che si riferiscono al medesimo tema.
Il predicatore sta spiegando il versetto evangelico Homo quidam nobilis: “Un uomo nobile partì per un paese lontano per ottenere un regno, e poi tornò”[25], e dice:
“Bisogna sapere che l'uomo ha in sé due nature: il corpo e lo spirito. Perciò un testo[26] dice: chi conosce se stesso, conosce tutte le creature, perché tutte le creature sono o corpo o spirito. Perciò la Scrittura dice, a proposito dell'uomo, che v'è in noi un uomo esteriore e che ve n'è un altro, l'uomo interiore[27]. All'uomo esteriore appartiene tutto ciò che inerisce all'anima, ma è avvolto dalla carne e commisto ad essa, tutto ciò che svolge opera fisica comune con ed entro ciascuna delle nostre membra, come l'occhio, l'orecchio, la lingua, la mano e altro. La Scrittura chiama tutto ciò l'uomo vecchio, l'uomo terrestre, l'uomo esteriore, l'uomo ostile, l'uomo servo.
L'altro uomo che è in noi è l'uomo interiore; la Scrittura lo chiama uomo nuovo, uomo celeste, uomo giovane, amico, e uomo nobile[28]. È a questo che pensa Nostro Signore quando dice: “Un uomo nobile partì per un paese lontano, per ottenere un regno, e poi tornò”[29].
Siamo partiti dal mondo greco, dal quale viene tutto ciò che abbiamo di buono, e non a caso: la distinzione uomo interiore - uomo esteriore di cui si serve san Paolo è platonica[30], e ancora alla “fonte greca”[31] ricorre l'Apostolo per la sua distinzione, anzi, contrapposizione, tra sarx-psiche, ovvero corpo-anima da un lato e pneuma, spirito, dall'altro[32].
La dimensione dell'interiorità, lo interior homo, in quo habitat veritas di Agostino[33], non è infatti quella della corporeità, ma neppure quella, tutta accidentale, dello psicologico. Essa è invece quella di ciò che il maestro domenicano chiama, con un'immagine che risale anch'essa alla grande eredità neoplatonica, “fondo dell'anima”[34], che è privo di ogni determinazione perché vuoto di ogni volere: è la realtà dell'uomo veramente povero di cui parla il celebre sermone 52, Beati pauperes spiritu: l'uomo che nulla vuole, nulla ha, nulla sa[35].
Il fondo dell'anima – o il centro dell'anima, come preferirà dire san Giovanni della Croce[36] – è Dio stesso nella sua nuda essenza, privo di determinazioni: non immagine (idolo), ma spirito, che si comunica a spirito, senza mediazione alcuna[37].
Uomo interiore, in quanto privo di determinazioni, significa perciò uomo in universale: non questo uomo qui, il piccolo Konrad o Heinrich, ma l'universale umanità. E, prosegue Eckhart, ciò che è comune, universale, è nobile, mentre ciò che è proprio, privato, è ignobile, sordido[38].
Si capisce qui come mai alla nobiltà – notava già Aristotele - inerisca in certo modo il disprezzo: non è il disprezzo per gli altri, come falsamente si pensa, ma il disprezzo verso ciò che, di noi stessi, vuole permanere. L'animo nobile cerca l'infinito, e perciò gli ripugna tutto ciò che è finito, se non è occasione e segno dell'infinito, ma vuole invece permanere in quanto finito.
Nello Zarathustra, Nietzsche poeticamente scrive:
“Tutto ciò che è giunto a perfezione, tutto ciò che è maturo, vuole morire […] Ma tutto ciò che non è maturo vuole vivere, ahimé![39]”
Questa è la logica dell'amore-distacco nel Convito platonico, ove, non a caso, con la via del distacco si va dall'amore come desiderio privato, proprio, di appropriazione, verso l'universale della giustizia, il Bene.
All'uomo nobile, che è uomo interiore, e, come abbiamo detto, universale, “il bene degli altri appare ugualmente caro come il proprio, per niente assolutamente di meno” - sia che si tratti di mille marchi d'oro, sia che si tratti della salvezza eterna.[40]
Ma facciamo un altro passo, piccolo ma essenziale. L'uomo nobile, in quanto distaccato da ciò che è proprio, appropriativo, è anche distaccato, ovvero libero, dalle opinioni, e perciò è veritiero.
La menzogna, infatti, finisce solo quando terminano le opinioni, le convinzioni, ovvero i legami al proprio interesse: sotto questo profilo, infatti, le cosiddette “convinzioni sono nemiche della verità più pericolose delle menzogne”[41].
“Chi pensa più profondamente, sa di avere sempre torto, qualunque cosa pensi”, scriveva nello stesso senso Nietzsche[42], il filosofo che, forse più di ogni altro, nel nostro tempo ha esercitato quell'amore di verità per il quale ci si proibisce, a un certo punto, la menzogna delle menzogne, ivi comprese quelle “religiose”.
Liberi dalla pretesa di verità, ovvero liberi dalla menzogna, si riconosce che vi sono solo opinioni, più o meno ingenue, che tutte colgono in qualche modo un aspetto della vita, della realtà, ma che possiamo vivere liberi da esse, e che questo dà grande serenità, grande luce:
“Noi siamo liberi di non formarci alcuna opinione su una cosa o su un'altra e di risparmiare così l'inquietudine alla nostra anima[43]”.
Così, non più schiavo della pretesa di verità, dell'egoità appropriativa, l'uomo libero:
“non vuole niente, non si preoccupa di niente. Il suo cuore è fermo, solo il suo occhio vive – è una morte a occhi aperti. Molte cose vede allora l'uomo che non aveva mai viste e, fin dove giunge il suo sguardo, tutto è avvolto in una rete di luce e per così dire sepolto in essa”[44].
È libero perché è veritiero, non menzognero, e ciò non solo nei confronti degli altri, ma soprattutto nei confronti di se stesso, in quanto il distacco lo fa capace di riconoscere l'egoismo e la menzogna che è connaturale alla volontà, quasi tutt'uno con essa.
“L'intelletto è maestro di finzione”, e svolge perciò “un normale servizio da schiavo”, scrive Nietzsche[45], ben consapevole che le verità sono, per il solito, “un mobile esercito di metafore, metonimie, antropomorfismi, in breve una somma di relazioni umane che sono state potenziate poeticamente e retoricamente, trasferite e abbellite […] illusioni di cui si è perduta la natura illusoria”[46]. Riferendosi specificamente alle sintesi intellettuali:
“Ogni filosofia è una filosofia dell'apparenza […] C'è qualcosa di arbitrario nel fatto che egli [il filosofo] si sia fermato qui, abbia guardato indietro, si sia guardato attorno, non abbia qui scavato più a fondo e abbia messo da parte la vanga; c'è anche qualcosa di sospetto in questo. Ogni filosofia nasconde anche una filosofia; ogni opinione è anche un nascondiglio, ogni parola anche una maschera”[47].
È chiaro anche a Nietzsche che “la menzogna più frequente è quella che ciascuno fa a se stesso; mentire agli altri è un caso relativamente eccezionale”, e questo “non voler vedere certe cose che si vedono, il non voler vedere una cosa così come si vede, è la condizione essenziale di tutti quelli che appartengono in qualsiasi senso a questo o quel partito: l'uomo di partito è necessariamente un impostore”[48]; ove il “partito” non va inteso solo in senso politico, ma in tutto ciò che costituisce gruppo, setta, chiesa, accademia – e perciò il filosofare moderno non ha nulla della libertà degli antichi, ma ha sempre “un colorito politico e poliziesco […] alla sola conquista dell'apparenza erudita”[49].
È molto significativo che il filosofo tedesco – non certo sospetto di simpatie agostiniane – pensi in modo simile al vescovo di Ippona, cui è ispirato il Canone 22 del Concilio di Orange, del 529: Homo non habet de se nisi mendacium - “L'uomo di suo ha soltanto la menzogna”. L'uomo è menzognero per natura, se non è rinnovato dalla grazia, diventando in certo modo oltre-uomo[50].
Il salmo 115, 11: “Ego dixi in excessu meo: omnis homo mendax” viene letto dai mistici proprio in questo senso: ogni uomo è menzognero, e questo vale in primo luogo per noi stessi. Lo si comprende solo nel momento in cui si esce, per così dire, da noi stessi, con profondo dolore (excessus, che significa anche turbamento, ma prima di tutto estasi, rapimento). Il dolore è quello della “morte dell'anima”[51], che riconosce il suo nulla, ovvero la sua radicale malizia, ma proprio in questo riconoscimento scompare la eigenschaft, la “appropriazione”[52] e la grazia[53] giunge nell'anima che ha fatto il vuoto in e di se stessa.
Nelle creature non c'è verità, scrive Teresa di Avila nel suo Castello interiore[54], contrapponendo la verità che è Dio alla menzogna che è l'uomo. La menzogna è, infatti, così connaturale alla creatura, che si può dire esser menzogna la creatura[55] stessa, se non rinnovata dalla grazia.
“Empio, cieco, sciocco e bugiardo è ogni uomo”, intitola Franck uno dei suoi Paradossi[56], in un denso capitolo in cui identifica ogni uomo – non rinato nella grazia - con il “mondo”, ovvero con carne e diavolo.
“Noi nasciamo e viviamo nella menzogna. Non ci sono date che menzogne. Noi stessi, perfino: crediamo di vedere noi stessi e non vediamo che l'ombra di noi stessi. Conosci te stesso è un precetto impraticabile nella caverna”, scrive Simone Weil riflettendo sul mito platonico della caverna[57]. E l'immaginazione è ciò che “tappa le fessure attraverso le quali potrebbe fluire in noi la grazia”[58], proprio come i prigionieri nella caverna platonica giocano con l'immaginazione con le ombre, per cui il mentale-mentire è il peccato per eccellenza, modo principale di essere e di presentarsi dell'egoità.
La menzogna tende a riproporsi in ogni istante, tanto più forte quanto più si è riconosciuta la comune, naturale, malizia del mentale, dando luogo a una sempre maggiore pretesa di verità, per cui il distacco deve esercitarsi anche sul concetto stesso di verità, intesa come un sapere in possesso dell'uomo.
Come è evidente anche dalla sua etimologia[59], la verità è qualcosa che serve alla difesa di se stessi, un’arma, difensiva ma anche potenzialmente aggressiva – e infatti dove c’è la pretesa di verità c’è subito l’aggressività. In questo caso la verità è frutto ed espressione insieme dell'appropriatività.
Perciò Meister Eckhart, interpretando il nunc scio vero liberati di Rm 6,22,[60] dice che esso significa che dobbiamo liberarci anche dalla verità, in quanto pretesa appropriativa. E, parlando della preghiera, che è, come insegna il Damasceno “ascesa dell'intelletto verso Dio”[61] scrive che l'intelletto deve ascendere non solo oltre le immagini, ma anche oltre gli intelligibili, e, in quanto conduce all'essere, bisogna ascendere anche oltre esso; infine, siccome l'intelletto coglie Dio sotto l'aspetto della verità, deve ascendere ancora: “Infatti l'anima deve trascendere Dio stesso sotto questo nome, anzi, sotto ogni nome”[62].
Ciò è assolutamente parallelo al suo celebre concetto della necessità di liberarci anche da Dio (“Prego Dio che mi liberi da Dio”[63], che ha lo stesso senso.
È nel distacco che si giunge alla infinita, beata aghnosìa, ovvero a quel “non sapere”[64] che è libertà dalle opinioni, libertà dai contenuti, signoria dell'identico e del diverso, beatitudine[65] della tolta alterità:
“Non ha l'uomo perfetta beatitudine se l'unità non ha risucchiato l'alterità”[66].
Giungiamo ora alla conclusione, tanto importante quanto, forse, inaspettata. L'uomo nobile, in quanto libero, ovvero in quanto distaccato, è aequalis, uguale in tutte le cose, e perciò è l'uomo giusto.
Che non si possa essere giusti senza equità, senza far pendere la bilancia della giustizia dalla parte voluta, quella cui noi incliniamo, ovvero verso cui ci traggono le nostre opinioni e volizioni, ci sembra abbastanza evidente. È chiaro, infatti, che un giudizio è giusto quando non è interessato, e perciò è giusto l'uomo distaccato, che non ha preferenze, inclinazioni, ovvero è uguale in tutte le cose. Nel Commento al vangelo di Giovanni, la sua opera speculativamente più significativa, Eckhart scrive perciò:
“Per essere divino e dei-forme, l'uomo deve comportarsi in modo uni-forme, dappertutto e in tutte le cose [...]non è uni-forme con Dio uno e non è dei-forme chi non è nella medesima disposizione in tutte le cose”[67].
Perciò l'uomo nobile, homo divinus, il giusto, è distaccato: “non cerca niente con le sue opere. Infatti, chi cerca qualcosa con le proprie opere, o agisce per un perché, è un servo, un mercenario”[68], non certo uomo libero, nobile.
Nel sermone Iusti vivent in aeternum, il maestro domenicano, partendo dalla definizione del diritto romano, “giusto è chi dà a ciascuno quello che gli spetta”[69], scrive che danno a Dio ciò che gli spetta, ovvero l'onore, solo:
“quelli che sono completamente distaccati da se stessi, che non cercano assolutamente niente che sia loro proprio in cosa alcuna, qualsiasi sia, grande o piccola […] che non mirano né alla soddisfazione, né al piacere, né all'onore, né all'utilità, né all'interiorità, né alla santità, né alla ricompensa, né al regno dei cieli; che sono usciti da tutto questo, da tutto ciò che è loro proprio” [….] “un uomo siffatto è giusto in questo senso, e in un altro senso lo è chi accoglie da Dio tutte le cose, qualsiasi siano, nello stesso modo uniforme – si tratti di cosa grande o piccola, piacevole o fastidiosa – sempre nello stesso modo, una cosa come un'altra, né più né meno”[70].
Questa immagine del giusto, uomo nobile, come uomo completamente distaccato da se stesso e da tutto quel che è suo, rivolto solo al bene del prossimo, è un'immagine anch'essa classica. La rappresentazione - che io sappia - più bella ce la dà Plutarco, narrando la vita di Aristide l'ateniese, uno dei vincitori di Maratona e salvatori della patria, che venne in odio alla plebe per la sua giustizia e fu perciò ostracizzato. In una celebre pagina, Plutarco racconta che
“un tizio, il quale non sapeva scrivere ed era un perfetto cialtrone, consegnò il suo coccio ad Aristide, credendo che fosse il primo venuto e gli chiese per piacere di iscrivere il nome di Aristide. Questi, stupito, domandò all'uomo se Aristide gli avesse fatto qualche torto. “Nessuno”, rispose l'altro, “io non lo conosco nemmeno, ma sono stufo di sentir ripetere dappertutto che è un uomo giusto”. Aristide ascoltò e non replicò niente: scrisse sul coccio il proprio nome e lo restituì. Quando lasciò la città, pronunciò con le mani tese al cielo l'invocazione opposta a quella di Achille: che cioè gli ateniesi non venissero a trovarsi in alcun frangente che li costringesse a ricordarsi di Aristide[71]”.
Gli ateniesi in realtà ebbero ancora bisogno di Aristide, di fronte alla rinnovata invasione persiana. Aristide tornò in patria, dimenticando ogni offesa, e guidò l'esercito a Platea, dove i greci sconfissero i barbari. Il resto lo tralascio, rilevando solo che Plutarco conclude:
“dicono che la sua tomba fu costruita a spese dello stato, perché Aristide non lasciò neppure i soldi per il funerale. Anche le sue figlie furono sposate con il denaro pubblico, a cura del pritaneo: fu la città che garantì loro una dote”[72].
Questo destino dell'uomo giusto non meraviglia. Anche Platone descrive la sorte del giusto come sventurata, tragica[73], fino ad esser “crocifisso”, nella società che è sempre ingiusta, per cui mi preme sottolineare, in conclusione, la coincidenza del tema nobiltà-giustizia nel mondo classico e in quello cristiano - là dove, beninteso, quest'ultimo è consapevole erede del primo[74].
Marco Vannini
Note:
[1] Ethica Nicomachea, IV, 7 1123 b.
[2]Cfr. Repubblica, II, 368 d.
[3] Cfr. J. Talmon, Le origini della democrazia totalitaria, Il Mulino, Bologna 1967. Al libro l’Autore premette questo pensiero, davvero profetico, di Tocqueville: Je pense donc que l’espèce d’oppression dont les peuples démocratiques sont menacés ne ressemblera à rien de ce qui l’a précédée dans le monde; nos contemporains ne sauraient en trouver l’image dans leurs souvenirs. Je cherche en vain en moi-même une expression qui reproduise exactement l’ idée que je m’en forme et la renferme, les anciens mots de despotism et de tyrannie ne conviennent point. La chose est nouvelle, il faut donc tâcher de la definir, puisque je ne peux pas la nommer.
[4] Cfr. Repubblica, VIII, 558 c – 562 a.
[5] Cfr. Ethica Nicomachea, IV, 7, 1123 b.
[6] Ibid., 1124 a.
[7] Ibid., 1124 a.
[8] Ibid., 1123 b.
[9] Ibid., 1125 a.
[10] Ibid., 1124 b.
[11] Ibidem.
[12] Ibid., 1125 a. Cfr. anche De gen. anim. V, 7, 786 b 35 – 787 a 2: “Si ritiene che una voce grave sia caratteristica di una natura nobile”. Da parte sua, Dante scrive che la fretta “l'onestade ad ogn' atto dismaga” (Purg., III, 11).
[13] Ibid., 1124 b.
[14] Cfr. Repubblica, VI, 486 a-b.
[15] Cfr. Erodoto, Storie, VII, 20.
[16] Cfr. Ethica Nicomachea, IV, 7, 1124 b.
[17] Al di là del bene e del male, IX, <Cosa è aristocratico>, 260.
[18] Cfr. Ethica Nicomachea, IV, 7, 1124 a.
[19] Inferno, IV, 141.
[20] Cfr. P. Hadot, Esercizi spirituali e filosofia antica, ed. it., Einaudi, Torino 2005.
[21] Cfr. Margherita Porete, Lo specchio delle anime semplici, a cura di R. Guarnieri, G. Fozzer, M. Vannini, ed. San Paolo, Cinisello Balsamo 1994, capp. 134-136.
[22] La synghèneia platonica, per cui vedi soprattutto Timeo 90 a, e poi Porfirio, Lettera a Marcella, 16. Cfr. É. des Places, Syngeneia, Paris 1964.
[23] Cfr. Dignitas et excellentia hominis. Atti del Convegno Internazionale di Studi su Giannozzo Manetti, a cura di S. U. Baldassarri, Le Lettere, Firenze 2010.
[24] Cfr. H. de Lubac, L'alba incompiuta del Rinascimento, ed. it., Jaca Book, Milano 1977.
[25] Cfr. Lc 19, 12.
[26] Si tratta di Isaac Israeli, Liber de diffinitionibus, che Eckhart cita da Domenico Gundissalvi, De divisione philosophiae (ed. Münster 1907, p. 7).
[27] 2 Cor 4, 16; Ef 3, 16.
[28] Cfr. Rm 6, 6 - 17; 1 Cor 15, 47; Ef 4, 22- 24; Col 3, 9-11; Mt 13, 28; Gv 15, 15 ecc.
[29] Cfr. Meister Eckhart, Dell'uomo nobile, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1999, pp. 221 s.
[30] La coppia antinomica uomo interiore/uomo esteriore si trova in Platone (Repubblica 589 a); passa in Paolo (2 Cor 4, 16); in Plotino, (Enneadi V ,1, 10); in Agostino (De vera religione, 72-74), ove sono i celebri passi sulla verità che abita in interiore homine e sulla necessità di rientrare in se stessi, allontanando il molteplice e cercando il luogo “da cui ha origine il lume stesso della ragione”.
[31] Pensiamo al titolo originale, La source grecque, della raccolta di saggi di Simone Weil, apparsa in italiano come La Grecia e le intuizioni precristiane, Borla, Torino 1967.
[32] Cfr. 1 Cor 2, 14 s.
[33] Cfr, Agostino, De vera religione, a cura di M. Vannini, Mursia, Milano 2011, XXXIX, 72, p. 137.
[34] Cfr. in proposito Éndre von Ivanka, Apex mentis. Wanderung und Wandlung eines stoischen Terminus, in Plato Christianus, Johannes Verlag, Einsiedeln 1964, pp. 315-352 e M. Vannini, Meister Eckhart e il fondo dell'anima, Città Nuova, Roma 1991.
[35] Il sermone si può leggere in Meister Eckhart, I sermoni, a cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2002, pp. 387-396, o in Meister Eckhart, Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1985, pp. 130-138.
[36] Cfr. ad es. Fiamma viva d'amore B, 1, 9-12 (Opere, a cura del p. Ferdinando di S. Maria, O.C.D., Roma 1967, p. 737 s.).
[37] Il mistico castigliano rivela in questo la sua profonda vicinanza ad Eckhart: cfr. in proposito M. Vannini, Dialettica della fede, Le Lettere, Firenze 2011, cap, II: <La fede come “notte oscura”>.
[38] Cfr. es. i sermoni Omne datum optimum e Dilectus deo et hominibus (I sermoni, cit., pp. 114 e 512). Gli fa eco Sebastian Franck, Paradossi, a cura di M. Vannini, Morcelliana, Brescia 2009, n. 153: Commune mundum, meum et tuum immundum.
[39] Così parlò Zarathustra. Parte quarta e ultima. Il canto ebbro, 9.
[40] Cfr. Eckhart, sermone Praedica verbum (I sermoni, cit., p. 277).
[41] Cfr. F. Nietzsche, Umano, troppo umano, I, 483. Sulla “convinzione” religiosa come menzogna, cfr. ancora L'anticristo, § 55.
[42] Cfr. Umano, troppo umano, Parte nona, § 518.
[43] Cfr. F. Nietzsche, Aurora, 82. Si ricordino i frammenti 46 e 70 di Eraclito (DK 22, B): le opinioni sono come il mal caduco, solo un gioco di fanciulli. Il cristiano Silesius recita: “Le opinioni sono sabbia: stolto chi vi edifica!/Su opinioni ti basi, come puoi esser saggio?” (Pellegrino cherubico, cit., VI, 251: “A chi pratica separatezza”).
[44] Cfr. F. Nietzsche, Umano, troppo umano, II, 308. Questo testo è inequivoco: non solo i concetti, ma perfino i termini – niente volere, niente desiderare, morte a occhi aperti, luce - rimandano alla tradizione mistica. Cfr. il capitolo <Nietzsche: Ecce homo> del mio Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2007.
[45] Cfr. F. Nietzsche, Su verità e menzogna in senso extramorale, in: Id., La filosofia nell'epoca tragica dei Greci e Scritti dal 1870 al 1873, a cura di G. Colli, Adelphi, Milano 1973, p. 370.
[46] Ibid., p. 361.
[47] Cfr. F. Nietzsche, Al di là del bene e del male; <Cosa è aristocratico>.
[48] Cfr. F. Nietzsche, L'Anticristo, § 55.
[49] Cfr. F. Nietzsche, La filosofia nell'epoca tragica dei Greci, cit., p. 278.
[50] Sullo Ȕber-mensch nietzscheiano come l'“uomo nobile” eckhartiano, ovvero l'uomo rinnovato dalla grazia, cfr. B. Welte, Nietzsches Atheismus und das Christentum, Darmstadt 1958, nonché G. Penzo, Nietzsche allo specchio, Laterza, Roma-Bari 1993.
[51] Cfr. M. Vannini, La morte dell'anima. Dalla mistica alla psicologia, Le Lettere, Firenze 2004.
[52] Per questa terminologia rimando al mio Lessico mistico, Le Lettere, Firenze 2012.
[53] Cfr. M. Vannini, Sulla grazia, Le Lettere, Firenze 2008.
[54] “El (Dios) solo es verdad, que no puede mentir; y dase bien a entender David en un salmo, que todo hombre es mentiroso.” Chi pensa il contrario, sta mentendo: “Dios es suma verdad, y la humilidad es andar en verdad; que lo muy es grande no tener cosa buena de nosotros, sino la miseria y ser nada, y quien esto no entiende, anda en mentira” (Obras completas, por el Padre Efrén de la Madre de Dios, B.A.C., Madrid 1954, Vol.II, p. 481).
[55] Cfr. Eckhart, sermoni Vidi supra montem Syon (I sermoni, cit., p. 177); Ego elegi vos de mundo (I sermoni, cit., p. 263).
[56] Impius, caecus, mendax est omnis homo: è il Paradosso n. 67 (cfr. Sebastian Franck, Paradossi, cit.,, pp. 113-116), ricco di innumerevoli riferimenti scritturistici.
[57] Cfr. S. Weil, Dio in Platone, in: Ead., La Grecia e le intuizioni precristiane, cit., p. 69.
[58] “Ciò che in noi proviene da Satana, è l’immaginazione” (S. Weil, Quaderni, II, a cura di G. Gaeta, Adelphi, Milano 1985, p. 138); infatti l’immaginazione “tappa le fessure attraverso le quali potrebbe passare la grazia” (ibidem, pp. 39, 52).
[59] La radice ver - si ritrova nelle lingue germaniche con wehren, bewahren, ecc. Cfr. ancora M. Vannini, Lessico mistico, cit., s.v. “Verità”.
[60] Cfr. Meister Eckhart, Sermoni latini, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma 1989, n. 169.
[61] Cfr. Giovanni Damasceno, De fide orthodoxa, III, 24.
[62] Cfr. Sermoni latini, cit., n. 247.
[63] La celebre invocazione si trova nel sermone 52, Beati pauperes spiritu, cit. Da essa prende il titolo anche il mio Prego Dio che mi liberi da Dio. La religione come verità e come menzogna, Bompiani, Milano 2010.
[64] Cfr. Lessico mistico, cit. s. v.
[65] Cfr. il mio Beatitudine, in: Felicità, a cura di Francesca Nodari, Massetti Rodella Editori, Roccafranca (Bs) 2011, pp. 203-227.
[66] Cfr. A. Silesius, Il pellegrino cherubico, cit., IV, 10. Il distico è intitolato: “La perfetta beatitudine”.
[67] Città Nuova, Roma 1992, n. 112. Alla mia Introduzione all'opera (pubblicata anche col titolo La Justice et la Géneration du Logos dans le Commentaire à l'Evangile selon saint Jean, in: Voici Maître Eckhart. Textes et études réunis par E. Zum Brunn, Millon, Grenoble 1994, pp. 143-162 ) rimando, a completamento di quanto qui brevemente accennato.
[68] Cfr. sermone Iustus in perpetuum vivet (I sermoni, cit., p. 319).
[69] Cfr. Corpus Iuris Civilis, Istituzioni 1,1: “La giustizia è costante e perpetua volontà che attribuisce a ciascuno il suo”.
[70] Cfr. Meister Eckhart, I sermoni, cit., pp. 129 s.
[71] Cfr. Plutarco, Vite parallele, tr. di C. Carena (lievemente ritoccata), Mondadori, Milano 1974. Ricordiamo che Achille, offeso da Agamennone, abbandonando il campo greco aveva invocato la madre, Teti, perché provocasse l’ira di Zeus e gli Achei avessero bisogno di lui (Iliade, I, 404-412).
[72] Ibidem.
[73] Cfr. Repubblica, II, 359 c – 362 c, con il racconto dell'anello di Gige.
[74] Pensiamo ancora a Meister Eckhart, che non teme di scrivere, ad esempio, che i pagani nella conoscenza della virtù giunsero più avanti di san Paolo, giacché giunsero con la loro esperienza là dove Paolo giunse per grazia (cfr. sermone 86, Intravit Iesus in quoddam castellum, in I sermoni, cit., p. 562).