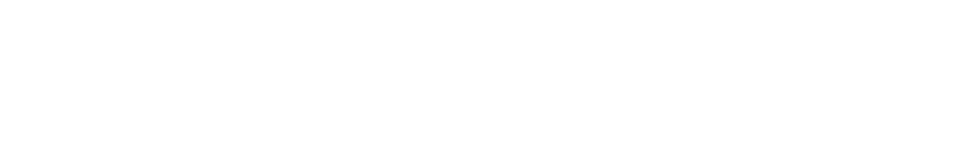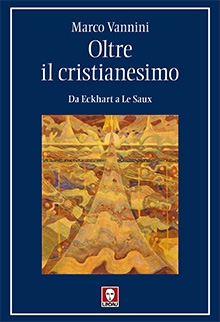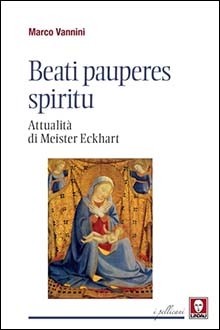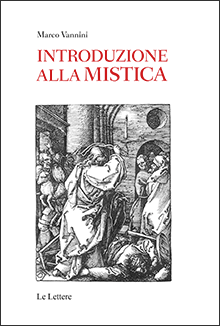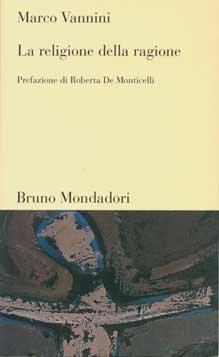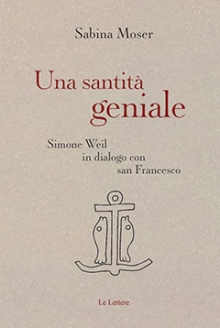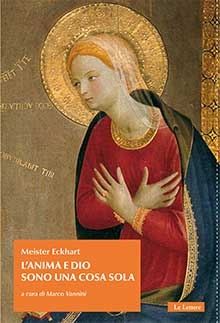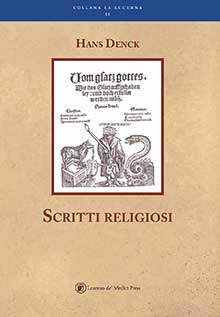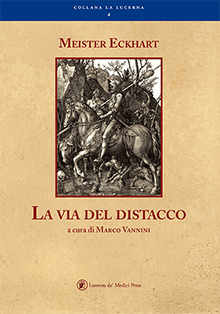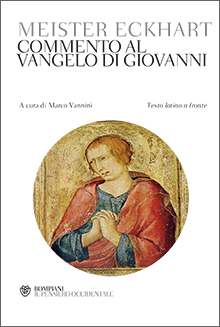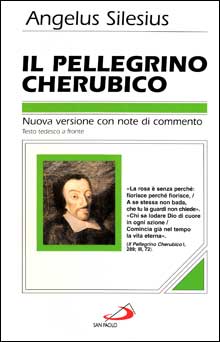Viaggio al centro dell'uomo
Luoghi dell’Infinito, gennaio 2023, pp. 24-28
di Marco Vannini
Obbediente al precetto dell’Apollo Delfico, “Conosci te stesso”, fin dai suoi inizi la filosofia ha avuto l’anima come oggetto primario di indagine, dal momento che, come scrive Platone, “L’uomo, se è qualcosa, non è altro che anima” (Alcibiade I, 130 a-c). Il nostro breve discorso non può perciò partire che da quello che Hegel considerò l’unico libro di psicologia fino ai suoi tempi esistente, ovvero il trattato Sull’anima di Aristotele.
L’anima, che “è in qualche modo tutte le cose” (ivi, 431b), ha le facoltà sensibili non indipendenti dal corpo, con cui fanno un “composto” (koinòn), ma così non è per le facoltà superiori, quelle intellettuali. L’intelligenza che lavora col materiale che le viene fornito dall’esperienza sensibile è determinata dallo spazio-tempo, e dunque condizionata, ma al di sopra di questo intelletto tutto recettivo, “passivo”, Aristotele pone l’ intelletto “attivo”, che non si mescola col sensibile spazio-temporale, “non ha niente in comune con alcunché”, ma ne è “separato”. “Un altro genere di anima”, “divino, impassibile”, “immortale ed eterno” (ibid., 408b; 413b; 429b; 430a), tale intelletto ha costituito sempre un problema per la riflessione filosofico-psicologica, che spesso non aveva, e non ha, l’esperienza necessaria a comprenderlo. La piena comprensione c’è comunque nell’ultima grande voce della filosofia antica, ovvero in Plotino, che spiega come l’intelletto (noûs) sia la facoltà di ragione che agisce indipendentemente da tutto ciò che ha a che fare col corpo, con la molteplicità, con lo spazio e col tempo. Esso è ciò che più propriamente ci costituisce, perché, anche se quando diciamo “noi” possiamo indicare il “composto” col corpo, dal momento che abbiamo pure un corpo, l’elemento veramente umano e non animale, l’ “uomo interiore” di cui parla Platone (Repubblica, 589 a-b), è l’intelletto, elemento divino nell’uomo (cfr. Enneadi, I, 1, 10; V, 1, 40).
Alla filosofia antica era anche chiaro che la conoscenza dell’anima e del “divino che la governa” (cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, X, 1177b), ovvero la conoscenza di ciò che veramente siamo, è essenziale alla felicità – anzi, alla beatitudine – in quanto con tale conoscenza si vive la vita più propriamente umana, realizzando la nostra vera natura (ibid., 1178a). Memore di ciò, il nostro Dante ripete che l’uso dell’intelletto, “fine e preziosissima parte dell’anima, che è deitade”, dà una beatitudine in vita simile a quella celeste (Convivio, III, 2, 19 ; III, 15, 5).
Nel mondo cristiano latino, la distinzione platonica e neoplatonica tra uomo interiore e uomo esteriore, ovvero tra l’ intelligenza libera e quella condizionata, è essenziale in Agostino, che, appoggiandosi sull’autorità di San Paolo (2 Cor 4, 16; Rm 7, 22; Ef 3, 16), parla esplicitamente dell’ “uomo interiore” come “uomo spirituale”, che coglie la Verità senza alcuna mediazione (cfr. ad es. La vera religione, 48-49; 72-74; 77, 113), in opposizione all’ “uomo esteriore”, “uomo psichico” (animalis, in latino) che vive smarrito nelle passioni, in quella che il vescovo di Ippona chiama regio dissimilitudinis, regione della dissomiglianza, ovvero lontananza dall’ Uno, dimensione alienante del molteplice. Agostino consegna così alla filosofia medievale la distinzione fondamentale tra anima e spirito. Da secoli, infatti, soprattutto attraverso lo stoicismo, l’intelletto attivo di aristotelica memoria aveva preso quel nome di spirito (pneûma) che diventerà predominante e con cui anche nelle traduzioni moderne si preferisce rendere il noûs di Plotino. Lo spirito è intelletto, e lo Spirito santo è dato solo a chi vive nell’intelletto, ripete spesso Eckhart. Non sorprende, dunque, che, verso la fine del medioevo, un suo lontano discepolo, il teologo fiammingo Emerico di Campo, affermi che lo Spirito santo è la luce che sempre risplende nell’ intelletto attivo.
Come ha dimostrato infatti nei suoi numerosi studi Pierre Hadot, la filosofia antica prosegue nella mistica cristiana. La vera filosofia è, secondo le parole di Platone, “esercizio di morte” (Fedone, 67e), ovvero distacco, e questo concetto è la chiave di tutto: separato, ovvero distaccato dal sensibile, dal molteplice, dallo spazio e dal tempo, è – come abbiamo visto - l’ intelletto attivo, lo spirito, che sta nell’ Uno e nell’eterno. Perciò l’uomo interiore, l’ uomo nuovo, l’uomo spirituale della tradizione cristiana, è l’uomo che vive nel distacco, ossia nell’ evangelica rinuncia a sé stessi, quando è “morta” l’anima (cfr. Lc 9, 23 s.; Mt 9, 39; Gv 12, 24 s., ecc. ). La “morte dell’anima” è infatti, in tutta la tradizione mistica, la condizione dell’ emergere dello spirito e, con esso, della libertà.
Luce intellettual, piena d’amore
amor del vero ben, pien di letizia,
letizia che trascende ogni dolzore.
Così, nel breve spazio di una terzina (Par., XXX, 40-32), Dante sintetizza mirabilmente la realtà dello spirito: luce dell’intelligenza pienamente dispiegata, ricca dell’amore del Bene, e piena di una letizia che è beatitudine, immensamente superiore a ogni altra gioia.
L’intelligenza tutto comprende quando a niente è legata, rivolta solo alla Verità, come pure l’amore tutto abbraccia quando non è desiderio particolare, ma amore del Bene, e perciò si può dire che lo spirito è essenzialmente distacco. Non deve dunque meravigliare che il contemporaneo di Dante, il domenicano Eckhart, nella conclusione del suo trattato Del distacco, chiami Dio, in quanto spirito, “supremo distacco”.
Intelligenza e amore nella loro pienezza pongono dunque l’anima per così dire in una dimensione nuova, per la quale è necessario non parlare più di anima, ma di spirito. Perciò Eckhart, spiegando il versetto paolino Renovamini spiritu mentis vestrae nell’omonimo sermone, dice che : “L’anima si chiama spirito in quanto è separata dal «qui» e dall’ «ora» e da ogni elemento della natura”.
Per la filosofia e la mistica medievale, dunque, spirito è il termine che indica la realtà dell’uomo costituita dall’intelligenza libera, non dipendente da contenuti, non volta a un fine determinato (“senza perché” è il sintagma usato a questo proposito), ma alla comprensione di tutto, e, insieme, dall’amore, anch’esso non dipendente da fini particolari, ma rivolto all’ assoluto Bene. Questa intelligenza che tutto comprende e, indissolubilmente unito, questo amore che su tutto si stende, sono per l’anima una realtà nuova: realtà ben più vera di quella dell’ accidentalità psichica e, insieme, gioia profonda, inestinguibile, intimamente correlata proprio al senso di realtà. Lo esprime con chiarezza una filosofa dei nostri giorni, Simone Weil, scrivendo, all’inizio della sua Professione di fede: “V’è una realtà situata fuori del mondo, vale a dire fuori dello spazio e del tempo, fuori dall’universo mentale dell’uomo e di tutto ciò che le facoltà umane possono cogliere. A questa realtà corrisponde, al centro del cuore umano, l’esigenza di un bene assoluto, che sempre vi abita e che non trova mai alcun oggetto in questo mondo”. Tale realtà è vera, non frutto dell’immaginazione, e la si coglie per la presenza “al centro del cuore umano” di un bene assoluto “che sempre vi abita”. E qui la filosofa francese ripete precisamente, senza saperlo, l’elemento fondamentale nella mistica di ogni tempo e luogo, ossia la presenza divina, la presenza dell’eterno, al fondo, o al centro, dell’anima - o del cuore, che dir si voglia.
È evidente che l’uscita – èkstasis, per così dire - dalla dimensione del corpo, del molteplice, del tempo, che costituisce la “morte dell’anima”, conduce nel “deserto”, nell’ ”abisso” (come amano appunto esprimersi i mistici) dell’assenza di ogni determinazione, e dunque nel nulla. Esso “fa orrore all’uomo non libero, ma è gioia profonda per l’uomo libero”, perché è il nulla divino: “quando Paolo vide il nulla, allora vide Dio”, scrive infatti Eckhart nel sermone Surrexit autem Saulus, commentando la visione di Paolo sulla via di Damasco, là dove il latino dice: Saulus nihil videbat (At 9,8), in quanto il Dio connotato secondo i modi spazio-temporali è solo una proiezione delle sensazioni dell’uomo e il Dio vero può esser pensato solo come pura luce. Gli fa eco l’anonimo autore del bellissimo testo inglese trecentesco, La nube della non-conoscenza, che, riprendendo la distinzione tra uomo interiore e uomo esteriore, scrive con splendida semplicità: “Ciò che l’uomo esteriore chiama «nulla», l’uomo interiore chiama «tutto»” (cap. 68).
Nulla, luminoso nulla, è l’interiorità dell’uomo, la parte più intima dell’anima, lo spirito: e lì che si ha, secondo il cristiano Eckhart, la vera generazione del Figlio, la nascita di Dio nel mondo – non nel mondo esteriore, ma in quello interiore, ove “il fondo di Dio è il mio fondo, e il mio fondo è il fondo di Dio. Qui io vivo secondo il mio essere proprio, così come Dio vive secondo il suo essere proprio”. E, per significare la beatitudine che è nello spirito – a differenza della felicità, che è della psiche, e del piacere, che è del corpo – nel sermone In hoc apparuit caritas dei il Meister prosegue: “Per chi ha gettato anche solo un istante uno sguardo in questo fondo, per costui mille marchi d’oro sono come un soldo falso”.
Nella predica che tratta della prima delle Beatitudini, Beati pauperes spiritu, dopo aver spiegato nel modo più radicale cosa sia “fondo dell’anima” e in cosa consista il distacco – niente volere, niente sapere, niente avere – Eckhart esplicita la distinzione tra anima e spirito. La prima è legata al corpo, al tempo e allo spazio, al divenire, che è temporale, e perciò destinata a perire: “Quello che sono secondo la mia nascita deve perire ed essere annientato, giacché è mortale, e dunque deve corrompersi col tempo”. Ma nello spirito, quando l’uomo ha raggiunto con la vera povertà ”ciò che è stato in eterno e che sempre sarà”, ovvero quando “Dio è uno con lo spirito”, allora, “secondo il modo del mio non esser nato, sono stato in eterno, sono ora e sarò in eterno”, giacché “la mia essenza è eterna”.
Il magister domenicano non fa altro che riproporre, con una radicalità che non poteva non fargli cadere addosso le censure ecclesiastiche (è in questo sermone che si trova la celebre espressione “Prego Dio che mi liberi da Dio”) la concezione classica del divino presente nell’uomo, e dunque della comune essenza spirituale uomo-Dio, “tolta ogni alterità e diversità”, come dirà esplicitamente Nicolò Cusano. Non è questo il luogo per discutere quanto questa concezione sia biblica e quanto cristiana; ciò che importa è sottolineare come l’esperienza del fondo dell’anima sia quella di una luce che ci costituisce nell’essenza:
“Quando l’anima non si disperde nell’esteriorità, giunge a sé stessa e risiede nella sua luce, semplice e pura”, scrive Eckhart, sempre nel sermone Surrexit autem Saulus, ed anche:
“C’è una luce nell’anima, dove mai è penetrato il tempo e lo spazio. Tutto ciò che il tempo e lo spazio hanno mai toccato, mai è giunto a questa luce. E in questa luce l’uomo deve permanere” (sermone Laetare sterilis, quae non paris).
La compresenza nell’uomo di anima e spirito ha sempre trovato armonica composizione nell’antropologia cristiana antica, che recepiva la triplice categoria classica di corpo, anima, spirito (cfr. ad es. 1Ts 5, 23; Eb 4, 12). Al problema della distinzione tra anima e spirito, salvaguardando però l’unità dell’anima stessa, hanno dedicato grande attenzione i teologi e filosofi cristiani del medioevo (basti ricordare il Liber de spiritu et anima, importantissimo perché attribuito, sia pure erroneamente, ad Agostino).
La differenza tra anima e spirito – la prima nel tempo e nel molteplice. il secondo nell’eterno e nell’ Uno – aveva fatto pensare addirittura a due anime, come risulta ad esempio dei catari. La Summa contra catharos et valdenses, del domenicano Moneta da Cremona, alla metà del Duecento, attribuiva loro tale dottrina, ma già il Concilio IV di Costantinopoli, nel 870, aveva condannato (canone 11) quelli che sostenevano “la presenza nell’uomo di due anime”. La Chiesa ha mantenuto fermo il principio che l’anima è una sola, a costo però di far passare in secondo piano la fortissima, drammatica, contrapposizione che Paolo fa tra uomo spirituale, perfetto, che possiede la sapienza, anzi il pensiero (noûs) di Cristo, e nello spirito scruta tutto, anche le profondità di Dio, giudicando tutto e senza esser giudicato da nessuno, e uomo psichico, che non può comprendere le cose dello spirito di Dio, che sono per lui follia (1 Cor 2, 10-16).
È nella mistica, in quanto esperienza spirituale, che si è mantenuta la consapevolezza che duo sunt in homine, ovvero che nell’uomo è come vi siano due uomini, uomo esteriore e uomo interiore, cioè da un lato il composto corpo-anima, dunque sensazione e sentimento, dall’altro lo spirito, che è puro intelletto, “luce eterna”, che è Dio, ma anche l’uomo (Par. , X, 136; XXXIII, 124-126). Dante, come Eckhart, sapeva solo poche parole di greco, e sarebbe stato ben lieto di sapere che in quella lingua phos significa tanto luce quanto uomo.
Questa consapevolezza prosegue, più o meno esplicita, anche nei grandi esponenti della filosofia moderna. In Cartesio, per il quale l’uomo è essenzialmente pensiero (esprit, spirito, dice infatti, quando scrive in francese); in Spinoza, che identifica intelletto umano e intelletto divino e parla esplicitamente di immortalità dell’uomo (Ethica, V, prop. 23 e scolio), fino ad arrivare ad Hegel, ultimo grande filosofo mistico-speculativo, il cui capolavoro si intitola proprio Fenomenologia dello spirito.
Siamo partiti dal “Conosci te stesso” dell’ Apollo Delfico. Il monito fu completato dai Padri greci della Chiesa con : “e conoscerai te stesso e Dio”. Infatti “l’anima è così completamente una con Dio che nessuno dei due può esser concepito senza l’altro. Si può concepire il calore senza il fuoco e la luce senza il sole, ma non si può pensare Dio senza l’anima, né l’anima senza Dio, tanto essi sono uno” , dice Eckhart, nel sermone Daniel der wissage. È infatti insegnamento comune dei mistici, fino a San Giovanni della Croce, che la conoscenza di Dio proceda dalla conoscenza di sé stessi. Questa affermazione apparentemente paradossale si spiega nel senso che, se non si ha esperienza di spirito, non si ha neppure conoscenza dell’anima e, in parallelo, neppure conoscenza di Dio. Spirito, infatti, è l’elemento essenziale dell’anima stessa, come pure il concetto vero, non esteriore e immaginario di Dio.
Il nostro tempo, che già Hölderlin chiamò dūrftige Zeit, tempo di povertà, vive un enorme disagio psicologico, esistenziale, proprio per l’eclisse dello spirito, ovvero per la riduzione dell’uomo solo a corpo e psiche. Ciò rende da una parte la psicologia mutila della sua componente essenziale – “una patologia” la definisce perciò il grande studioso anglo-indiano A. K. Coomaraswamy (La tenebra divina, Milano 2017, p. 494) -, e, dall’altra, confina la teologia in una sfera tutta dell’immaginazione e del sentimento, che, come sottolineava Hegel, è proprio ciò che non lascia essere lo spirito.
Concludiamo perciò questo breve intervento sottolineando la stringente attualità delle parole che la Filosofia dice a Boezio, rinchiuso nel carcere fisico di Pavia, ma ancor più in quello psicologico delle passioni: “So quale è la principale causa del tuo male: tu non sai più chi sei” (Consolazione della filosofia, I, 6).