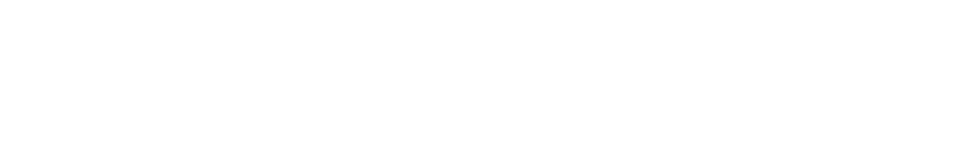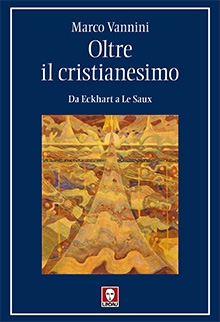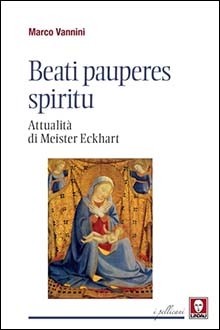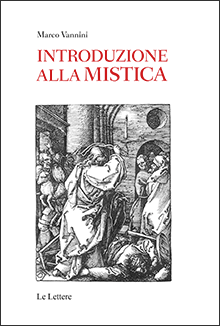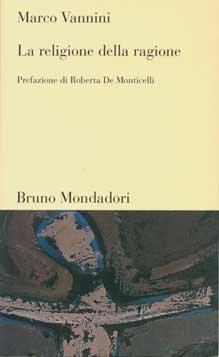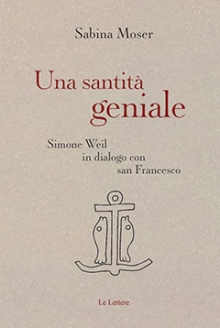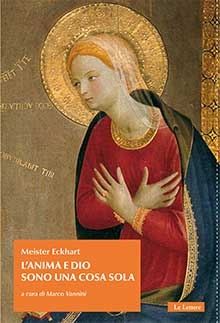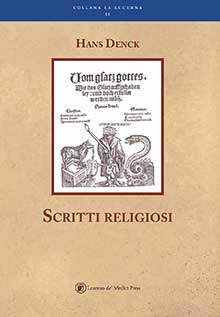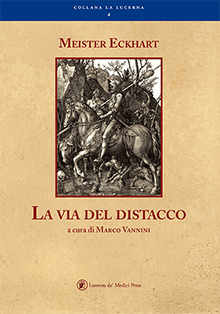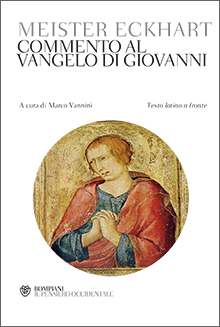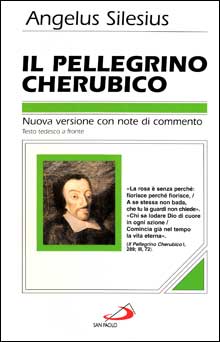Il nobile maestro
L'intellettuale dissidente, 15 febbraio 2021
di Davide Brullo
Alla scoperta di Meister Eckhart, il sapiente del distacco e della gioia intransigente, condannato dalla Chiesa perché “ha voluto saperne di più che non convenisse”. Dialogo con il suo massimo studioso, Marco Vannini.
Arrivò così, come un iceberg di luce, il tagliagole di tutte le certezze. Il titolo del libro, Dell’uomo nobile, ricalca quello del trattato sommario, che scardina, in cui viene descritta la disciplina per realizzarsi (cioè sconfiggersi): “quando l’uomo è spogliato di se stesso e trasformato dall’eternità di Dio; quando è giunto al perfetto e totale oblio della vita effimera e temporale, ed è portato e trasfigurato in un’immagine divina, quando è divenuto figlio di Dio. Oltre questo non esiste un grado più alto”. Il libro, stampato da Adelphi nel 1999, nella ‘Piccola Biblioteca’, aveva l’ambizione di essere una guida, un manuale, parola che sussurri e arde: vi riuscì. Meister Eckhart (1260-1328 ca), pensatore domenicano di formidabile potenza, rampicatore nella tenebra divina, che “ha voluto saperne di più che non convenisse… facendo crescere nel campo della Chiesa triboli e spine” (così papa Giovanni XXII nella Bolla In agro dominico che dichiara eretiche alcune tesi del meister), ci fa percepire con abbacinante nitidezza l’‘altro mondo’, quello vero, proprio dell’“uomo interiore”. Maestro della gioia intransigente, speculatore che entra fin nel cristallino del mistero, Eckhart elogia il distacco – “Il distacco permane in se stesso, e da nulla si lascia turbare” –, insegna a dimenticare le cose effimere, a riporre l’ego nella polvere, mendicando il vuoto: “essere vuoto di ogni creatura è essere pieno di Dio, ed essere pieno di ogni creatura è essere vuoto di Dio”. Impone di morire in questa vita per risorgere nell’unica autentica: “Un uomo veramente perfetto deve essere così uso a morire a se stesso, a spogliarsi di se stesso in Dio, e a trasformarsi nella volontà di Dio, che tutta la sua beatitudine consisterà nel non sapere nulla né di se stesso né d’altro che non sia Dio soltanto” (dal Libro della consolazione divina). Se Meister Eckhart è diventato un nobile maestro per questi tempi fatali, che ci paiono futili, lo si deve a Marco Vannini, che ha curato le opere del pensatore tedesco – il Commento alla Genesi, I sermoni, ad esempio – anche con il genio per l’alta divulgazione. Prima – mi riferisco, ad esempio, al volume Rusconi che raccoglie Trattati e prediche – Meister Eckhart era per pochi studiosi che s’immergono nella teurgia mistica o nella sapienza teologica; ora è lettura necessaria – mi riferivo, appunto, al volume che Vannini ha curato per Adelphi, Dell’uomo nobile, per dire –, per tutti, da tenersi addosso quando si va al supermercato, come un talismano immediato, un toccasana, la botola verso il tempo dello spirito, il tempio, rischioso, ripido salto nel miracolo. L’ultimo libro di Eckhart curato da Vannini, in una attività da studioso inesausta e pressoché inestimabile, s’intitola L’anima e Dio sono una cosa sola (Le Lettere, 2020), e prende spunto da uno dei sermoni più travolgenti del meister, che insegna: “L’anima è così completamente una con Dio che nessuno dei due può essere compreso senza l’altro”. A partire da qui, s’incendia il dialogo con un maestro del nostro tempo, su un maestro senza tempo.
Cosa insegna oggi il mistico vissuto settecento anni fa? Dentro quale inattualità ci precipita?
Settecento anni di distanza non significano niente, se si ha di mira non l’attualità passeggera, ma ciò che costituisce il valore vero, l’essenza reale dell’essere umano. Settecento, o duemila e più, anni non fanno alcuna differenza: si legge Platone, o il Vangelo, o la Bhaghavad-Gita, ecc., come testi che parlano al presente, non meno di quanto parlassero ai tempi in cui furono scritti. Eckhart ci ‘precipita nella inattualità’ proprio perché ci richiama a questi valori veri e a questa essenza reale, sottraendoci alla banalità dell’attualità, in quanto rincorsa affannosa di quello ‘stare al passo con i tempi’ che è frutto dell’ideologia del progresso. Quella di ‘progresso’ è, come notava Simone Weil, una delle idee più stupide che il nostro tempo – tempo miserabile, come sempre lo definisce – coltivi. Idea alienante, perché applicata non solo, che so io, ai mezzi di locomozione, per cui l’automobile è più veloce del cavallo, o cose di questo genere, ma ai valori, al pensiero, per cui si lascia credere ai ragazzi nelle scuole che i contemporanei siano migliori, in tutti i sensi, degli antichi, o dei sempre disprezzati ‘medievali’. Questa idiozia la può credere uno che non abbia mai letto Platone, o, appunto, Meister Eckhart. Una prima, parziale, risposta alla domanda è perciò proprio questa: il mistico vissuto settecento anni fa ci insegna a guardare all’essenziale, togliendo via l’accidentale, il superfluo e inessenziale.
In cosa consiste l’eresia di Eckhart?
In primo luogo diciamo che Eckhart non si è mai considerato eretico, anzi, ha ribadito alla fine della vita la sua ortodossia e la sua appartenenza alla chiesa cattolica. Ciò premesso, possiamo considerarlo ‘eretico’ nel senso etimologico del termine, ovvero in quanto il suo pensiero è frutto di una ‘scelta’ (airesis) autonoma, e non frutto di obbedienza passiva ad un’autorità estrinseca. Nel momento in cui afferma che i maestri pagani, ossia i filosofi greci, hanno conosciuto la verità prima della fede cristiana, è chiaro che egli si situa in un orizzonte di perfetta autonomia filosofica, nella quale la retta ragione è l’unica autorità, come del resto insegnava Agostino nel De vera religione (il testo più amato da Eckhart). In secondo luogo, possiamo considerarlo eretico proprio seguendo le proposizioni sue che come eretiche furono condannate dalla Bolla papale del 1329 – una Bolla, notiamo peraltro, emanata da uno di quei papi avignonesi che rappresentano una delle pagine peggiori della storia della chiesa. Non v’è dubbio, infatti, che a partire dalla tesi dell’eternità del mondo, a quella dell’uomo buono per cui vale tutto ciò che la Scrittura dice di Cristo, ovvero cui è propria la stessa natura divina del Figlio di Dio, per finire a quella della gloria di Dio che si manifesta e risplende in ogni opera, anche in quelle cattive, il Meister si sia discostato ampiamente dall’insegnamento corrente del magistero ecclesiastico. Ora, la domanda non è tanto se queste, ed altre qui non citate per brevità, tesi siano o no ‘eretiche’ rispetto al magistero ecclesiastico, di allora o di oggi, bensì se siano o no coerenti con l’insegnamento evangelico, ed è a questa domanda che, con urgenza, quasi con prepotenza, ci sospinge oggi Eckhart.
“Penso che l’anima nella sua parte più elevata e pura, non abbia niente a che fare con il tempo”: cosa significa? Che cosa intende per anima Eckhart?
A questa domanda troviamo ampia e dettagliata risposta nei testi eckhartiani, soprattutto in quelli presenti nel volume in oggetto. In conformità con la tradizione classico-cristiana, la cui fonte primaria era per il magister domenicano il Liber de spiritu et anima, attribuito dai medievali, erroneamente, ad Agostino, egli dice che l’anima ha due aspetti. Il primo, come è ovvio anche per ciascuno di noi, riguarda il mondo sensibile, che sta nella dimensione della temporalità e della molteplicità – è quella che noi chiamiamo psiche –, mentre il secondo riguarda il mondo intelligibile, che sta nella dimensione dell’eternità e dell’unità – e questo non è per nulla ovvio per noi. Noi abbiamo infatti perduto non solo il nome, ma anche l’esperienza stessa di questo aspetto dell’anima, ovvero della sua realtà spirituale. Spirito è infatti il nome che si dava, e che anche Eckhart dà, all’anima in questo suo secondo, ma essenziale, aspetto. Questo, precisamente questo, è il punto su cui il ‘mistico vissuto settecento anni fa’, come dicevamo all’inizio, ha maggiormente da insegnarci, perché si sta parlando non di astratte questioni teologiche, ma della realtà dell’essere umano, ovvero di ciò che propriamente siamo. Mentre la dimensione dell’anima in quanto soggetta al molteplice, allo spazio e al tempo, è del tutto accidentale, quella spirituale – o, come Eckhart ama spesso dire, quella del “fondo dell’anima” (Grund der Seele) – è la dimensione essenziale. Chi non la conosce, non conosce se stesso, per cui vive smarrito, in una dimensione alienante, quella che Agostino chiama “regione della dissomiglianza”, lontananza dall’Uno, dall’essere, dal Bene. Concludo questa rapida risposta a una domanda cruciale, riportando la frase con cui Simone Weil inizia la sua Professione di fede: «Vi è una realtà situata fuori del mondo, vale a dire fuori dello spazio e del tempo, fuori dall’universo mentale dell’uomo e di tutto ciò che le facoltà umane possono cogliere». Realtà. Questa è la prima e fondamentale parola. Realtà: non opinione, non credenza, non speranza, non rimando a un mondo immaginario. Realtà davvero è ciò che si è, e proprio per questo si conosce veramente e si definisce reale: perché si è. Senza l’esperienza della realtà fuori del mondo, vale a dire fuori dello spazio e del tempo, si conosce solo la realtà situata nello spazio e nel tempo, e dunque solo una parte del reale. Le due realtà, una del mondo ed una fuori del mondo, corrispondono alle due realtà dell’uomo: quelle che la terminologia classica e cristiana chiama, rispettivamente, uomo esteriore e uomo interiore. L’uomo esteriore è quello accidentale, fluttuante, della psiche – uomo psichico lo chiama infatti san Paolo – che vive nell’amore di sé, ovvero nell’amore del corpo, e della psiche ad esso legata: in quella filopsychìa da cui deriva la filautìa, ovvero l’egoismo. L’uomo interiore è invece l’uomo essenziale, saldo nel fondo dell’anima, nell’essere, nel Bene – uomo spirituale, sempre secondo il linguaggio paolino.
A proposito del tempo, mi colpisce questo concetto: “Quando si vede Dio? Quando non c’è un ieri né un domani: Dio si vede quando c’è un oggi, un ora”. Che cosa intende per ora, Eckhart?
A questa domanda, la risposta è, implicitamente, già data al punto precedente. Quando si è fuori dalla dimensione alienante del tempo, siamo nel nunc aeternitatis, in quell’ora che non è più un breve spazio sempre sfuggente tra il passato e il futuro, ma un presente per così dire intemporale, ove tutte le cose, noi stessi e il mondo, siamo eterni, come Dio stesso. Non si tratta qui affatto di esaltazioni o fughe ‘mistiche’, nel senso banale comune; si tratta semplicemente dell’esperienza che la dimensione temporale è data dai sensi, dalla sensazione e dal desiderio, e che essa scompare quando si sta invece nella sfera dell’intelletto, dello spirito. «Uomo, se proietti il tuo spirito oltre spazio e tempo/ In ogni istante puoi essere nell’eternità», è uno (I, 12) dei bellissimi distici del Pellegrino cherubico, opera di quello che è stato giustamente chiamato “versificatore di Eckhart”, cioè il poeta tedesco Angelus Silesius (1624-1677). L’eternità non è un tempo dilatato all’infinito, anzi: «Se ti sembra più lunga l’eternità del tempo/ Stai parlando di pena, non di beatitudine», scrive ancora Silesius (II, 258) rivolgendosi a quel cristiano che pensa all’eternità e alla vita eterna come a un tempo senza fine, e, sempre rivolgendosi allo stesso ideale interlocutore, ammonisce: «Tu dici che vedrai un giorno Dio e la sua luce;/ Stolto, mai lo vedrai, se non lo vedi già ora» (VI, 115): Ora, appunto, fuori dal tempo, nello ewig nun, l’eterno presente.
“V’è nell’anima qualcosa in cui Dio è nudo, e i maestri dicono che quel qualcosa è senza nome, non ha nome proprio”. Mi sembra un pensiero che prevede una ‘poetica’ dell’esistere: cosa significa esattamente?
La frase indica il “fondo dell’anima”, cui abbiamo già accennato. In quanto pura luce, senza alcuna connotazione spazio-temporale, esso – che pure è chiamato in vari modi, secondo una tradizione tanto antica quanto medievale (scintilla dell’anima, castello dell’anima, vertice dell’anima, sinderesi, ecc.) –, è in realtà privo di nome proprio perché senza determinazione alcuna. L’impersonale e, in tedesco, neutro “qualcosa”, è quindi il modo meno peggiore per indicarlo. Siccome fondo dell’anima e fondo di Dio sono un unico e medesimo fondo – questa la tesi di Eckhart: io e Dio siamo una cosa sola, come Cristo ha affermato di sé stesso – nel fondo dell’anima “Dio” abita nudo, ossia anch’esso senza determinazione alcuna. Anzi, talvolta il magister domenicano non si perita di chiamarlo “nulla”, sempre per sottolineare che non gli si può attribuire caratteristica alcuna. Riprendendo allora la seconda domanda, potremmo dire che la principale “eresia” di Eckhart sta nel separare in modo netto l’immagine biblica di Dio, con tutto il suo antropomorfismo, dal concetto di un Dio senza immagine né forma (formlos, bildlos), che si conosce non come oggetto-altro, ma solo essendolo, spirito nello spirito. Questo può apparire scandaloso ad una religiosità di superficie, ma in realtà esprime appieno l’insegnamento evangelico: Dio è spirito (Gv 4, 24) e chi si unisce a lui è con lui un solo spirito (1 Cor 6, 17).
Chi è “l’uomo nobile”? Chi si è staccato dei beni, adempiendo il Bene? Chi si è distaccato da sé? E come si esce da sé, facendo fruttificare l’ego nell’autentico io?
Proprio nel breve trattato intitolato appunto Dell’uomo nobile, Eckhart spiega che questo sintagma equivale a “uomo interiore”, cui abbiamo sopra accennato. Sì, l’uomo nobile è essenzialmente l’uomo distaccato, non tanto dai cosiddetti beni esteriori (denaro, potere, ecc.), quanto dall’egoità, da quel male davvero radicale che è l’amore di sé stessi e la quasi insopprimibile tendenza a riportare tutto a sé stessi – quella che Eckhart chiama spesso “appropriazione” (Eigenschaft). Spiegando i primi versetti del libro biblico della Genesi, afferma perciò che il peccato di Adamo, quello che poi è diventato il peccato originale, consisteva esattamente in questo, nell’amore di sé, che accompagna l’uomo come la sua ombra, e che è la radice di ogni male, in quanto ricerca del bene privato, di fatto opposto al Bene. Ora, distaccarsi dall’amore di sé è possibile solo se si ha di mira il Bene, al cui confronto il bene privato appare piccolo, meschino: la via del distacco perciò non è altra da quella descritta nel Convito di Platone: si abbandona ciò che ci appare piccolo, solo se e quando si ama qualcosa di più grande. Il distacco dall’egoità avviene perciò senza sforzo, in modo del tutto naturale, quando si è esperimentata la gioia profonda che viene dal mettersi in rapporto non con i beni effimeri ed accidentali, ma col Bene. Vorrei sottolineare questo punto: le pagine di Eckhart non hanno niente dell’ascetismo o del moralismo spesso rimproverati al medioevo, ma, al contrario, esprimono sempre una grande gioia, la beatitudine appunto dell’uomo nobile. E qui si aprirebbe anche l’interessantissimo problema del rapporto tra l’“uomo nobile” eckhartiano e lo Übermensch, “uomo dell’oltre” di Nietzsche, in quanto entrambi uomini del distacco. Una questione che non possiamo qui discutere; basti accennare che studiosi importanti hanno sottolineato questa prossimità: del resto, il filosofo tedesco non presentava forse il suo Zarathustra come un “quinto evangelo”?
Come è possibile avere uno sguardo mistico, oggi? Come dobbiamo intendere la mistica, in Eckhart?
Come dicevo all’inizio, rispondendo alla prima domanda, sotto un profilo essenziale tutti i tempi sono uguali e l’uomo è sempre lo stesso, le nostre domande di fondo sono le stesse di quelle dei tempi di Dante e Meister Eckhart (assolutamente contemporanei). A differenza di loro, però, noi ci avviciniamo alla Scrittura con un occhio disincantato, critico, post-illuministico, per cui non ci sforziamo più di ‘salvarne’ la verità di fronte alla filologia e alla conoscenza storica, ma questo non è affatto un problema nel caso di Eckhart, perché lui non dipende affatto dalla Scrittura. Le presta fede, come non poteva non fare un medievale, ma non ne dipende: se anche non avessimo la Scrittura, sarebbe lo stesso, perché abbiamo la creatura ed ogni creatura è piena di Dio, ed è un libro – scrive, alla lettera. Del resto, come abbiamo già detto, secondo lui i filosofi pagani conobbero la verità prima della fede cristiana. Ecco, qui è la risposta alla domanda: mistica in Eckhart è lo stesso che filosofia. E ciò è vero non solo filologicamente, in quanto la parola ‘mistica’ non compare mai nei suoi scritti: è un termine che si afferma come sostantivo solo molto dopo, soprattutto nel XVII secolo, per cui, paradossalmente ma secondo verità, Eckhart avrebbe guardato stupito, senza capire, chi lo avesse chiamato ‘mistico’. Mistica è lo stesso che filosofia, sol che si prendano i due concetti nel loro significato originario, autentico: come la mistica è la via del distacco, consiste essenzialmente nel distacco, così è la filosofia, che come via del distacco è nata in Grecia, a partire da Pitagora, cui si deve il conio stesso della parola, e da Platone, che la definisce “esercizio di morte”, ovvero, appunto, esercizio di distacco. Questa – sottolineo – non è solo una mia opinione: ben più rilevante il fatto che sia sostenuta dal compianto Pierre Hadot, che dai suoi studi sulla filosofia antica conclude come la filosofia in senso forte, “vita filosofica” nel distacco, sia proseguita solo nei monasteri, in quanto appunto ‘mistica’. D’altro canto, in parallelo, molti studiosi contemporanei tentano di sottrarre il magister domenicano all’ambigua categoria di ‘mistico’ e rivendicarne il ruolo filosofico. Per concludere, per essere ‘mistici’ come lo fu Eckhart, occorre recuperare il senso forte e vero di filosofia, che era il socratico “Conosci te stesso”, e così conoscerai te stesso e Dio. Una cosa ai nostri giorni non semplice, in quanto per farlo è necessario prima di tutto liberarsi dalle due presunte scienze che hanno monopolizzato la conoscenza dell’anima e quella di Dio, ossia psicologia e teologia, rispettivamente. Credo che per questo occorrerà ancora un po’ di tempo, ma non disperiamo.