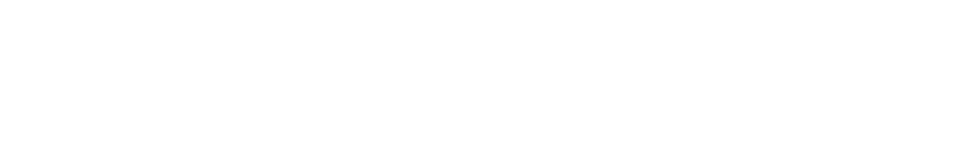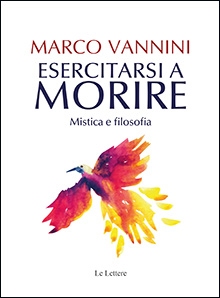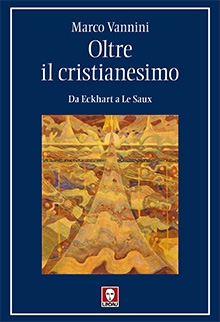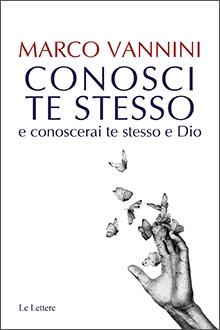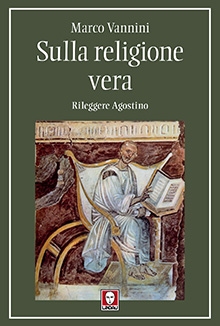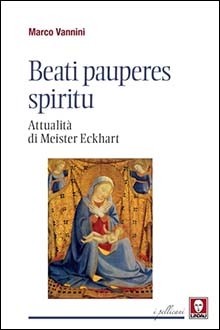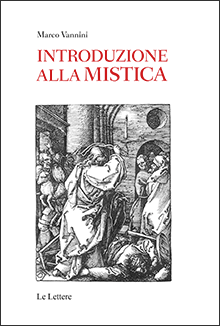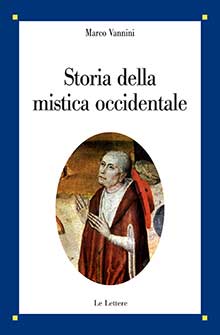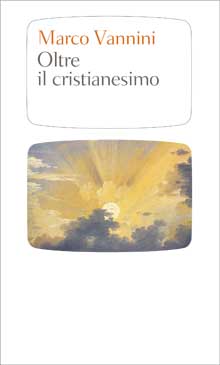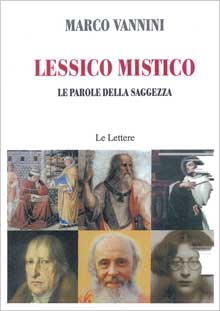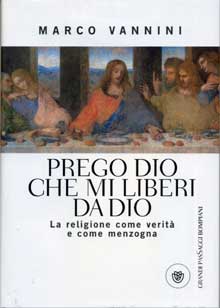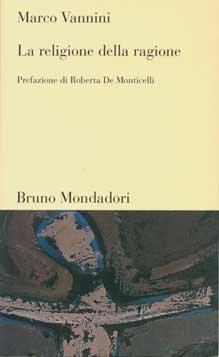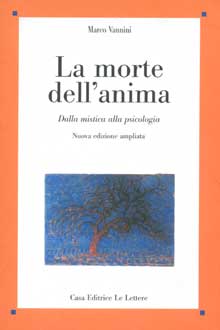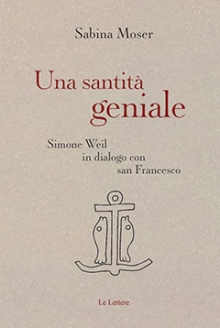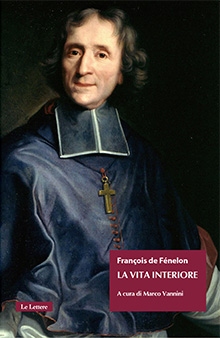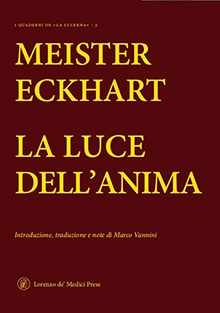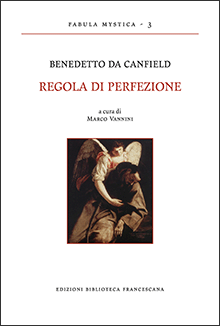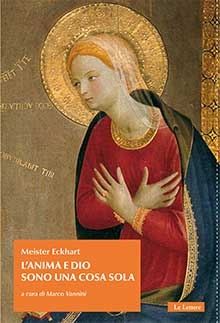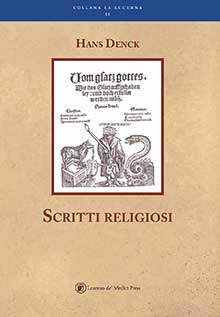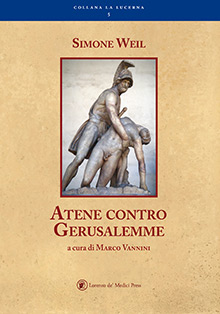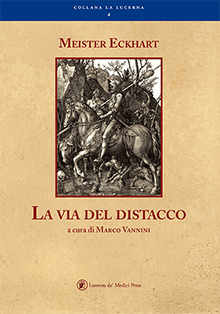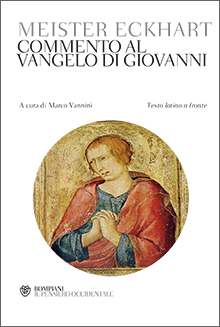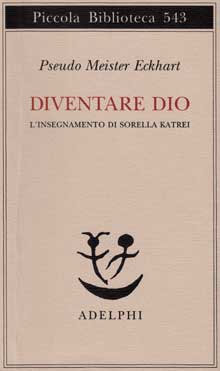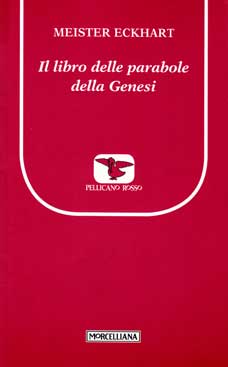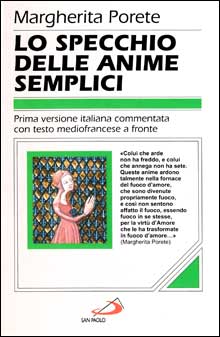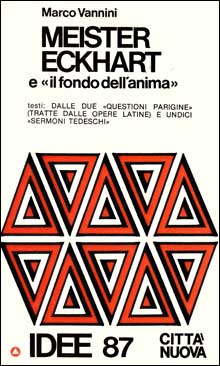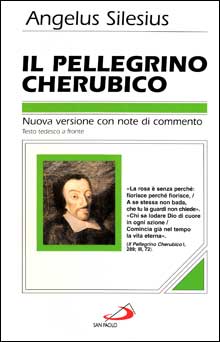La scomparsa dell'anima: non sappiamo più che cos'è
di Armando Torno, in: <Corriere della Sera>, 9 settembre 2003.
C'è un racconto di Giovannino Guareschi dal titolo Commercio, raccolto nel 1953 in Don Camillo e il suo gregge, dove si narra di una discussione sull'esistenza o meno del Paradiso. Il vecchio Molotti, che ha già passato i novanta, compera l'anima del Nero, «rosso come il fuoco e uno dei più scalmanati della banda di Peppone». Il compagno ha fatto un buon affare, perché ha ricavato mille lire dalla vendita di una cosa che per lui non esiste. Però, un certo giorno, il Nero non riesce più a dormire. È preoccupato: ormai Don Camillo è al corrente della faccenda; sente rimorso perché Molotti versa in punto di morte. Ne parla. Vorrebbe farsi restituire l'anima. E qui sospendiamo la sua avventura per ricordare che cinquant'anni fa l'anima, almeno nel linguaggio comune, si sapeva ancora cosa fosse. Si poteva vendere, comperare, lasciarla in pace, farsela curare dagli psicoanalisti che ormai avevano numerosi clienti in tutto il mondo, perderla con le scomuniche della Chiesa che erano in piena attività, salvarsela con il pentimento. Oggi è un po' difficile districarsi, anzi uno dei guru in materia come Adam Philips sta ripetendo che nessuno detiene conoscenze certe sulle angosce e sui desideri e, quindi, non è possibile chiedere ai nipotini di Freud di risolvere i nostri problemi (lo ha ribadito in numerose interviste e ora lo ricorda in Paure ed esperti, tradotto da Ponte alle Grazie). Di più: una serie di dibattiti intorno alla psicoanalisi, apparsa con il favore dell'estate sui settimanali anglosassoni, sottolinea come il concetto di anima sia radicalmente cambiato. Il che significa che chiamiamo con un nome antico qualcosa che forse è il contrario, o tale potrebbe essere. Persino i sondaggi di opinione, con cui a volte crediamo di analizzare i problemi, non trovano percentuali soddisfacenti di intervistati che siano d'accordo su cosa sia oggi l'anima. Gli inviti del Papa a pregare per far piovere e gli appelli alla purezza - due casi che senza una certa concezione dell'anima non avrebbero senso - rischiano di essere fraintesi proprio perché viviamo una dimensione dove pratiche simili hanno ormai caratteristiche esotiche. Il nostro massimo esperto di storia della mistica, Marco Vannini, ha appunto intitolato la sua ultima ricerca La morte dell'anima (è pubblicata da Le Lettere), prendendo posizione definitiva. Pare una battuta, ma i funerali della sostanza soffiata in noi dal Creatore, messa a punto dai filosofi greci, forse si sono celebrati da tempo. È ormai argomento da storici. Per questo gli psicoanalisti utilizzarono subito il lettino: era malferma e malata. E per il medesimo motivo stiamo vivendo un' epoca in cui ogni valore che rimandi alla morale può essere messo in discussione, perché si è dissolta la bussola che ci ha guidato per millenni. Ma c'è qualcosa da aggiungere al lutto: la scomparsa dell'anima ha lasciato visibili ferite nella filosofia, in politica, nell' organizzazione della Chiesa (Vannini ricorda con delicatezza qualche colpa) ma ha messo in ginocchio la società, o meglio la sua parte debole, che a volte è stata governata proprio attraverso i ricatti all'anima. I poveri senza di essa, parafrasando Voltaire, si sono trovati più poveri. Gli umili, con questo vuoto, sono diventati dei derelitti. L'anima, anche se per qualcuno non è mai esistita, rappresentava sempre una ricchezza e per oltre due millenni e mezzo ha aiutato a sbrigare (anche) faccende materiali. Sia detto con rispetto: peccato che nessuno abbia pensato di proclamarla patrimonio dell'umanità, in un'epoca in cui tutto può essere considerato tale. Il racconto di Guareschi ricorda il suo valore pratico. Il Nero, per chi volesse saperlo, riuscì ad avere indietro il contratto su carta bollata con cui vendette la sua anima. Lo bruciò, e le famose mille lire le infilò nella fessura della cassetta delle elemosine. Anzi, per non sbagliare, ne aggiunse altre mille «per grazia ricevuta». Don Camillo, che poco dopo andò a chiudere la chiesa, non mancò di fare la solita domanda al Cristo dell'altar maggiore. «Gesù, - disse - chi riesce a capire questa gente?». «Io», rispose sorridendo il Crocifisso.