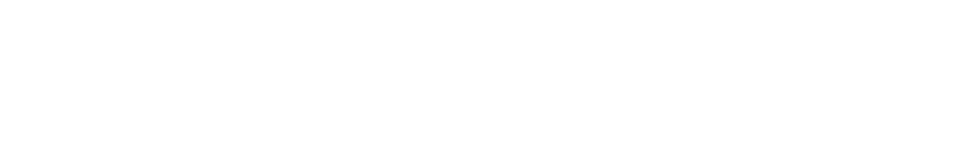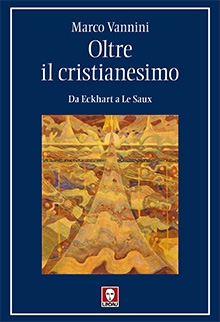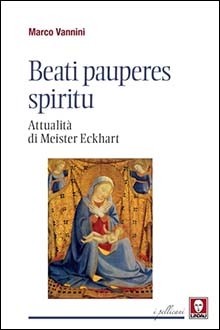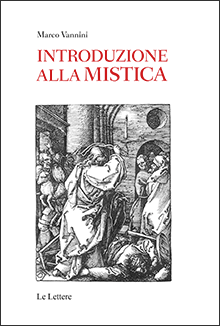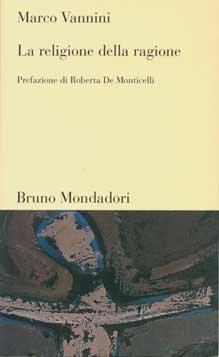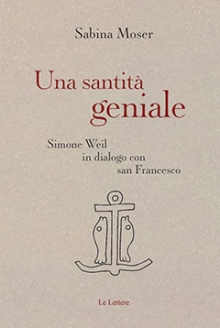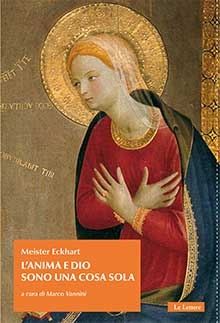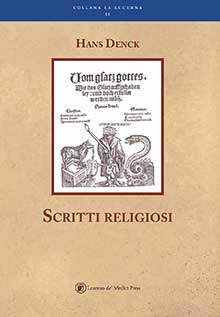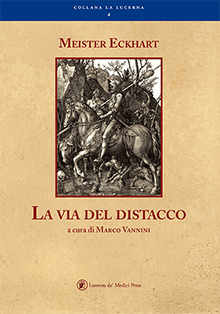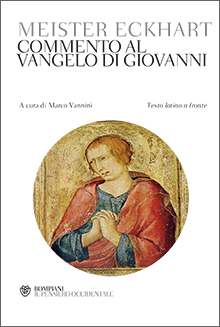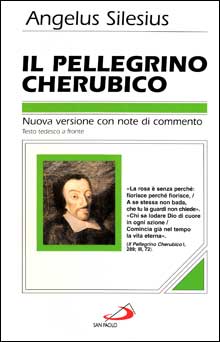La mistica in Marco Vannini
Tesi di laurea magistrale in Filosofia di Alberto Rossignoli (relatore prof. F. Marcolungo): La mistica in Marco Vannini Università di Verona, 2010-2011.
Università degli Studi di Verona
Corso di laurea magistrale in Scienze filosofiche
La mistica in Marco Vannini
Relatore: prof. Ferdinando Marcolungo
Candidato: Alberto Rossignoli
VR089239
Anno Accademico 2010-2011
INDICE
Introduzione
Capitolo 1: una storia della Mistica
Antichità
Medioevo
Epoca moderna
Contemporaneità
Capitolo 2: Mistica e Filosofia: il Logos
Premessa
Margherita Porete
Meister Eckhart
Cusano e Ibn 'Arabi
Angelus Silesius
Hegel
Nietzsche
Simone Weil
Il lieto annuncio
Capitolo 3: L’anima: dalla Mistica alla Psicologia
Psicologia razionale
Cartesio e le passioni dell’anima
Spinoza
Hegel: anima e spirito
La fine dell’anima: Freud e Jung
Bibliografia
Ringraziamenti
Introduzione
Marco Vannini nato a S. Piero a Sieve (Firenze) nel 1948, si dedica da tempo allo studio della mistica speculativa.
Oltre a Meister Eckhart, di cui ha tradotto ormai, con un lavoro ventennale, quasi l’intera opera, tedesca e latina, ha curato l’edizione italiana della Teologia mistica di Jean Gerson (Paoline 1992); il Libretto della vita perfetta dell’Anonimo Francofortese (Newton Compton 1994); le Prefazioni alla Bibbia di Lutero (Marietti 1997); in collaborazione con Giovanna Fozzer, il Pellegrino cherubico di Angelus Silesius (Paoline 1989); Con Giovanna Fozzer e Romana Guarnieri, lo Specchio delle anime semplici di Margherita Porete (San Paolo 1994).
Tra i suoi principali lavori ricordiamo Lontano dal segno (La Nuova Italia 1971); Dialettica della fede (Marietti 1983); Meister Eckhart e il fondo dell’anima (Città Nuova 1991); L’esperienza dello spirito (Augustinus 1991); Introduzione a Silesius (Nardini 1992). Più recenti, ricordiamo Prego Dio che mi liberi da Dio. La religione come verità e come menzogna (Bompiani 2010), Storia della mistica occidentale (Mondadori 2010), Invito al pensiero di sant’Agostino (Mursia 2009), Sulla grazia (Le Lettere 2008), Mistica e filosofia (Le Lettere 2007), La religione della ragione (Mondadori 2007), Tesi per una riforma religiosa (Le Lettere 2006), La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia (Le Lettere 2004).
Nel seguire Vannini lungo una trattazione storica e filosofica sulla mistica, si impone la necessità di definire, quanto meno, come introduzione, l’oggetto di questa ricerca. “Mistica” è una parola dai molti significati, anche assai diversi e contrastanti, carica di valori e disvalori consolidatisi nel corso dei secoli.
Come ricorda Vannini, il termine “mistica” va riportato al suo senso greco originario, nel quale esso non era sostantivo, ma aggettivo di “teologia”, e indicava perciò una scienza di Dio, un discorso su Dio, chiuso, riservato, riguardo al quale sono opportuni il silenzio e la quiete (cui allude il verbo greco myein). La segretezza, il silenzio, la quiete, cui la teologia mistica rimanda, non sono da intendersi, puntualizza Vannini, nel senso di esoterismo; ciò è, anzi, esplicitamente negato dalla mistica, nel significato originario del termine.
Vi è, nondimeno, il riferimento a Dio, che però, per un verso, sembra mancare in Vannini, almeno per quel che concerne il riferimento a un Dio trascendente. Più precisamente, egli intende per “mistica” l’esperienza dell’Uno, ossia della profonda unità tra uomo e Dio; anzi, nella misura in cui l’umano reca con sé il finito, l’esperienza mistica si configura come unità finito-infinito, e, si potrebbe dire, di unità mondo-Dio.
Per questo motivo, si comprende come l’accusa di panteismo sia quella che, da parte delle religioni positive, accompagna più spesso la mistica. L’esperienza dell’Uno, costituente la mistica nella sua essenza, è tuttavia esperienza dello spirito e dell’unità nello spirito e dello spirito, per cui, ammonisce Vannini, non ha senso porsi in una posizione valutativa verso la mistica al di fuori del riferimento allo spirito, nel quale non hanno significato le determinazioni oppositive finite; infatti, la mistica è essenzialmente dialettica, dal momento che l’esperienza dello spirito è al di là di ogni contenuto e determinazione, e, al contempo, del tutto in grado di rendere conto di ogni contenuto e determinazione.
Peraltro, riguardo al concetto di “Spirito”, bisogna rilevare che Vannini non giunge ad una sua definizione vera e propria, insistendo, invece, fondamentalmente sulla sua importanza e sul suo ruolo nella mistica e, in particolare, nella dialettica: qui si vede, peraltro, quanto Vannini sia debitore nei confronti di Hegel.
La mistica, poi, sta quindi al di sopra e al di là della polemica riguardo al suo presunto panteismo; nella rimozione della volontà personale, nell’estinzione di ogni desiderio e contenuto, il mistico sa che la sua volontà è diventata la volontà di Dio e il suo io è diventato l’io di Dio, ma non pensa affatto in termini di “panteismo”, ossia nel senso di una soppressione della differenza tra Dio e il mondo o tra uomo e Dio; anzi, a ben vedere, mai l’alterità e la trascendenza di Dio appaiono chiare come nell’esperienza dello spirito, che è, come già detto, esperienza di unitas spiritus.
Inoltre, in quanto la mistica è esperienza di unità, seppur dialettica, su di essa incombe sempre, oltre all’accusa di panteismo, anche quella di ateismo. Si tratta, nello specifico, di un “ateismo” tutto particolare, ben lontano da ciò che comunemente si intende con questo termine, dal momento che, in questo caso, è la coscienza stessa del divino, dell’Assoluto, che, pienamente esperita nell’identità del soggetto, rischia di negare l’alterità di Dio. È l’“ateismo” di Eraclito, per il quale identico è il Logos umano e quello divino, così come nel caso di Gesù, il quale aveva affermato di essere una cosa sola con il Padre e come nel caso di molte altre personalità della storia della mistica.
Comunque, l’esperienza dello spirito, e questo è un altro punto fondamentale, è sintesi di intelligenza e amore, benché una conciliazione tra i due termini sembri quanto mai ardua: dell’intelligenza nel senso forte dell’intelletto attivo aristotelico, libero da condizionamenti, divino, e dell’amore del Convito platonico, che non è passione e legame ma, al contrario, termine e fine di tutte le passioni, carità che si estende su tutto, dimentica di se stessa.
Su questa tematica, Vannini si preoccupa (a più riprese, talora, pare, eccessivamente) di chiarire che per “mistica” non si intende la cosiddetta “mistica del sentimento”, che, distinta da quella “speculativa”, permette di inserire nel genere mistico tutto l’apparato devozionale, estatico, visionario, della pietà religiosa: è evidente che, in questo tipo di mistica (che peraltro perde di vista il mirabile quotidiano dell’istante, esperienza spirituale per eccellenza), fondamentale è l’aspetto psicologico e di autoaffermatività dell’io, che potrà anche aver valore sul piano storico, ma non certo su quello filosofico.
Centrale è, in Vannini, l’impianto storico: Vannini parte dalla storia della mistica e si fonda sulla storia della mistica per esporre (non tanto per costruire), o, meglio, lasciar intravedere, il suo pensiero nell’abbondanza di riferimenti storico-filosofici. Ma c’è di più.
Proprio il suo approccio alla storia della mistica è peculiare, se si considera come egli abbia praticamente fondato la sua ricerca fin dagli inizi sull’analisi e l’esposizione di Meister Eckhart: egli interpreta e studia la storia della mistica (e della filosofia?) con la lente del pensiero eckhartiano, arrivando a considerazioni che possono sembrare paradossali, chiamando in causa l’intelletto attivo aristotelico e accostandolo alla mistica.
Come si vedrà nella parti finali, la mistica si pone in netta antitesi con la psicologia, intesa non come disciplina che studia alcuni processi della mente e della psiche, ma come pretesa di esser conoscenza esaustiva e normativa della realtà psichica dell’uomo. Come ben scrisse Eraclito, non si può tuttavia avere conoscenza esaustiva dell’anima all’interno dell’anima stessa (non si possono trovare i confini dell’anima...); e, d’altra parte, il riconoscimento della sua radice volontaristica, di quell’amor sui sul quale si articolano, poi, tutti i contenuti psicologici, e che costituisce il peccato originale dell’anima stessa, presuppone semmai un’uscita dallo psicologico, vale a dire, quella morte dell’anima di cui la mistica tanto parla.
Termine chiave della mistica, stante quanto si è detto, è perciò, sin dalla sua origine greca, il distacco. Esso non è altro che il movimento dell’intelligenza e di tutto l’essere che ci libera dalla finitezza, dalla parzialità, dall’incidenza del volere del soggetto in ogni contenuto e affermazione, ossia in ogni legame con le cose ; una liberazione che è possibile solo in rapporto all’Assoluto, poiché soltanto così si può operare la distruzione dell’autoaffermatività : solo in relazione all’Assoluto le cose e il soggetto psicologico appaiono prive di valore, appaiono e sono un puro nulla.
Certo, questa lettura non risolve appieno l’individualità, la quale esce indubbiamente svalutata, ma mai negata appieno; Vannini, infatti, si limita a stigmatizzare (a suon di citazioni e riferimenti) quella che, in fondo, è solo una componente dell’individualità: l’auto-affermazione.
La psicologia, dal canto suo, è incapace di scendere nel profondo (ricordiamoci, però, che neppure Vannini precisa di cosa sia esattamente il “fondo” dell’anima, concezione ripresa pari pari da Meister Eckhart), proprio in quanto resta psicologia, ovvero rimane all’interno di un’esperienza solo e prettamente psichica dell’uomo, priva di spirito: la psicologia, dunque, non è altro che una grande opera di potenziamento dell’Io.
Bisogna altresì rilevare il rapporto conflittuale che la mistica ha, in quanto tale, con le Scritture, ossia con ogni corpus dottrinale o comunque di contenuti che si ponga come determinato/determinante nel rapporto uomo-Dio.
Il mistico insegna a diventare la cosa stessa, diventare il Libro e, è bene far notare, il conflitto mistica e Scrittura è assai più profondo di quello che si pone tra la mentalità laicisticoilluministica e la creduloneria superstiziosa, che pensano entrambe in termini meramente intellettualistici ed estrinseci il rapporto uomo-Dio: ma il rischio non sarà il medesimo, se non si risolve il conflitto, citato poc’anzi, tra intelligenza e amore, specie se si preferisce la prima?
Non è raro che, alla Scrittura, il mistico preferisca il liber Naturae, nel suo infinito svolgersi; ma soprattutto, se cristiano, preferisce l’esempio della vita di Gesù Cristo, cui conformarsi nella totale rinuncia alla volontà personale (rischiando, però, per compulsione, di voler diventare o quanto meno imitare Gesù, inarrivabile, per un essere umano finito e limitato).
In conclusione, da quanto si è detto, si comprende quanto apparentemente siano vicine mistica e filosofia, benché, in realtà, il loro rapporto necessiti più che mai, di chiarificazione. E far comprendere il rapporto tra mistica e filosofia, è anche l’obiettivo del lavoro di Marco Vannini.
Capitolo 1
Per una storia della mistica
1.1) L'antichità
"La parola “mistica” rivendica una parentela almeno etimologica con “mistero”: si è pensato spesso, infatti, alla mistica come a un qualcosa di esoterico, di intimamente connesso con le religioni misteriche.
Ora, è vero che i grandi mistici greci, da Eraclito a Platone e Plotino, hanno utilizzato un linguaggio misterico, ma, come vedremo, in un’accezione completamente diversa. Nelle religioni misteriche, si agisce su e mediante un meccanismo psicologico: a colui che vive una situazione di sofferenza (più o meno intensa che sia), viene presentato il tormento fisico e la morte di Dio, seguiti dalla sua rinascita/resurrezione, di modo che si creda che il medesimo processo può avvenire per l’uomo, specie se egli partecipa al mistero del Dio sofferente.
Tuttavia, non è nel mondo dei misteri che si deve cercare l’origine della mistica in Grecia, bensì nel mondo omerico.
1.1.1) L’Iliade: la forza e il suo dominio
Dobbiamo ringraziare una grande mistica contemporanea, Simone Weil, se è stato messo in evidenza come l’Iliade, poema omerico assai noto, fosse veramente conosciuto nel suo significato spirituale solamente da pochi.
Al centro della riflessione omerica stanno la misura, il limite, l’equilibrio, concetti che noi, ai nostri giorni, sempre più difficilmente siamo in grado di riportare all’uomo, alla sua anima e alla sua vita. I concetti sopra indicati sussistono tuttavia in Oriente, sotto il nome di karma.
Ad ogni modo, proprio il castigo che, con singolare rigore, punisce inevitabilmente l’abuso della forza, fu il primo oggetto della meditazione greca. La hybris, la tracotanza, è per essi, sin dall’Iliade, il peccato per eccellenza.
Nondimeno, solo l’anima che ha piena esperienza del dominio della forza è in grado, seppur per pochi istanti, di risvegliarsi, ritrovando se stessa: non c’è dunque posto per altri sentimenti se non il coraggio e l’amore.
Unica differenza: la sventura dei nemici viene sentita più dolorosamente.
Chi ignora fino a che punto la (volubile) fortuna e la necessità avvincono ogni anima umana alla loro mercé non può considerare suoi simili né amare come se stesso quelli che il caso ha separato dalui. Le diverse costrizioni che pesano sugli uomini possono far nascere l’illusione che, tra di loro, vi siano specie distinte, specie particolari, senza nulla in comune.
Come è dunque possibile, si chiede Vannini[1], amare ed essere giusti se non si è consapevoli dell’influenza della forza?
L’uomo che non si affida alla menzogna e alla corruzione non può patire la forza senza esserne colpito fino all’anima; e la grazia può impedire che questo colpo lo corrompa, ma non può impedire la ferita e il dolore.
Il riconoscimento del dominio della forza è, altresì, il riconoscimento che qualcosa sfugge alla forza: nell’Iliade è implicita la scoperta di un qualcosa, connesso all’anima, che non cede al peso della necessità, proprio perché è in grado, mediante uno scarto, di guardare in faccia questa forza, riconoscendola ma non adorandola.
Anche gli dèi, in Omero, sono sottomessi a questa forza: al poeta greco è dunque palese che, al disopra degli dèi, antropomorfici, vi è una divinitas del tutto i mpersonale, non pensata secondo la limitatezza dell’uomo (anti-mistica); è implicita, nell’Iliade, secondo Vannini[2], l’idea di una bontà del Tutto.
1.1.2) Eraclito: lo scopritore del logos
Ciò è manifesto anche in Eraclito, prima grande figura della mistica.
Eraclito è, afferma Vannini[3], anzitutto lo scopritore del logos, la cui superiore verità (forse per primo) contrappone all’esperienza sensibile, mutevole e superficiale, dunque non affidabile. Il termine greco logos significa “discorso”, “pensiero”, ma in Eraclito assume il significato di “ragione” sia nel senso di motivo profondo per cui un qualcosa avviene, che nel senso di facoltà di comprensione umana.
La ragione, infatti, comprende ciò che i sensi non possono capire e, in particolare, comprende che, attraverso la conflittualità del divenire, ciò che si profila è una realtà profondamente unitaria, benché apparentemente in contrasto nei suoi opposti.
Necessario è, dunque, liberarsi dai condizionamenti, per non esser preda dell’opinione.
1.1.3) Platone: amore, anima e morte mistica
Un filo conduttore lega Platone a Eraclito: sappiamo infatti che il filosofo ateniese fu in gioventù discepolo dell’eracliteo Cratilo, prima di incontrare Socrate.
Ma, a ben vedere, non sarebbe sbagliato pensare a Platone come a un vaso di raccolta della religiosità antica, anche pre-ellenica ed extra-ellenica.
Ad ogni modo, senza Platone, afferma Vannini[4], la Filosofia e la Mistica occidentali non sussisterebbero, come vedremo: basti pensare alla concezione dell’Amore, del Bello e, nondimeno, dell’Anima.
Troviamo altresì in Platone, rimarcato da Vannini[5], il grande tema mistico della morte, vista anzitutto come separazione dell’anima dal corpo, raccoglimento, un abitare dell’anima sola con se stessa.
1.1.4) Aristotele: l’intelletto attivo
Troviamo in Aristotele, per Vannini[6], alcuni punti fondamentali nella storia della Mistica, anche cristiana, ancor più significativi proprio perché presenti in uno spirito spiccatamente scientifico.
Il primo ed essenziale è la concezione dell’intelletto attivo, presente nel De anima.
Trattando dell’anima e delle sue funzioni, ad Aristotele appare palese che l’anima non riceve né produce sensazione o affezione alcuna senza il corpo e, se il pensare è una sorta di immaginazione, neppure esso può darsi senza il corpo: nulla sfugge la condizionamento del mondo sensibile.
A questo punto, però, il filosofo afferma che esiste, nell’uomo, anche un intelletto che non è mescolato al corpo. Vi sarebbe dunque, chiosa Vannini, «un intelletto analogo alla materia, che diviene tutte le cose e da esse dipende, ma c’è anche un altro intelletto che produce tutte le cose. [...] Tale intelletto “ è separato, non mescolato, impassivo, per sua essenza atto»[7].
Nella Metafisica si precisa che esiste, necessariamente, un essere che è causa prima incausata, principio del divenire, identico al Bene, che è veramente principio di tutte le cose; tutti i contrari hanno materia, mentre nel Primo Essere non vi è materia, pertanto non vi è contrarietà alcuna.
Tale Essere è intelletto puro, pensiero di pensiero, sempre in atto e dunque suprema felicità.
Il Dio di Aristotele, lungi da qualsiasi mitologia, è contemplazione pura, pensato da un’intelligenza umana totalmente distaccata e nobile.
Dal Libro IV dell’Etica Nicomachea, parlando della megalopsychìa (la “grandezza dell’anima”), ossia delle caratteristiche dell’uomo nobile, apprendiamo che l’uomo dall’anima grande è un uomo del distacco.
1.1.5) Neoplatonismo: ultima sintesi del pensiero classico
Il compimento della filosofia e della mistica elleniche avviene nell’era ormai cristiana, quando confluiscono nell’alveo della grande tradizione platonico-aristotelica le diverse componenti di pensiero sviluppatesi nel corso dei secoli: anzitutto lo stoicismo, ma anche le culture del Vicino Oriente, compresa, naturalmente, quella biblica.
E il neoplatonismo va considerato come ultima grande sintesi del pensiero classico.
Presentiamo alcune figure basilari di questa sintesi.
1.1.5.1) Plotino: l’estasi
In un’epoca di grave crisi, nella quale era profondo il bisogno di salvezza, Plotino, scrive Vannini, «tiene fermo il primato del logos e offre, con la sua filosofia, un itinerario di “salvezza razionale” veramente universale»[8].
Proprio a questo bisogno di salvezza risponde l’esigenza primaria del pensiero, ossia trovare l’Uno. L’Uno è ciò che noi, con termini moderni, chiameremmo Assoluto, alla base dell’essere. Smarrita nel divenire e nel molteplice, l’anima non può trovare la pace se non ritorna all’Uno.
Il cammino verso la verità presuppone, anzitutto, la purificazione dalle passioni: necessaria è dunque la virtù, in particolare la temperanza (sophrosyne), con la quale si diviene padroni di se stessi.
Inoltre, per liberarsi dal condizionamento in cui lo psichico è inserito a causa delle contingenze che lo determinano, è necessaria una radicale ascesi. Nel suo significato etimologico di “esercizio”, spiega Vannini, «non va intesa tanto nel senso cristiano di penitenza, rinuncia, macerazione, quanto in quello platonico classico di “ esercitarsi a morire”[...] : un gesto cioè più radicale e razionale di distacco»[9].
Se si vuole cogliere l’Uno, occorre andare oltre il pensiero-essere, escludendo ogni dualità. L’Uno, inoltre, non ha alcuna caratteristica antropomorfica, ma può anzi essere indicato come Nulla, nel senso che è al di là di qualunque essere, ma, al contempo, proprio perché sta a fondamento dell’essere, può essere inteso come Tutto.
L’Uno, in Plotino, è dunque Dio (ma non un Dio personale, fa notare Vannini[10]) e il filosofo assimila l’unità al “diventare Dio”, parlando di “uguaglianza con Dio”.
Le tre ipostasi sono distinte ma non separate, poiché tutto è legato da un’armonica gradualità e da un armonico procedere.
Ma come tornare all’Uno?
Tre sono le vie, per Plotino: l’arte, l’amore e la dialettica.
L’amore, nel senso indicato dal Convito platonico, come ricerca del Bello a partire dal sensibile, costituisce una via del ritorno all’Uno: occorre che l’amore, come l’arte, sia sempre diretto dalla ragione, onde evitare la caduta nel molteplice, nell’errore, nelle credenze irrazionali.
Da questo punto di vista, è chiaro, commenta Vannini[11], che la dialettica costituisce la strada preferenziale per il ritorno all’Uno: essa è la capacità di riconoscere e discernere le idee e il loro rapporto e di distinguere i vari piani ipostatici, nonché di cogliere l’essenza nella sua unità. Attraverso la dialettica, l’anima può sciogliere i legami che la avvincono alla materialità, per elevarsi alla contemplazione dell’Essere.
1.1.5.2) Porfirio
Porfirio, nato in Siria verso il 233, venuto a contatto col cristianesimo e discepolo di Plotino, si impegnerà a fondo in difesa del lògos.
Il lògos ci insegna, come scrive, che il divino è presente ovunque e totalmente e che il suo tempio è il pensiero, specie il pensiero del saggio.
Si onora Dio conoscendolo, nella saggezza: il noùs è il vero naòs (tempio) di Dio; di più, non è possibile onorare e amare Dio con il pensiero delle cose materiali: è empio, perciò, chiedere favori e aiuti materiali a Dio nella preghiera.
Coloro che pensano di onorare Dio dimenticando la virtù, lo ingiuriano: una fede senza ragione è mera ignoranza ed empietà.
Alle tre virtù divine (Fede, Speranza, Carità), il filosofo aggiunge la Verità, senza la quale la fede diviene superstizione. Ad ogni modo, il primo posto spetta alla fede, senza la quale non vi è conversione.
Solo volgendosi verso il profondo di noi stessi possiamo salvarci, ma questo volgersi presuppone la saggezza e il distacco da ogni legame materiale, dall’alienazione, da ogni irrazionalismo, commenta Vannini[12].
1.1.5.3) Proclo
Dal canto suo Proclo (nato a Costantinopoli nel 412) teorizza con maggiore precisione la presenza, nell’uomo, accanto alle facoltà razionali, di una facoltà che è superiore al pensiero, in grado di immedesimarsi nell’Uno, di cui è presente in noi una traccia.
Anche per Proclo, per raggiungere l’Uno occorre seguire un cammino di distacco, guidato dalla ragione.
Il contributo più importante di Proclo alla storia della mistica e della filosofia, per Vannini[13], è dato dalla sua soluzione al problema del rapporto Uno-molti: come è possibile che, se tutto è Uno, vi sia la molteplicità? Come si concilia l’immobilità dell’Uno (immobilità dovuta alla perfezione) col movimento che è nelle cose, nel cosmo?
Tutto, per Proclo, è sempre in atto nell’Uno, ma con un ritmo circolare, scandito dialetticamente in modo ternario, come monè (permanenza degli esseri nell’Uno), pròodos (uscita da sé, oggettivazione, processione), epistrophè (conversione a sé, ritorno).
1.1.5.4) Filone di Alessandria
In Alessandria operò l’ebreo ellenizzato Filone (25 a.C. - 42 d.C.), il quale ben comprese che molte parti della Bibbia non possono reggere ad un esame critico, e si servì di interpretazioni simboliche e allegoriche per superare le difficoltà e incongruenze della Scrittura, prima fra tutte, l’ingenua antropomorfizzazione di Dio.
Il principale sforzo di Filone fu quello di produrre una mediazione tra la concezione biblica e la cultura greca.
Di particolare importanza, a tal fine, sottolinea Vannini[14], è la ripresa del lògos, interpretato però come Parola e Sapienza divine che discendono dal cielo sulla terra: a guisa di intermediario tra Dio e l’uomo, il lògos diviene creatore e reggitore del cosmo, avvicinando così la Bibbia al Timeo platonico.
La vita di Filone di Alessandria si svolge più o meno negli stessi anni in cui si consuma la vicenda umana di Gesù di Nazareth.
1.1.6) Paolo di Tarso
Paolo di Tarso è il primo importante autore cristiano che, pochi decenni dopo la morte di Gesù, scrive dei testi che contengono una sintesi teologico-mistica fondamentale per l’intera storia del cristianesimo.
Nell’Anticristo, ricorda Vannini[15], Nietzsche polemizza con particolare veemenza contro Paolo, giudicandolo il primo vero negatore del messaggio di Gesù. Nello specifico, Nietzsche prende di mira la gnosi paolina, così come è esposta nella Lettera ai Romani: il peccato di Adamo colpisce tutti gli uomini, che sono incapaci di giustizia, nonostante la Legge data a Mosè. Ma Cristo è morto per noi, espiando il peccato di Adamo e aprendo all’uomo la possibilità di una giustificazione attraverso la fede in Cristo stesso.
Questo mito deve la sua fortuna al fatto che, in certo qual modo, spiega la cosa più incomprensibiledi tutte per i suoi seguaci: la morte di Gesù Cristo.
La fede in Cristo diviene elemento di pretesa di valore, di affermatività del soggetto e della comunità che nel frattempo si costituisce: in Paolo è infatti determinante la componente clericale. Sembra dunque che la costruzione paolina sia veramente il prodotto di una singolare volontà di autoaffermazione, che avviene nel rovesciamento di tutti i valori.
Ma in Paolo è presente anche un’altra componente, che interessa maggiormente Vannini[16]: l’imitazione di Cristo.
La figura di Gesù, infatti, non è solo inserita in un mito salvifico, ma viene anche proposta come modello di trasformazione spirituale. Il rifugiarsi nel Salvatore implica la fine dell’uomo vecchio, dell’uomo carnale, e l’assunzione della forma dell’uomo nuovo, spirituale.
La possibilità di ripetere il percorso interiore di Cristo pone fine ad ogni alienazione religiosa, afferma Vannini[17].
Particolarmente rilevante è l’utilizzazione paolina del concetto di pnèuma, “spirito”, ripreso dal pensiero greco del tempo, soprattutto dallo stoicismo. Componente essenziale dell’uomo, lo spirito è anche e soprattutto l’elemento divino presente nell’uomo stesso, ed è ciò che rende possibile la koinonìa, l’“unione” con Cristo.
1.1.7) Vangelo di Giovanni: Lògos
Il Vangelo di Giovanni si costruisce sull’opposizione luce-tenebre.
In Giovanni la luce è incarnata in Cristo, visto non tanto come una realtà cosmico ontologica, ma come un soggetto; e, cosa ancor più importante, si afferma che ciò che vale per Cristo vale anche per il cristiano.
Primo punto su cui si sofferma Vannini[18] è l’autonomia, la libertà, che il quarto Vangelo presenta come costitutiva del cristiano. Come può esservi unione con Dio se vi è subordinazione a questa o a quell’autorità?
L’evangelista è molto chiaro: i discepoli di Gesù sono suoi amici, non suoi servi, che compiranno opere uguali, anzi, maggiori di quelli da Lui compiute.
Giovanni mette in bocca a Cristo parole di straordinario valore spirituale: fa infatti congedare Gesù dai suoi discepoli dicendo che è bene che se ne vada, perché, se non se ne andasse, non potrebbe giungere a loro lo Spirito , quello Spirito che li condurrà alla verità.
Che significa? Come commenta Vannini, «bisogna che i discepoli divengano autonomi, non trovino più conforto e sostegno nel Maestro, se devono diventare uomini spirituali»[19].
Giovanni, su questa linea, polemizza contro il miracolismo e contro certa fede che pretende di alimentarsi con i miracoli, o presunti tali.
Il punto centrale è l’incontro di Gesù con la Samaritana, nel quarto capitolo; Gesù spiega alla donna che è venuto il tempo di adorare Dio non nel tempio, ma spiritualmente: viene negata, spiega Vannini, «ogni appropriazione psicologica ed eliminata ogni religio, che dell’appropriazione psicologica è lo strumento più forte»[20].
Proprio nel terzo capitolo, il colloquio con Nicodemo, Gesù ha enunciato la condizione per entrare nel regno di Dio: rinascere nello spirito e dallo spirito. Ma per rinascere, occorre prima una morte, un morire alla carne, allo psichico, se si vuole che il granello di frumento (lo spirito) germogli.
Fondamentale per la mistica cristiana, afferma Vannini[21], è il legame, ben presente in Giovanni, tra il conoscere ed essere generato: si conosce ciò che si genera nell’anima, e tutte le altre pretese di conoscenza sono vane esteriorità. Il cristiano conosce Dio perché in lui si genera il Logos, lo spirito, che è Dio stesso, e si genera nell’amore, ossia in quanto il cristiano stesso ama, in risposta all’amore di Dio che per primo ha amato noi.
Unità con Dio nell’amore-spirito: questo è il grande lascito che Giovanni fa alla Mistica cristiana. Nel Vangelo di Giovanni, l’unità uomo-Dio nell’amore-spirito si concretizza, per Vannini[22], nella morte a tutto ciò che è appropriativo e affermativo di sé e del sociale (dominato, secondo il pensiero giovanneo, dal demonio). Generazione di Dio nell’anima umana, e non conoscenza di Dio, e neppure unione con Dio (formula ambigua, che rischia di annullare la differenza specifica tra uomo e Dio, sottolinea Vannini[23]): ciò conduce alla concezione di Dio come spirito, giacché Dio può generarSi nell’anima come spirito.
1.1.8) Origene: conversione e ritorno in se stesso
Dopo gli scritti canonici, non c’è dubbio che la prima voce della Mistica cristiana sia quella di Origene.
Importante filologo ed erudito, Origene fu anzitutto un esegeta della Scrittura. Come tale, è principale responsabile di quell’allegorismo che è fondamentale anche per la Mistica, poiché permette di superare, almeno parzialmente, le difficoltà che derivano da una interpretazione letterale, che conduce ad un antropomorfismo superstizioso, nonché a conclusioni assurde.
La prima tappa dell’itinerario spirituale è, per Origene, la conversione, ossia il ritorno dell’uomo in se stesso.
La seconda tappa è simboleggiata dall’Esodo: l’uscita dalla schiavitù d’Egitto e l’ingresso nella Terra Promessa, ossia l’uscita dalla schiavitù del peccato e della concupiscenza.
L’itinerario si compie, con altre tappe successive, non attraverso sporadiche “visioni”, ma nella conoscenza, una conoscenza, però, non intrinseca, ma trasformante, che introduce in quelle realtà di cui è conoscenza, ossia le cose divine ed umane.
Estremamente importante nella storia della Mistica, secondo Vannini[24], è anche il Commento al Cantico dei Cantici di Origene.
Il Cantico esprime la terza via ed è il poema dell’amore spirituale.
Origene fa riferimento ancora una volta al Convito platonico. Il testo platonico è letto da Origene, rileva Vannini, «in sintonia con quello biblico, giacché egli interpreta il Cantico come poema dell’anima che desidera unirsi al Logos, penetrando nei misteri della sua sapienza come nella camera nuziale di uno sposo celeste»[25].
Fondamentale, è anche il fatto che Origene presenti la vita mistica come una conoscenza sperimentale della realtà divina, dando inizio alla teoria dei sensi spirituali.
I sensi spirituali, spiega Vannini, «sono la manifestazione dell’uomo interiore e sono risvegliati nell’anima dal Logos. Corrispondono a esperienze spirituali diverse, che hanno per oggetto il Logos presente nell’anima; sono perciò legati alla perfezione della vita spirituale e al parallelo deperimento dall’uomo esteriore e della sua vita carnale»[26].
1.1.9) Gregorio di Nissa: epèktasis
Indicato convenzionalmente come “padre della Mistica cristiana”, Gregorio di Nissa nacque verso il 335 in Asia minore da una famiglia già profondamente cristiana.
Il tema centrale della spiritualità di Gregorio, ossia quello della epèktasis (l’essere sempre “oltre”, sempre “al di là” di quanto è possibile conseguire, per cui l’anima deve sempre andare avanti, con inizi sempre nuovi, che non hanno mai fine), rimanda, come rileva Vannini[27], alla speculazione di Paolo di Tarso, specialmente in Fil 3,13 («Io dimentico quel che è dietro di me, e, tendendo a ciò che è davanti a me, cerco il fine»), ma rimanda ancor più al fondamentale concetto platonico per cui il Bene è sempre “al di là” (epèkeina) di ciò che è.
Gregorio, inoltre, utilizza a fondo l’idea platonica della synghèneia (“parentela”) tra uomo e Dio, per la quale Dio attira a sé l’anima. In virtù di tale parentela, l’anima umana è sin dall’inizio tendente a Dio, al Bene, che costituisce la sua vera natura.
Cruciale è, nel pensiero del Nisseno, come spiega Vannini[28], la distinzione tra l’essenza di Dio e le sue “energie”, quali la sua giustizia, pace, provvidenza e bontà. Inconoscibile la prima, poiché infinita e al di là dei limiti della conoscenza umana, sperimentabili le seconde, che rappresentano una forma di comunicazione tra la trascendenza divina e le facoltà umane.
Come nel Convito platonico, in Gregorio la conoscenza di Dio non si raggiunge sul piano meramente teoretico, osserva Vannini[29], ma c’è bisogno dell’amore, il quale si muove seguendo il cammino della bellezza – l’amore del Bene è quindi un amore del Bello (philokalìa), che del Bene è la manifestazione sensibile e che attira a sé. Dal momento che, in senso platonico, il simile si conosce con il simile, noi, nella nostra anima, diveniamo affini a ciò cui il nostro amore si rivolge, sia che ci si rivolga al Bene, sia che ci si rivolga al male.
1.1.10) Pseudo-Dionigi: Teologia mistica
La figura più importante nella storia della Mistica neoplatonico-cristiana è l’anonimo autore del Corpus dionysianum. Verso la fine del V secolo o agli inizi del VI, uno scrittore di lingua greca, compose 4 trattati e 10 lettere, fingendo che fossero stati redatti da Dionigi, convertito da Paolo di Tarso col suo discorso all’Areopago di Atene, ritenuto il primo vescovo della città greca.
L’importanza eccezionale che lo Pseudo-Dionigi riveste nella storia della Mistica è legata al quarto trattato, la Teologia mistica.
La via negativa, o apofatica, raggiunge ivi il suo culmine: l’autore intende condurre al di là della luce, al di là del sapere e, persino, al di là della non-conoscenza. Solo mediante il distacco da se stessi e da ogni presunta conoscenza, è possibile essere elevati alla tenebra divina.Ora, quanto sia veramente cristiano questo contesto è oggi oggetto di discussione, fa notare Vannini[30]. In realtà, nella Teologia mistica, spiega Vannini[31], Cristo non ha alcun ruolo, e non se ne sente affatto il bisogno: viceversa, è ovvio che ogni mediazione va eliminata da questo cammino di ascesa radicalmente negatore, un cammino di unione a un qualcosa che non si può neppure chiamare Uno. Nello Pseudo-Dionigi manca il concetto giovanneo della generazione del Logos nell’anima: il contrasto tra cristianesimo e neoplatonismo si fa insanabile.
1.1.11) Agostino di Ippona: conversione
Agostino venne educato cristianamente dalla madre Monica, e questa educazione produrrà i suoi frutti, anche se non nell’adolescenza, tenuto conto anche dell’importanza che ha avuto, per Agostino, la cultura classica.
Veramente importante è invece l’incontro di Agostino con lo scetticismo, allora molto diffuso nell’ambiente dell’Accademia: il ruolo che ebbe lo scetticismo nel maturo Agostino fu connesso al distacco dai dogmi, ma non dalle passioni, non dall’ambizione, non dalla volontà, tutte cose che lo scetticismo non può dare: Agostino si trovò perciò lacerato, animato da una spiccata volontà di auto-affermazione, ma senza una verità cui fare riferimento.
Fu l’incontro con le traduzioni latine di Plotino, scrive Vannini[32], a determinare la svolta essenziale nel pensiero di Agostino.
Agostino fu senza dubbio un cristiano, scrive Vannini, «poiché trovò, o meglio, ritrovò nel cristianesimo della sua fanciullezza qualcosa che i platonici non potevano e non volevano dargli: la salvezza dell’ego, la garanzia dell’affermatività personale»[33].
Il filo conduttore della ricerca è, platonicamente, la bellezza e l’armonia.
La bellezza stessa assurge a criterio di verità, poiché, in virtù della bellezza, scrive Vannini, «si approvano o disapprovano le rappresentazioni»[34]. Si rientra in se stessi per cercare la suprema armonia e, data la mutevolezza della nostra natura, è necessario andare oltre noi stessi, verso la fonte della luce della ragione. Venendo al punto, è necessario che l’uomo interiore si conformi al suo ospite interno, ossia lo Spirito di Dio.
La luce della verità è Dio stesso e l’intelligenza stessa, pertanto, è la verità, e il lògos che si manifesta nell’uomo è il lògos divino: così si supereranno tutte le ingenue rappresentazioni di Dio.
Illuminante è il rapporto con la Scrittura: Agostino platonico non dipende dal testo sacro o dall’autorità della Chiesa: per lui, Scrittura e autorità hanno valore pedagogico e disciplinare, ma non danno luce e verità. I libri, infatti, di per sé non possono dare la conversione, che solo la luce dell’uomo interiore può dare, una volta sottomesse carne e anima.
Un accenno particolare meritano, per Vannini[35], alcune pagine del De trinitate, la maggiore opera teologica di Agostino, specie laddove si tratta del concetto teologico di Spirito e del suo rapporto col Padre e il Figlio.
Le verità eterne, chiosa Vannini, «possono esser comprese [...] solo nella dimensione eterna dell’anima umana, giacché nell’uomo v’è, al di là dei sensi e delle diverse facoltà dell’anima, uno “spirito” [...] che è capace di razionalità pura e, quindi, di comprensione delle realtà eterne intelligibili»[36]. Ora, questo spiritus agisce solo quando tacciono i legami con gli esseri carnali inferiori e l’anima intera, così purificata, può volgersi al bene.
Lo spirito che ha generato il verbum , il pensiero che ha trovato se stesso come assoluto hanno oramai ciò che cercavano, ciò che amavano e proprio in questa conoscenza c’è amore. Si ha così un terzo termine: l’amore che unisce lo spirito al suo verbum, il pensante al pensato. Anche l’amore costituisce una trinità, formata da amante, amato e amore stesso che li unisce.
1.2) Il medioevo
1.2.1) Gregorio Magno: raccoglimento e contemplazione
Per quanto riguarda la storia della Mistica, due scritti di Gregorio Magno sono particolarmente importanti: il Commento morale a Giobbe (Moralia in Job) e le Omelie su Ezechiele.
Primaria è, per Gregorio, la purgatio, la purificazione morale:solo quando lo spirito si è purificato da ogni desiderio di gloria terrena e da ogni concupiscenza può elevarsi alla contemplazione.
Agostinianamente e platonicamente, però, è l’amore a costituire l’anima della contemplazione stessa: «L’amore si esercita, ancora in termini platonici, nel non-amore, ovvero nel distacco dagli oggetti sensibili, dai beni finiti e nel rivolgersi verso il Bene in sé. Tale rivolgersi è, agostinianamente, un atto prima di raccoglimento e poi di introversione, ovvero un atto con cui la mente guarda nel proprio intimo, ormai priva di ogni immagine esteriore. Solo il terzo momento è quello della contemplazione vera e propria, ovvero un elevarsi al di sopra di sé, abbandonandosi alla contemplazione del Creatore invisibile»[37].
Egli concepisce Dio come Luce infinita, senza determinazioni né limitazioni, e dunque la contemplazione è un fissare l’occhio dell’anima su questa Luce senza confini.
1.2.2) Ugo e Riccardo di San Vittore: ascesa graduale dell’anima a Dio
Dopo il lungo silenzio dell’Alto Medioevo, nel XII secolo si assiste a un’impetuosa ripresa della riflessione sulla mistica o semplicemente della letteratura mistica.
Con i maestri Ugo e Riccardo di San Vittore, si riprende per lo più uno schema gradualistico di stampo agostiniano, per delineare l’ascesa dell’anima a Dio.
Ugo parla, ad esempio, di tre occhi, nell’anima: uno per vedere il mondo esterno, uno per vedere se stessa, e infine un occhio per vedere Dio all’interno di se stessa e le cose che sono in Dio. Anche il terzo occhio non appare però come qualcosa di soprannaturale o sovra-razionale, bensì come qualcosa che appartiene allo spirito umano, sulla scia della tradizione agostiniana. Tuttavia, già in Riccardo, pur proseguendo lo schema gradualistico della continuità dell’ascesa, la conoscenza mistica appare palesemente come mentis excessus (“estasi dello spirito”), raptus (“rapimento”), abalienatio (“separazione”), vale a dire come un modo di conoscere inesprimibile a parole e non comprensibile concettualmente. Riccardo non vede però in questa forma di conoscenza qualcosa di per sé differente da ciò che opera anche nella conoscenza razionale.
Il pieno compimento della conoscenza mistica si raggiunge, spiega Vannini[38], con l’amore, ma questo avviene non perché l’amore sia un’altra via per giungere a Dio diversa dalla conoscenza, bensì solamente perché la perfetta conoscenza si tramuta spontaneamente in amore per Dio, elevando così l’anima a Lui.
Riccardo, nondimeno, è importante perché, scrive Vannini, «con un gusto sistematico che già preannuncia l’incipiente Scolastica, aggiunge alla tripartizione delle sfere di conoscenza che abbiamo già visto in Ugo una parallela tripartizione delle facoltà corrispondenti […]: imaginatio, ratio, intellectus»[39].
1.2.3) Guglielmo di Saint-Thierry: le tre condizioni dell’uomo
Secondo Guglielmo di Saint-Thierry, altro nome della mistica alto-medievale, lo status animalis è la condizione nella quale l’uomo è capace di conoscere solo le cose sensibili e corporee e, dunque, di concepire un’immagine di Dio unicamente in senso corporeo. Ciò non toglie, precisa Vannini[40], che la volontà possa essere buona e che, dunque, qui sia già in azione lo Spirito Santo. Infatti, anche nella condizione animalis può esservi semplicitas, ossia una volontà tutta rivolta verso Dio.
Nella condizione rationalis, poi, si conoscono spiritualmente l’essenza di Dio e la natura dell’anima, i precetti etici e le dottrine della fede, ma essi ancora non fanno parte dell’intera natura dell’uomo restando in conflitto con la sua sensibilità. Solamente quando lo Spirito Santo inizia ad operare nell’uomo, lo status rationalis cede spontaneamente il posto allo status spiritualis. In quest’ultimo, la volontà umana si conforma sempre più all’amore dello Spirito Santo: ora è la volontà di Dio stesso che agisce nell’uomo. Su questo piano supremo, la conoscenza derivante dalla grazia dello Spirito Santo è un’esperienza interiore dello spirito e non più solo pensiero.
L’esperienza mistica, osserva Vannini[41], comincia a essere caratterizzata come espressione di una specifica facoltà affettiva per conoscere Dio, distinta dalla ragione.
1.2.4) Bernardo di Chiaravalle: amore e contemplazione
In Bernardo di Chiaravalle (1090-1153) troviamo, almeno in germe, tutti gli elementi essenziali della posteriore storia della mistica.
In primo luogo, dobbiamo a Bernardo la devozione all’umanità di Gesù Cristo e alla Vergine Maria. In particolare, dell’umanità di Cristo, ciò che a lui più interessa è la Passione, la quale diviene oggetto di meditazione e di amore per il mistico cistercense; tale amore viene descritto con terminologia propria dell’amore umano.
Commentando il Cantico, l’abate di Chiaravalle ha cura di specificare, e Vannini lo ribadisce[42], che questo amore, che culmina nel matrimonio dell’anima con Cristo, non ha nulla a che vedere con quello carnale.
Non bisogna pensare, precisa Vannini[43], che il tema del matrimonio spirituale, in Bernardo, abbia un carattere panteistico: l’unione cui egli allude non è un’unione di nature (umana e divina), che restano divise, ma l’incontro di due volontà.
Bernardo, nella fattispecie, parla di due tipi di contemplazione, quella intellettuale e quella affettiva. La prima è una contemplazione della mente sulle cose divine, e ha la caratteristica della chiarezza; è tuttavia la seconda, affettiva, che occupa un posto di rilievo, tanto da poter essere considerata la vera esperienza mistica.
È nello spogliamento da tutto, e da tutte le immagini (precisa Bernardo), che consiste la vera contemplazione e la vera estasi.
La via amoris è la via della fruizione, che ha bisogno dell’oggetto amato e dei suoi doni. L’amore, dunque, cerca un qualcosa, cerca i doni di Dio, mentre la conoscenza, al contrario, non cerca nulla. Bernardo, perché legato alla volontà e, attraverso di essa, al sensibile, spiega Vannini, «dovette privilegiare l’amore/volontà e perciò andare verso la figura di Cristo»[44], in special modo verso la sua Passione, poiché la prima e fondamentale soddisfazione di chi è nel dolore è pensarlo come forma di elevazione assoluta, in virtù di quel meccanismo psicologico per il quale è di conforto a chi soffre il sentirsi partecipe della Passione di Cristo.
1.2.5) Tommaso Gallo: principalis affectio
Il progressivo spostamento della Mistica cristiana verso l’affettività dopo Bernardo, con la (conseguente) valorizzazione della volontà/amore come centro ed essenza dell’anima, appare evidente in Tommaso Gallo, abate di Sant’Andrea a Vercelli, e prima canonico di San Vittore a Parigi, morto nel 1246.
Il carattere affettivo della conoscenza mistica viene da lui affermato chiaramente, in concomitanza col carattere soprannaturale del supremo piano raggiunto dall’anima nella sua ascesa a Dio. Fondamentale sottolineare come la valorizzazione del sentimento (fruizione psicologica, per essere precisi) va di pari passo con l’affermazione del suo carattere soprannaturale.
Gallo, poi, rileva Vannini, «muta profondamente quello schema dell’ascesa graduale che abbiamo incontrato in Riccardo di San Vittore. Al di sopra della imaginatio e della ratio non si trova più il solo intellectus, ritenuto ormai incapace di conoscenza mistica, ma anche la principalis affectio (o affectus) o scintilla synderesis»[]45.
1.2.6) Ugo di Balma: separazione della “facoltà mistica” e del “luogo mistico”
La completa separazione della “facoltà mistica” e del “luogo mistico” dal tradizionale schema dell’ascesa si incontra, scrive Vannini[46], in Ugo di Balma, priore, tra il 1289 e il 1304, della certosa di Meyr, presso Lione. Nel trattato De triplici via o Theologia mystica, Ugo mostra le tre vie che conducono alla più alta sapienza: la via della purificazione, la via dell’illuminazione (caratterizzata da orazioni colme di desiderio) e la via dell’unione (che conduce ad un sapere divino fondato sull’amore, al di fuori della ragione).
1.2.7) Francesco d'Assisi e il Francescanesimo
La vita e l’esperienza di Francesco d’Assisi, su cui Vannini sceglie[47] di non soffermarsi più di tanto, è certamente uno dei fatti più straordinari della nostra storia.
Nell’ambito femminile, il suo corrispettivo è l’altrettanto nota figura di Caterina da Siena (1347-1380), che, benché non appartenente all’ordine francescano, si situa nella sua forma di vita e di santità, anche se in lei entrano le concezioni più forti dell’esperienza domenicana.
Per capire la posizione dell’autore riguardo al Francescanesimo, è bene rifarsi a quanto scrive: «Per quanto concerne però in modo specifico l’oggetto del nostro studio, bisogna precisare che la “mistica francescana”, dai suoi inizi fino ai giorni nostri, non rappresenta nulla di nuovo rispetto a quanto già presente, almeno implicitamente, in Bernardo. Già l’abate di Chiaravalle, infatti, aveva meditato sulla vita di Gesù come vita di sofferenza, dall’infanzia alla morte sulla croce, e aveva puntato proprio sulla Passione, sul Cristo crocifisso, come centro della sua spiritualità.
Il francescanesimo non fa altro che divulgare, nel senso specifico di rendere popolare, a tutti ilivelli, questo tratto bernardiano, insistendo sul lato affettivo, devozionale, rappresentativo: dal Gesù bambino del presepio alla cinque piaghe di Cristo in croce. Tutto ciò ha avuto un’enorme importanza proprio perché andava (e continua ad andare) incontro ai bisogni psicologici, emozionali nonché alle possibilità intellettuali del popolo, e ha perciò dato vita a una lunga serie di santi, nei quali si sono presentati non di rado fenomeni eccezionali (visioni, estasi, stimmate, ecc.), costituendo così uno dei capitoli più interessanti della storia del cristianesimo; tuttavia non riveste molta importanza per la storia della mistica»[48].
1.2.8) Margherita Porete: Lo Specchio delle anime semplici
La vicenda umana e spirituale di Margherita Porete, nata intorno al 1250-1260 e bruciata come eretica a Parigi nel 1310, si inscrive nell’ambito della Minnemystik, ossia di quella “mistica dell’amor cortese” che fiorì soprattutto nell’Europa centrale e settentrionale nella seconda metà del Duecento.
La riscoperta e soprattutto l’attribuzione dello Specchio delle anime semplici, che approfondiremo successivamente, a Margherita Porete, costituiscono una delle acquisizioni più importanti nella storia della Mistica cristiana.
Nello scritto di Margherita, in cui Amore gioca un ruolo essenziale, non c’è assolutamente, fa notare Vannini[49], alcuna connotazione nuziale, né alcun accenno alla sensualità. Inoltre, dato che in esso il soggetto è l’Anima innamorata, senza alcun riferimento esplicito al femminile, il libro potrebbe tranquillamente essere attribuito anche ad un autore di sesso maschile.
Indifferente a tutto perché distaccata da tutto, l’anima nobile, chiosa Vannini[50], si congeda anche dalle virtù, vale a dire dalla morale come dipendenza, e vive in assoluta pace. Essa non è mai triste, poiché non appartiene a se stessa, non desidera nulla fuori di sé.
La fine della volontà, che è sempre egoistica, significa la fine dell’amore in quanto desiderio, ma se questa fine avviene per traboccante ricchezza dell’amore stesso, l’anima cessa di amare perché diviene essa stessa Amore: si stabilisce così un’identità tra l’Amore, Dio e l’Anima.
Così, l’Anima potrà trovare Dio in tutte le cose.
1.2.9) Jean Gerson: la Teologia Mistica
Uomo di cultura, ma anche di potere (era un cancelliere), Jean Gerson (1363-1429) si trova a metà strada tra Medioevo e Umanesimo.
Nella Teologia mistica, sua opera principale, si cita espressamente l’autore dell’Ornamento dellenozze spirituali, ossia Ruusbroec, che il cancelliere parigino legge alla fine del Trecento quando si trova a Bruges, e di cui continuerà ad occuparsi per tutta la vita. Il perché sembra evidente: mentre è facile condannare gruppi già definiti “ereticali”, la serietà e la cattolicità di Ruusbroec rendevano ben più ardua l’analisi e il giudizio. Gerson riteneva infatti che anche Ruusbroec fosse caduto negli errori dei suddetti movimenti in odor di eresia, vale a dire, in primis, la divinizzazione dell’uomo e il panteismo.
È a questo punto che il discorso gersoniano deve porre limiti al primato dell’amore estatico che divinizza l’anima, facendo necessariamente valere il peso della conoscenza razionale, della distinzione, anche con l’aiuto delle categorie aristotelico-scolastiche.
L’intero percorso delineato nella Teologia mistica del cancelliere parigino, fa notare Vannini[51], prescinde da ogni riferimento cristologico, ma non ci meraviglia più di tanto, se si considera che, come abbiamo detto, nel cammino dell’anima verso Dio, tutte le rappresentazioni devono venir meno.
Comunque, è importante mantenere saldo il lato razionale. Infatti esso è quello che assicura l’universalità della teologia mistica, che Gerson considera, giustamente, compito di ogni cristiano, e non sfera riservata a pochi eletti. Senza la misura universale della ragione, il sentimento può facilmente sfociare nell’arbitrio e nel soggettivismo più sfrenati.
Alla conclusione del Trattato primo, speculativo, Gerson si pronuncia per l’unione dell’amante con l’amato, dell’anima con Dio, avendo solo cura di scartare quelle teorie ed espressioni che possono far pensare a un’unione ontologica.
Nel Trattato secondo, pratico (scritto quattro anni dopo il precedente), troviamo invece una maggiore valorizzazione dell’intellettualismo, anche se sempre su posizioni sostanzialmente concordistiche. Più di quindici anni dopo, infine, nel giugno 1424, scrivendo l’Opuscolo per chiarire scolasticamente la Teologia mistica, che costituisce poi la terza e ultima parte dell’opera, lo spostamento è più consistente: Gerson, citando Ugo di Balma, si chiede se e come sia possibile l’unione dell’anima con Dio senza conoscenza razionale.
Ad ogni modo, commenta Vannini[52], l’opera gersoniana possiede tutti i limiti della sua origine, ovvero la preoccupazione di sistematizzare, l’obbedienza a una logica istituzionale, in virtù della quale Gerson farà condannare Jan Hus al concilio di Costanza (1414-1418).
1.2.10) Ruusbroec: L’ornamento delle nozze spirituali
Uno degli obiettivi polemici di Ruusbroec è Lo specchio delle anime semplici di Margherita Porete, cui Ruusbroec rimprovera l’affermazione che l’anima unita a Dio prende congedo dalle virtù e non ne è più schiava. La polemica contro le eresie mistiche, ad esempio quella dei Fratelli del Libero Spirito, è evidente a partire dal primo scritto ruusbroechiano, Il regno degli amanti (1330-1335 ca.), fino a quel Libro delle dodici beghine, scritto negli anni della vecchiaia, e nel quale si cita, per criticarlo, il sermone eckhartiano Beati pauperes spiritu. Ma è probabile che, alla fine dell’Ornamento delle nozze spirituali, l’obiettivo sia ancora Eckhart, laddove si prendono di mira i Fratelli del Libero Spirito.
L’opera più ampia di Ruusbroec è però Il tabernacolo spirituale, un lungo e denso commentario dei capitoli dell’Esodo che descrivono il tabernacolo.
Ruusbroec, spiega Vannini, «insegna che lo spirito ha un triplice ruolo: in primo luogo vitale, con cui anima il corpo, in secondo luogo intellettuale, che si manifesta nel pensiero; infine un ruolo diattività spirituale superiore, con cui diventa principio di unificazione di tutta la vita interiore, e con il quale costituisce l’essenza stessa dell’anima»[53]. A ciascuno di questi ruoli corrisponde quella che Ruusbroec chiama una “unità”, ossia un punto di convergenza intorno al quale si compie l’unificazione al livello considerato. L’unità del cuore comanda la vita carnale e sensibile, rendendola retta e orientandola a Dio; l’unità della mens accentra e indirizza verso Dio la vita intellettuale; l’unità nell’essenza, infine, si compie in Dio stesso. Alla realizzazione progressiva di ognuna di queste unità corrisponde una tappa del cammino spirituale.
Per Ruusbroec, l’itinerario verso Dio ha tre vie, soltanto l’ultima delle quali, però, costituisce il vero e proprio cammino spirituale.
Vi è, infatti, una via “sensibile”, nella quale ci si avvicina a Dio tramite l’ordine esteriore del mondo.
Vi è poi la via “naturale”, in cui l’uomo pratica le virtù secondo un’intenzione estranea all’influsso dello Spirito Santo e senza doni divini soprannaturali (contemplazione razionale, contro i “falsi mistici”).
La sola autentica via della vita interiore è per lui la terza, “soprannaturale”, nella quale l’anima è mossa dallo Spirito Santo, ovvero dalla carità divina.
La via soprannaturale, a sua volta, si distingue in tre vie, corrispondenti alle tappe del cammino spirituale.La prima è chiamata “attiva”, o “morale”, o “esteriore”, oppure “iniziante”. Si tratta comunque della costruzione dell’unità del cuore, che unifica la vita sensibile, corporea.
Al termine della vita attiva, l’uomo entra in quella “interiore” o “affettiva”, oppure “del desiderio di Dio”. Ruusbroec intende dire, chiosa Vannini[54], che qui la vita spirituale non è più retta da un ordine esteriore, ma dall’azione interiore e dalla presenza di Dio, che l’anima scopre profondamente in se stessa.
Infine, la terza vita, che costituisce l’ultima tappa della via soprannaturale, è chiamata da Ruusbroec “sovraessenziale”, o “divina”, oppure “contemplativa di Dio”. L’ingresso alla vita soprannaturale si compie, ancora una volta, in tre tappe. La prima è di ordine morale, e consiste nell’acquisizione di una sorta di habitus di virtù, tale che nessun elemento psicologico possa ostacolare la vita dello spirito. La seconda è di ordine affettivo e consiste in una costante adesione amorosa a Dio. La terza, infine, è di ordine propriamente contemplativo e si realizza nel perdersi in una indeterminazione senza modi, nella quale l’anima sperimenta un perfetto godimento di Dio ed entra davvero nella vita divina.
1.2.11) Meister Eckhart: distacco
Il caso di Meister Eckhart, su cui, seguendo il percorso di Marco Vannini[55], ci soffermeremo in modo particolare, sia dal punto di vista storico che filosofico, è emblematico del destino della Mistica cristiana quale compimento dell’esperienza religiosa e suo superamento.
Non sappiamo molto sulla vita di Eckhart. Dalle ultime ricerche sembrano certi la sua origine da una famiglia della piccola nobiltà turingia, e il suo luogo di nascita, Tambach, a sud di Gotha. La data si suppone sia verso il 1260, visti i tempi consueti di formazione nell’Ordine domenicano.
Si pensa che Eckhart sia entrato assai giovane nel convento domenicano di Erfurt, in Turingia, e abbia ivi seguito il corso di studi e di formazione consueto: latino, logica, retorica, divinum officium e costituzioni dell’Ordine, filosofia e teologia.
Probabile che Eckhart fosse stato inviato a Colonia, per perfezionare i suoi studi. Un ulteriore periodo di studi a Parigi è stato supposto da qualche studioso, ma resta una pura illazione.
Il secondo dato certo sulla vita di Eckhart è il suo priorato nel convento di Erfurt, che deve aver avuto luogo tra il 1294 e il 1298.
Nel 1303, il capitolo generale domenicano, tenuto a Besançon, divide la grande provincia Teutonia in due, chiamando Saxonia quella del nord. Eckhart fu nominato primo provinciale di quest’ultima, che contava 47 conventi maschili e 9 femminili, in un territorio che andava dal mare del Nord alla Boemia. Sede del provincialato era ancora il convento di Erfurt, ma Eckhart dovette passare questo periodo, di circa 8 anni, in continui viaggi, per visitare le case dell’Ordine, fondarne di nuove (a Braunschweig, Dortmund, Groeningen furono infatti istituiti dei conventi femminili, ratificati nel 1310 dal papa), per partecipare ai capitoli provinciali annuali (sempre per la festa della Natività di Maria, l’8 settembre) e a quelli generali, tenuti, per la Pentecoste, a Tolosa nel 1304, a Strasburgo nel 1307, a Piacenza nel 1310.
Proprio al capitolo di Strasburgo Eckhart fu nominato anche vicario generale di Boemia, con pieni poteri di riforma, e un’altra grande regione si aggiunse alla sua giurisdizione.
Eckhart, il maestro del distacco, per tutta la sua vita si occupò in maniera efficiente dei doveri legati alla sua posizione: e ciò dovrebbe far riflettere chi male intende questo distacco.
Nel 1310 il capitolo provinciale di Spira, sotto la presidenza di Teodorico di Freiberg, elegge Eckhart provinciale della Teutonia, ossia della Germania meridionale, ma il capitolo generale di Napoli, l’anno seguente, si pronunciò diversamente, togliendo ad Eckhart anche il provincialato sassone e inviandolo a Parigi.
Al biennio parigino 1311-1313, che è per lui il momento della piena maturità, segue il decennio strasburghese. Tra il 1314 e il 1323 o 1324, Eckhart è infatti vicario generale del Maestro dell’Ordine, con l’incarico della cura d’anime dei monasteri femminili. Proprio in questo ambiente renano, dalla Svizzera all’Alsazia, si farà sentire maggiormente l’influenza della sua predicazione, a un punto tale che a lungo si è creduto che Strasburgo fossa la sua patria.
Una visita al celebre monastero (oggi museo) di Unterlinden, nell’estate del 1322, è l’ultimo atto ufficiale di Eckhart quale vicario generale a Strasburgo su cui siamo informati. L’anno seguente, infatti (o, più probabilmente, nel 1324) egli viene chiamato ad assumere, quale lector primarius, la cattedra teologica dello Studio dei domenicani di Colonia. Nella grande città sul Reno trascorre pochi anni, e forse neanche tranquilli, dal momento che è molto probabile che iniziassero subito contro di lui voci diffamatorie di eresia: nel 1326, a Colonia, si apre il processo a suo carico.
Sugli ultimi anni di vita di Eckhart, la cui morte, presumibilmente ad Avignone, risale al periodo tra il luglio 1327 e l’aprile 1328, siamo informati abbastanza bene, proprio grazie alle vicende di quel processo che rappresenta il fatto cruciale della sua esistenza, e anche la chiave di volta per la trasmissione e l’interpretazione del suo pensiero.
Verso la metà del 1326, nella fattispecie, il principe vescovo di Colonia, Enrico II di Virneburg, che già si era fatto notare come risoluto persecutore di begardi e Fratelli del Libero Spirito, iniziò un processo di Inquisizione contro Eckhart, sulla base di una denuncia (dalla discutibile attendibilità, come pare) che già alcuni domenicani avevano levato contro il Nostro in occasione della Visitazione che il confratello Nicola di Strasburgo aveva compiuto l’anno prima al loro convento. Ci dovevano dunque essere dei contrasti interni all’Ordine domenicano, forse tra correnti più o meno rigoriste.
Sappiamo che ad Eckhart furono contestate due liste di proposizioni sospette di eresia: una prima lista, contenente 49 frasi tratte soprattutto dal Liber benedictus e da alcune opere latine; una seconda di 59 frasi, tutte tratte da sermoni tedeschi. Altre liste furono successivamente redatte ad Avignone, dove il processo si spostò e si concluse.
Sulle vicende avignonesi del processo non abbiamo molte testimonianze. Sulla base delle liste di accusa di Colonia venne costituita una ulteriore e più ristretta lista, per la quale conosciamo la perizia teologica, che però non cita mai l’autodifesa di Eckhart.
Pur nel suo tecnicismo teologico, la lista delle proposizioni censurate, che qui riporto, ci fornisce un primo e importante quadro di alcuni dei più importanti insegnamenti del magister domenicano su cui parleremo più approfonditamente nella parte filosofica dell’esposizione.
«I) Essendo stato interrogato una volta sul perché Dio non abbia creato prima il mondo, rispose che Dio non poté creare il mondo prima, perché una cosa non può agire prima di essere; perciò, appena Dio fu, subito creò il mondo.
II) Similmente si può concedere che il mondo sia esistito dall’eterno.
III) Similmente, nel medesimo tempo e nel medesimo istante in cui Dio fu e generò il Figlio, Dio a lui costerno e in tutto uguale, creò anche il mondo.
IV) Similmente in ogni opera, anche cattiva – e dico cattiva in ordine sia della pena sia alla colpa –, si manifesta e riluce ugualmente la gloria di Dio.
V) Similmente, chi ingiuria qualcuno loda Dio con quello stesso peccato di ingiuria, e, quanto più ingiuria e più gravemente pecca, tanto più loda Dio.
VI) Similmente, chi bestemmia Dio stesso, loda Dio.
VII) Similmente, chi chiede questa o quella cosa, chiede il male e chiede male, in quanto chiede la negazione del bene e la negazione di Dio, e prega che Dio gli si neghi.
VIII) Chi non ha di mira beni, né onori, né utilità, né devozione interna, né santità, né premio, né regno dei cieli, ma ha rinunciato a tutto ciò, e anche a quel che è suo proprio, in tali uomini Dio viene onorato.
IX) Di recente mi sono chiesto se volevo ricevere o desiderare qualcosa da Dio: voglio rifletter molto su questo punto, perché, se ricevessi qualcosa da Dio, sarei sotto di lui o suo inferiore, come un servo o uno schiavo, ed egli come un padrone, nel dare – e così non dobbiamo essere nella vita eterna.
X) Noi siamo trasformati totalmente in Dio e mutati in lui; come nel sacramento il pane viene mutato nel corpo di Cristo, così sono cambiato in lui, giacché egli mi rende uno col suo essere, non simile; per il Dio vivente è vero che non c’è più alcuna distinzione qui.
XI) Tutto quello che Dio Padre ha dato al Figlio suo unigenito nella natura umana, lo ha dato anche a me, senza alcuna eccezione, né dell’unione né della santità: lo a dato tutto a me come a lui.
XII) Tutto quello che la sacra Scrittura dice di Cristo, si verifica totalmente anche in ogni uomo buono e divino.
XIII) Tutto quello che è proprio della natura divina, è proprio anche dell’uomo giusto e divino: perciò quest’uomo opera tutto quello che Dio opera, e ha creato insieme a Dio il cielo e la terra, e genera il Verbo eterno, e Dio non saprebbe cosa fare senza un tale uomo.
XIV) L’uomo buono deve conformare la propria volontà a quella di Dio in modo tale da volere tutto quel che Dio vuole. Al momento che Dio in qualche modo vuole che abbia peccato, io non devo voler non aver commesso peccati, e questa è la vera penitenza.
XV) Se un uomo avesse commesso mille peccati mortali e fosse in buona disposizione, non dovrebbe voler non averli commessi.
XVI) Dio non comanda propriamente alcuna azione esteriore.
XVII) L’azione esteriore non è propriamente buona né divina, né Dio la opera propriamente, né la genera.
XVIII) Dobbiamo portare il frutto non delle azioni esteriori, che non ci rendono buoni, ma di quelle interiori, che il Padre, che abita in noi, fa e opera.
XIX) Dio ama le anime, non l’opera esteriore.
XX) L’uomo buono è l’unigenito Figlio di Dio.
XXI) L’uomo nobile è quel Figlio di Dio unigenito che il Padre ha generato dall’eternità.
XXII) Il Padre genera me come suo Figlio e come suo stesso Figlio. Tutto quel che Dio opera è uno; perciò genera me come suo Figlio senza alcuna distinzione.
XXIII) Dio è uno secondo tutti i modi e sotto ogni aspetto, per cui non è possibile trovare in lui alcuna molteplicità, né ideale, né reale; infatti chi vede la dualità o la distinzione non vede Dio, perché Dio è uno al di fuori e al di sopra del numero, e non si somma con niente altro nell’uno. Ne consegue che in Dio stesso non può esserci né essere pensata alcuna distinzione.
XXIV) Ogni distinzione è estranea a Dio, sia alla natura sia alle Persone; giacché la natura stessa è una e questo stesso uno, e ogni Persona è una e lo stesso uno che è la natura.
XXV) Quando si dice: “Simone, mi ami più di costoro?” (Gv 21,15), il senso di questo «più di costoro» indica il bene, ma non la perfezione. Infatti dove c’è un primo e un secondo c’è un più e un meno, una gradazione e un ordine, ma nell’uno non c’è né grado né ordine. Perciò chi ama Dio più del prossimo agisce bene, ma non perfettamente.
XXVI) Tutte le creature sono un puro nulla: non dico che siano poca cosa o qualcosa, ma che sono un puro nulla.
XXVII) C’è nell’anima qualcosa di increato e increabile; se tutta l’anima fosse tale, sarebbe increata e increabile; e questo qualcosa è l’intelletto.
XXVIII) Dio non è né buono né migliore né ottimo; perciò dico male quando dico che Dio è buono, come se chiamassi nero il bianco»[56].
Siamo qui in presenza di un fortissimo senso dell’incarnazione di Dio, che è vissuta come una realtà esperita qui ed ora, nell’unità dello spirito.
Il magistero eckhartiano fondamentalmente, come rileva Vannini[57], consiste in questo soltanto: nel tentare di far comprendere che non c’è un Dio lassù, mentre noi stiamo quaggiù, ma che io e Dio siamo una cosa sola. La predicazione eckhartiana consta di pochi punti fondamentali, che svilupperemo: il distacco e la nobiltà dell’anima, di modo che l’uomo possa tornare all’Uno, che è Dio. Tra amore e conoscenza, Eckhart dà il primato alla seconda, poiché essa sola distacca. Tuttavia, sia amore che conoscenza sono determinati, pertanto ambedue implicano sempre la dualità e l’alienazione.
1.2.12) Esicasmo
Più o meno negli anni in cui si svolgeva la vicenda terrena di Meister Eckhart, una parallela questione relativa alla spiritualità interessava la Chiesa greca in modo particolare: la controversia esicasta.
In sintesi, come scrive Vannini in proposito, la Chiesa d’Oriente, « puntando sul monachesimo come elemento centrale della vita cristiana, fin dal tempo dei Padri del deserto aveva anche insistito sulla componente ascetica […] come essenziale e determinante per quella che si voleva configurare come “visione di Dio”, “unione con Dio”, o simili, conseguibile in questa vita»[58].
La questione della processione dello Spirito dal solo Padre o anche dal Figlio (filioque), come stabilito dalla Chiesa latina, è una questione della massima rilevanza. Infatti, come si sarà compreso, l’insistenza sul Figlio significa sottolineare la conoscenza, il distacco, in virtù del quale niente di determinato può essere Dio e, al contempo, tutto l’umano si spiritualizza e si divinizza. Per contro, far derivare lo Spirito dal solo Padre significa ritenere che il divino possa, in quanto tale, sottrarsi alla finitezza, all’umano, al relativo.
Per cui, vi è una logica profonda nel privilegio attribuito alle tecniche ascetiche, che vanno in una direzione simile a quella dello yoga indiano, dal digiuno al controllo della respirazione, dalla veglia prolungata alla concentrazione su un punto del corpo (l’ombelico, per esempio), alla ripetizione continua del nome di Gesù o di una formula di preghiera (come un mantra).
Le figure che più spiccano sono quelle di Evagrio Pontico (IV secolo), Giovanni Climaco (VI-VII secolo), Gregorio Sinaita (XIII-XIV secolo) e Gregorio Palamas (XIV secolo).
Nel secolo che intercorre tra Eckhart e Niccolò Cusano, il mondo germanico ha prodotto alcuni capolavori della Mistica cristiana. Saranno ricordati solo i principali, partendo dai due domenicani discepoli di Eckhart: Enrico Suso e Giovanni Taulero.
1.2.13) Suso: abbandono dell’ascesi violenta
Heinrich Seuse (latinizzato Suso) nacque probabilmente a Überlingen, sul lago di Costanza, e nel convento dei domenicani di quella città passò buona parte della sua vita. Morì a Ulm, nel 1366, a 70 anni di età.
Nella sua Vita, il giovane religioso racconta, e Vannini lo riporta[59], come fu condotto da un’esistenza di durissime macerazioni e penitenze alla dottrina del distacco, e quindi alla pratica dell’abbandono in Dio, senza più tormentare il corpo: «Il venerato maestro Eckhart gli apparve in una visione, manifestandogli di trovarsi in uno straordinario splendore, dove la sua anima era puramente divinizzata in Dio; gli rivelò anche che si poteva giungere nell’abisso “senza modo” sprofondandosi in se stessi, quanto al proprio egoismo, in totale distacco, prendendo tutte le cose da Dio, non dalla creatura, e stabilendosi in una silenziosa pazienza, nei confronti di tutti gli “uomini lupi”»[60].
Ne Il libretto della verità troviamo, scrive Vannini, «una delle più chiare teorizzazioni del principio dialettico del superamento dei contrari come chiave di accesso alla vita dello spirito»[61].
L’intelletto dell’uomo distaccato si intuisce Uno in Colui il quale è il nulla di tutte le cose esprimibili – quel nulla che noi chiamiamo Dio, e che è in se stesso l’essenza di tutte le cose. In particolare, rileva Vannini[62], Suso si distacca da Eckhart nel tenere ben salda la necessità dell’imitazione di Cristo, con tutto il necessario corollario di opere di pietà, anche nei confronti dei santi e della Vergine, verso la quale Suso nutre una tenera devozione.
Tuttavia, in seguito, Suso corregge la sua posizione si riallinea presto col suo maestro, sostenendo che non si tratta di imitare Cristo esteriormente, bensì interiormente. Anzi, prosegue Vannini[63], chi imita Cristo esteriormente finisce per dimenticare che Egli era dolce e mite, divenendo rude e giudicando le persone che non vivono a suo modo: mostra così di essere legato alla volontà propria e non giunge affatto all’autentica conformità con Cristo.
1.2.14) Taulero: tre tappe verso la perfezione
Ancor più che a Suso, dobbiamo però al suo contemporaneo Giovanni Taulero (nome italianizzato di Johannes Tauler, domenicano, nato a Strasburgo verso il 1300 e ivi morto nel 1361) se la mistica eckhartiana non è rimasta sepolta sotto il macigno della condanna papale.
Per Taulero, l’uomo è come se fosse tre uomini, pur essendo uno solo. Il primo e l’uomo esteriore (animale, sensibile); il secondo è l’uomo razionale, con le sue facoltà; il terzo corrisponde al fondo dell’anima, la parte più elevata dell’anima.
Non è difficile riconoscere, fa notare Vannini[64], l’antropologia paolina: carne, anima, spirito; tre parti gerarchizzate e non giustapposte.
Nondimeno, queste tre parti costituiscono anche le tappe del cammino spirituale verso la perfezione. Anzitutto, con la guida della ragione, si deve domare l’uomo inferiore, l’uomo sensuale. Poi si tratta di tenere la ragione stessa al suo posto e ciò non è facile, perché spesso la ragione vuol dominare.
Nell’elaborata psicologia tauleriana, per Vannini[65], il concetto di “fondo (Grunt) dell’anima” proviene certamente da Eckhart, mentre specifico del linguaggio dello Strasburghese è quel Gemüte che ha costituito la croce dei traduttori e degli esegeti. Esso traduce in genere il latino mens della tradizione agostiniana, che rimanda al nostro “spirito”, ed è per Taulero qualcosa di molto più elevato e interiore delle facoltà, poiché da esso le facoltà ricevono la loro forza, anzi, in esso sono incluse e da esso provengono. Assolutamente semplice, formale, sempre in atto, sempre rivolto a Dio, conosce se stesso come Dio in Dio, nella contemplazione, pur restando cosa creata.
Del Gemüte, Taulero sottolinea la riflessività: come immagine trinitaria esso è lo spirito, sempre memore di sé, sempre conosce e ama se stesso, pur dipendendo da Dio in quanto “fondo”: da qui il rapporto indissolubile tra i due concetti, per cui lo Strasburghese definisce lo “spirito” come ripiegato verso il “fondo”, ove riposa l’immagine elevata al di sopra delle facoltà.
1.2.15) L’Anonimo Francofortese
Terza, grande autorità della Mistica medievale tedesca di stampo eckhartiano (la “via del distacco), è un piccolo libro, che ha avuto una curiosa storia.
Si tratta del Libretto della vita perfetta, opera di un non meglio precisato Cavaliere Teutonico di Francoforte, redatto presumibilmente alla fine del Trecento.
Il Francofortese ripete, con monotonia, l’insegnamento fondamentale: «bisogna distaccarsi da noi stessi; l’appropriazione è ciò che costituisce il male radicale. Rinunciare a se stessi, rinunciare a tutto ciò che è riferito all’io»[66]. Tuttavia, rileva Vannini[67], questo distacco non è una fuga dal mondo, ma semplicemente la rinuncia alla Eigenschaft, ossia all’appropriazione.
Questa è la vera imitazione di Cristo: nell’ubbidienza, nel distacco, senza una volontà propria, abbandonato alla volontà di Dio.
L’“uomo nobile” trova così gioia nella finitezza, in questo mondo, perché nel distacco Dio gli è sempre presente e nel distacco le creature si rapportano tutte all’Uno.
1.3) L’epoca moderna
1.3.1) L’Imitazione di cristo
Conformarsi a Cristo, imitare la sua vita, è un tema costante nella spiritualità cristiana medievale, come abbiamo visto; e si è visto come la mistica renana intenda ciò essenzialmente nel senso della rinuncia alla volontà propria, attuabile in qualunque genere di vita.
Abbastanza diversa, rileva Vannini[68], è invece la posizione assunta dal libro, scritto in latino, dal titolo L’imitazione di Cristo (attribuito a Tommaso da Kempis), con cui apriamo la trattazione della Mistica nella modernità, e che è stato una delle opere più diffuse e importanti del mondo cristiano per secoli.
L’itinerario dell’unione uomo-Dio, è delineato dall’amore e l’autore, anche in questo caso, come è costante nell’opera, professa la superiorità della vita claustrale e monastica, nella quale ci si può più facilmente conformare al modello di Cristo, soprattutto attraverso l’imitazione del Crocifisso.
Tuttavia, differenziandosi dalla mistica renana, l’autore intende la croce come una sorta di insegna di combattimento, proponendo un modello di vita cristiana come militia Christi e sostenendo l’utilità di opere ascetiche: la Mistica renana sostiene invece, ricorda Vannini[69], l’inessenzialità di opere e modelli, e la bontà di ogni genere di vita, che il distacco spiritualizza.
1.3.2) La Nube della non-conoscenza
Verso la metà del Trecento apparve in volgare quella Nube della non-conoscenza che costituisce il frutto più noto della letteratura inglese medievale.
L’autore, a noi ignoto, traccia un cammino di totale spogliazione di sé, alieno da ogni eccesso e dalle manifestazioni esteriori, alla portata di tutti. Lo scrittore coglie bene, commenta Vannini, «la realtà unitaria del distacco che è amore e dell’amore che è distacco, e significativamente, conclude la sua Lettera di direzione spirituale con un capitolo ispirato a Gv 16,7 (“È bene per voi che io vada”), ovvero incentrato sulla necessità di abbandonare anche l’umanità di Cristo, perchè si abbia una vera unione spirituale, priva di ogni sentimentalismo»[70].
Alquanto rilevante, rispetto a certo visionarismo, la cautela che La nube propone a questo riguardo: i veri frutti della contemplazione, spiega Vannini[71], non sono un qualcosa che va al di là della natura, bensì sono del tutto conformi alla natura, vale a dire un discreto silenzio e un parlare opportuno, una segreta preghiera, maniere umili e una contenuta gioia.
1.3.3) La devotio moderna
Con l’espressione devotio moderna si indica, scrive Vannini, «un movimento spirituale, originario dei Paesi Bassi e diffuso soprattutto nell’area renana. Tale movimento è teso a una riforma della vita religiosa e della pietà tradizionale, soprattutto nel senso della valorizzazione dell’interiorità, a tutto discapito delle pratiche esteriori e con netta presa di distanza dai fenomeni miracolistici»[72], diffusi in quel periodo e in quella zona.
L’iniziatore del movimento è un certo Groote, nato a Deventer nel 1340 da famiglia patrizia. Abbandonò una sicura carriera di magister a Parigi, insieme ai beni di famiglia, ritirandosi per tre anni (1374-1377) nella certosa di Monnikhuizen, presso Utrecht, ove venne in contatto con gli scritti di Eckhart. Fece visita a Ruusbroec e, lasciata la certosa, si dedicò con successo alla predicazione itinerante con l’amico e discepoli Florens Radewijns.
La direzione prevalente della devotio moderna è quella morale-ascetica: la preoccupazione principale di Groote e amici è quella di distinguersi dall’eresia, dai Fratelli del Libero Spirito e, in ultima analisi, da Eckhart stesso.
Proprio l’attenzione verso l’ascesi, rileva Vannini[73], preparerà la via ai “regolamenti” cinquecenteschi e agli “esercizi spirituali”, come vedremo.
1.3.4) Cusano
Ultimo grande esponente della Mistica speculativa tedesca prima della Riforma protestante fu Niccolò Cusano, nato a Kues, sulla Mosella, nella diocesi di Treviri, nel 1401, da una famiglia abbastanza agiata. Frequentò forse la scuola dei Fratelli della Vita Comune a Deventer (nell’attuale Olanda), largamente ispirata alla devotio moderna, mentre è certo che nel 1416 iniziò gli studi accademici a Heidelberg, per passare l’anno seguente a Padova, ove si addottorò in diritto nel 1423. In Italia, allora vero centro della cultura europea, Cusano conobbe Paolo dal Pozzo Toscanelli, Vittorino da Feltre e molti altri umanisti, ai quali resterà legato per tutta la vita.
Tornato in Germania, studiò filosofia e teologia a Colonia, città in cui, un secolo prima, aveva operato Meister Eckhart, e in cui ebbe come maestro e amico il neoplatonico Emerico di Campo, profondamente legato alla teologia negativa dello Pseudo-Dionigi. Divenuto segretario del cardinale Giordano Orsini, legato pontificio in Germania, nel 1432 troviamo Cusano attivo, come giurista, al concilio di Basilea e, entratovi come sostenitore del partito conciliarista, ne esce come fautore della causa papale, e da allora in avanti la sua vita sarà densa di impegni politico-religiosi. Nel 1437 compie un viaggio molto importante a Costantinopoli e, per tutto il decennio successivo, è in Germania, a combattere per la causa papale contro i sostenitori del conciliarismo. Nel 1448 viene nominato cardinale e, due anni dopo, vescovo di Bressanone: si apre così un periodo assai fecondo per Cusano, dal punto di vista filosofico e scientifico, nel quale opererà attivamente (non senza difficoltà) per una riforma religiosa della sua diocesi. Dopo il 1458 lo troviamo prevalentemente a Roma, come cardinale della Curia e vicario dello Stato pontificio, accanto all’amico Enea Silvio Piccolomini, divenuto pontefice con il nome di Pio II. La morte colse Cusano nell’agosto 1464, a Todi, mentre si recava da Roma ad Ancona, dove Pio II aspettò invano le navi veneziane che dovevano condurre i crociati in Oriente.
De docta ignorantia è il titolo della maggiore opera filosofico-teologica di Cusano, che venne progettata nel viaggio di ritorno dalla Grecia e conclusa in poco più di due anni nel gennaio 1440.
Ogni conoscenza, come viene asserito nello scritto, è per Cusano rapporto, proporzione tra noto e ignoto così come, per esempio, una misura lineare si ottiene applicando lo strumento di misura all’oggetto da misurare, ed è pertanto sempre relativa, mai definitiva, dato che una misura può essere resa sempre più precisa affinando lo strumento di misura.
È evidente, rileva Vannini[74], che non vi può essere conoscenza dell’infinito, perché, in quanto tale, sfugge a ogni proporzione, ossia al rapporto con le nostre facoltà conoscitive, che sono finite. Perciò, noi non abbiamo una conoscenza positiva di Dio, che è assoluto e infinito.
Siamo dunque in una condizione di ignoranza, che però è “dotta”: il superamento della finitezza, spiega Vannini, «è possibile alla stessa intelligenza umana, poiché essa non è solo ragione discorsiva e finita, cioè ratio, ma anche intellectus, ossia quella ragione che è in grado di andare oltre le determinazioni finite»[75].
Ne La difesa della dotta ignoranza Cusano, rispondendo all’accusa di panteismo, mossagli da Johannes Wenck von Herrenberg, teologo scolastico di Heidelberg, fa appello alla fondamentale distinzione tra complicatio ed explicatio. Tale distinzione è usata dal Nostro, scrive Vannini, «nel senso che l’essere eterno di tutto il possibile in Dio (complicazione) è distinto dalla realtà del possibile nel mondo (esplicazione)[76].
Il De visione Dei, concluso a Bressanone nell’ottobre 1453, è una delle più importanti opere mistico-filosofiche di Cusano.
Nel suo complesso, l’opera è una rigorosa dimostrazione dell’Uno, ossia della non-alterità di Dio.
1.3.5) Jakob Böhme
Nato nel 1575 ad Alt-Seidenberg, nella Slesia, quarto figlio di una famiglia contadina, Jakob Böhme apprende da ragazzo quel mestiere di calzolaio che eserciterà per tutta la vita. Nel 1599 ottiene la cittadinanza della vicina Görlitz, sulla Neisse, acquista un banco di calzolaio e si sposa con Caterina Kuntzschmann, figlia di un macellaio. L’anno dopo gli nasce il primo figlio, e Jakob inizia ad avere le sue illuminazioni. Nel 1612 scrive la sua prima opera, L’aurora che sorge (titolo tratto da Ct 6,10). Nel 1613 comincia la persecuzione, a opera del locale pastore luterano, Gregor Richter: Jakob viene accusato di eresia e gli viene intimato di non scrivere più.
Tra il 1619 e il 1623 nascono le sue opere principali (egli, su consiglio degli amici, ricomincia a scrivere e compie diversi viaggi), le quali, fatte circolare da amici ed estimatori, assicurano una vasta notorietà all’autore.
Nel 1624 appare a stampa, a Görlitz, La via a Cristo, e ciò scatena nuovamente l’ostilità di Richter, che conduce nuovamente Böhme davanti a un magistrato.
Nel maggio di quell’anno, Jakob si reca a Dresda, invitato dalla corte sassone, ma non ottiene udienza dal principe; intanto la sua famiglia è esposta alla violenza del popolo, aizzato da Richter. In agosto, questi muore e poco dopo, il 17 novembre, muore anche Böhme.
Il Nostro, commenta Vannini[77], presenta un pensiero in cui i temi tipici della Mistica medievale germanica si saldano con alcuni caratteristici motivi della speculazione rinascimentale. Anzitutto, la Scrittura deve diventare interiore e autenticarsi nel singolo uomo, altrimenti resta esteriorità e superstizione.
Come i mistici medievali, rileva Vannini, «Böhme chiama “nascita della Divinità” quella discesa nell’interiorità in cui lo spirito trova il “fondo” (Grund) e l’“abisso senza fondo” (Ungrund) della stessa Divinità, precedente alla processione delle Persone. Prima della Trinità, infatti, v’è un Ungrund al di fuori di ogni natura e, anche al di fuori di ciò che viene predicato dalla Chiesa»[78].
Per Böhme, spirito e materia non sono separati: Dio e la natura si uniscono in quell’unità che l’alchimia medievale e rinascimentale intendeva quando parlava di un unus mundus, di un mondo che, nell’unità, è il Tutto. In questo concetto di unità del Tutto, Böhme, aggiunge Vannini, recupera anche le intuizioni di Paracelso sulla costituzione della materia, di cui sale, zolfo, mercurio sarebbero gli elementi essenziali; così come trovano posto le speculazioni numerologiche di origine cabalistica.
Anche il mito dell’androgino, di platonica memoria, ha un ruolo nella visione del Nostro, il quale, commenta Vannini[80], pecca forse di una certa ingenuità, poiché sembra cedere in maniera a-critica a certe speculazioni.
1.3.6) Angelus Silesius: il Pellegrino Cherubico
Johannes Scheffler, che prenderà poi il nome di Angelus Silesius, nacque a Breslavia, negli ultimi giorni del dicembre 1624, figlio di un nobile polacco.
Dopo accurati studi ginnasiali, si addottorò (1648) in Medicina e Filosofia a Padova, dopo essere passato per le università di Strasburgo e Leida.
Tornato in patria, Scheffler ottenne nel 1649 l’incarico di medico di corte presso il duca von Württemberg a Öls (oggi Olesnyca, cittadina non lontano da Breslavia). Fu lì, nel vicino castello di Ludwigsdorf, che conobbe l’anziano Abraham von Franckenberg, appassionato cultore di mistica, sostenitore di una religiosità interiore, libera dal dogmatismo. L’amicizia con Franckenberg fu breve, dato che questi morì nel giugno 1652, ma fu sicuramente uno degli episodi più importanti della vita di Scheffler, il quale ereditò anche parte della biblioteca dell’amico, con parecchi libri che erano appartenuti a Böhme.
Nello stesso 1652, Johannes si dimise dall’incarico di medico e, l’anno dopo, a Breslavia, porta a compimento la sua conversione al cattolicesimo, assumendo il nome di Johannes Angelus. Fondamentalmente, alla base della sua conversione, vi è, per Vannini, «l’inconciliabilità tra l’esperienza interiore, ascetica e spirituale, attraverso la quale il cristiano genera il Logos, e l’esteriorità della dottrina luterana, con la sua concezione della radicale alterità di Dio»[81].
L’insegnamento di Johannes si trova, passo dopo passo, nei distici del Pellegrino cherubico, sua massima opera, e fondamentale testo della Mistica germanica.
1.3.7) Ignazio di Loyola
Gentiluomo di origine basca, nato nel 1491, Ignazio portava con sé un atavico attaccamento al cattolicesimo: nella memoria storica della sua gente stavano i secoli della guerra contro i Mori, a difesa dell’identità cristiana della penisola iberica. Dalla sua classe egli traeva il senso militarecavalleresco dell’esistenza, quello della vita come fedeltà, servizio a un signore e a una causa.
A seguito di una ferita in combattimento e ad un periodo di forzata inattività, in cui si dedica alla lettura di opere religiose, decide di porsi al servizio della Chiesa e fonda l’Ordine dei gesuiti, riconosciuto dal papa nel 1541.
Ignazio, profondamente radicato nel cristianesimo, sviluppò una marcata devozione cristocentrica incentrata sulla Passione: e la compassione per Cristo crocefisso, scrive Vannini, spingerà Ignazio «all’azione, con una costanza, una dedizione, un disinteresse alla propria vita e alla propria sorte che solo chi conosce le virtù militari può comprendere»[82].
Dal punto di vista della nostra ricerca, ci interessano maggiormente gli Esercizi spirituali, stampati nel 1548, uno dei libri che ha maggiormente influenzato la spiritualità cattolica negli ultimi quattro secoli.
Ora, fin dal titolo è chiaro che gli Esercizi, scrive Vannini, «appartengono specificamente al genere letterario ascetico, dal momento che “ascesi” significa appunto “esercizio”[83].
Il libretto di Ignazio consta di una elaborata tecnica di direzione psicologica,commenta Vannini[84], con il fine di plasmare o quanto meno orientare la coscienza vero la pietà cattolica del suo tempo. La tecnica usata, prosegue Vannini, «è quella della rappresentazione sensibile, attraverso l’immaginazione, che non è solo visiva ma include l’esercizio di tutti e cinque i sensi»[85].
Per Ignazio, è inconcepibile l’annullamento di sé: fin dall’inizio, i gesuiti saranno pronti a riconoscere e a combattere le tendenze mistiche che conducono al nulla dell’anima e al nulla di Dio. Un atteggiamento di sostanziale distacco verso la cultura, nondimeno, vista come inessenziale per la salvezza dell’anima, condusse i gesuiti a un positivo apprezzamento di tutto ciò che di buono si trovava anche al di fuori del mondo cristiano ed europeo: qui opera la consapevolezza, che anche Ignazio ebbe, della presenza di Dio in tutte le cose.
All’età della Controriforma, al mondo spagnolo largamente permeato dalla mentalità di Ignazio di Loyola, appartengono le figure “classiche” della mistica cattolica, ossia Teresa d’Avila e Giovanni della Croce.
1.3.8) Teresa d’Avila: il Castello interiore
Teresa nasce ad Avila, nella Vecchia Castiglia, nel 1515 e cresce nell’epoca di Carlo V, quando la Spagna si sente investita della missione divina di difendere il cattolicesimo contro tutti i pericoli, interni ed esterni, che minacciano la cristianità: dai Turchi ai luterani.
Le caratteristiche basilari della mistica carmelitana, come si riscontrano in Teresa, sono da ricercare anzitutto, per Vannini[86], in una condizione di sofferenza, fisica o psichica. Infatti, nel 1538, durante una gravissima malattia che la condusse alle soglie della morte e che per tre anni la rese quasi invalida, lasciandola poi per sempre in una situazione di salute perennemente cagionevole, Teresa legge l’Abecedario spirituale del francescano Francisco de Osuna, che la orienta verso la meditazione interiore, ben diversa dalle solite preghiere vocali.
La seconda condizione essenziale della mistica cattolica di questo tipo, secondo Vannini[87] è infatti la meditazione cristologica, incentrata in particolare sulla Passione, con la quale si esorcizza il negativo.
Si inserisce,poi, secondo Vannini, una terza componente, forse la più rilevante, della mistica moderna: «il visionarismo estatico quale garanzia della validità e veridicità del vissuto umano e religioso, anzi, esso stesso fondamento ed essenza di tale vissuto»[88]; la stessa Teresa, infatti, racconta di aver sperimentato numerose visioni, le quali la sostennero nell’impresa della sua vita, ossia la riforma del Carmelo.
Forte è la componente psicologistica negli scritti di Teresa d’Avila, e ciò è evidente se si considera il capolavoro spirituale di Teresa, il Castello interiore, iniziato nel giugno 1577 a Toledo e terminato nel novembre dello stesso anno, ad Avila.
Il “castello”, diviso in sette dimore concentriche, è l’anima stessa, secondo una metafora ampiamente diffusa nella letterature religiosa.
1.3.9) Giovanni della Croce: mistica e Notte oscura
Autentico vertice della mistica cattolica è considerato però Giovanni della Croce (1542-1591), che di Teresa fu collaboratore nella riforma del Carmelo, nonché amico e consigliere.
Giovanni della Croce ha scritto quattro grandi opere: la Salita al Monte Carmelo, la Notte oscura, il Cantico spirituale e la Fiamma d’amor viva.
La caratteristica più interessante dell’opera di Giovanni della Croce, secondo Vannini, «è la ricchezza psicologica con cui sono descritte le “notti”, ossia gli annichilamenti purificatori dell’intelligenza, della volontà e della memoria (le tre potenze dell’antropologia) nella Salita e quelli dei sensi e dello spirito nella Notte. A tal proposito, è bene rilevare come Giovanni non faccia altro che ampliare un tema che gli proviene da Taulero e, più precisamente, da Eckhart stesso»[89], dal quale il Castigliano riprende concetti e immagini, a partire da quella famosa del legno che si trasforma in fuoco dapprima con grande sofferenza, ma poi con gioia, come avviene per l’anima stessa che deve trasformarsi in Dio.
Il “nulla” sanjuanista, commenta Vannini[90], altro non è se non la ripresa del “niente” eckhartiano, quel “niente” a cui va incontro l’“uomo povero” eckhartiano, che nulla sa e nulla vuole.
Come il mistico tedesco, Giovanni conduce nell’assoluto vuoto, nel nulla che è il tutto, e anche l’ardire delle sue espressioni si avvicina spesso a quello di Eckhart, parlando per esempio del proprio intelletto che diventa l’intelletto di Dio.
Eppure, un abisso separa Giovanni dalle sue fonti medievali; infatti, come scrive Vannini: «V’è infatti in Giovanni quella volontà di sistema, quell’insistenza sulla metodica, quella continua separazione natura-grazia che contrastano profondamente con la libertà, il respiro, la naturalezza […] di Eckhart»[91].
In particolare, che ne è del cristianesimo e di Cristo?
Da un lato, come scrive Vannini, «il santo castigliano insiste su di Lui, soprattutto ne utilizza la figura di crocifisso come cifra kenotica, ovvero come strumento di annichilimento, di “nulla”, dall’altro, però, ne sviluppa il “niente sapere” fino al trascendimento di ogni scienza, il che, rigorosamente inteso, porta fuori anche dal cristianesimo»[92].
Tuttavia, prosegue Vannini[93], Giovanni non compie mai questo passo, non solo perché ha bisogno della nozione di Spirito, e dunque della Trinità, per conciliare immanenza e trascendenza, unità immutabile e movimento della vita, ma perché in lui permane il primato dell’amore sulla conoscenza.
1.3.10) Francesco di Sales: la vita devota
Per comprendere effettivamente gli eventi che segnarono la storia della Mistica cristiana alla fine del Seicento, occorre prendere in considerazione la figura di Francesco di Sales (1567-1622), agli inizi del secolo stesso.
Sia nella Introduzione alla vita devota, sia nel Trattato dell’amore di Dio, Francesco, spiega Vannini, «si sforza di conciliare l’immagine alienante del Dio-padrone, che esige sottomissione e che è pronto a punire, tipica del suo tempo e della sua cultura, con la tematica dell’amore che gli proviene dalle letture mistiche e che, probabilmente, era più consona al suo animo»[94].
Francesco descrive la possibilità di una “vita devota” per tutti, indipendentemente dal sesso, dalla professione, dallo stato; poi delinea una fenomenologia dell’amore di Dio, che è al contempo un cammino per conformare la propria volontà a quella divina, fino a giungere a una “santa indifferenza” di stampo ignaziano.
Ciò che a Vannini interessa sottolineare[95] è il primato del binomio volontà/amore: per Francesco, lavolontà è ciò che ha ricevuto da Dio il controllo delle facoltà dell’anima, ed è essa stessa governata dall’amore, il quale è l’inclinazione che muove la volontà verso la cosa amata, avendo come fine ultimo l’unione di amante e amato.
1.3.11) Miguel de Molinos: quietismo?
Molinos (1628-1696) era un prete spagnolo, giunto abbastanza casualmente a Roma, ove si stabilì, guadagnando ampio seguito come direttore spirituale nella numerosa colonia spagnola ivi residente, godendo, tra l’altro, della stima di personaggi come papa Innocenzo XI e Cristina di Svezia.
La sua Guida spirituale (pubblicata in spagnolo nel 1675) insegna un itinerario per giungere alla purezza dell’anima, alla perfetta contemplazione e alla pace interiore, itinerario che consiste nella purificazione passiva (rimozione della volontà e di ogni pensiero), di modo che l’anima possa tornare alla sua origine, ossia Dio, la sola realtà.
Nel suo impianto complessivo, e nel suo esito, prosegue Vannini[96], la Guida sostiene quel nulla sapere, nulla essere, nulla volere che eliminano ogni dogmatismo e ogni contenuto, anche religioso.
Non meraviglia, dunque, che Molinos e seguaci fossero oggetto di pesanti attacchi da parte dei gesuiti, oltre all’aspetto politico, in particolare riguardante i rapporti papato-Francia-Spagna.
1.3.12) Madame Guyon: anti-intellettualismo
Madame Guyon (1640-1717), nel suo pensiero, riprende, dalla spiritualità del suo tempo, l’antiintellettualismo e il primato dell’orazione del cuore, tuttavia è capace di sollevarsi al di sopra dello psicologismo. Dal momento che Dio, spiega Vannini[97], è un essere puro e semplice, la contemplazione deve essere altrettanto pura e semplice, priva di immagini e anche di fenomeni straordinari, peraltro spesso illusori. L’anima annichilata, passata attraverso le “notti” del senso e dello spirito, entra in un’“estasi permanente”, ossia in una costante condizione di amore e unione con Dio.
1.3.13) La disputa tra Fenelon e Bossuet
Un legame stretto unisce Madame Guyon a Fenelon (1651-1715). Il vescovo di Cambrai aveva quella cultura e disciplina intellettuale che la donna possedeva solo in parte, così da poterne difendere le idee al meglio.
Fenelon, in particolare, si scontrò con Bossuet (1627-1704), vescovo di Meaux, in relazione alla Mistica. I punti essenziali della controversia, esposti da Vannini[98], sono i seguenti:
- Per Fenelon, la Mistica è la manifestazione della grazia santificante, che è propria di ogni cristiano fedele alla sua vocazione. I fenomeni straordinari sono un accessorio secondario, spesso dannoso. Per Bossuet, invece, la mistica è una condizione eccezionale, caratterizzata da quelle “grazie” straordinarie che Dio concede a pochi.
- Secondo Fenelon, richiamandosi anche a Francesco di Sales, l’amore per Dio nel suo grado più alto è, e deve essere, amore puro e disinteressato. Per Bossuet, invece (che peraltro si richiama anch’egli a Francesco di Sales), anche l’amore più puro non può essere privo dell’interesse alla salvezza dell’anima.
- Per Fenelon, l’abbandono totale dell’anima alla volontà di Dio comporta anche un’indifferenza che si estende, come si è visto, anche alla sorte eterna dell’anima stessa. Per Bossuet, invece, la volontà deve essere sempre vigile ed orientata al bene.
1.4) Da Giordano Bruno ai nostri giorni
1.4.1) Giordano Bruno: unità e infinità del Tutto
Giordano Bruno (1548-1600) non fu un sistematico, sia perché non ne ebbe il tempo, sia perché, anticipando Nietzsche, capì che la volontà di sistema è un atto che denota limitatezza.
L’intuizione fondamentale di Giordano Bruno, che permane immutata e, anzi, si rafforza, attraverso le molteplici influenze che la sua vastissima cultura gli procura, come scrive Vannini, «è [...] quella dell’unità e infinità del Tutto, vivo di vita immortale, che racchiude in sé la ricchezza inesauribile delle sue determinazioni e le unifica in una totalità omogenea, senza lacerazioni»[99]. Perciò, Bruno accoglie con entusiasmo la nuova cosmologia copernicana e recupera da Cusano la teoria dell’infinità dell’universo e della pluralità dei modi.
Per Giordano Bruno la Mistica, non manca di sottolineare Vannini, «non è un tipo di vita separato dal mondo, chiuso nella introversione e in forme innaturali di autoavvilimento e autoabiezione, che corrispondono poi ad amore di sé e desiderio di potenza»[100].
Bruno, nondimeno, riconosce la bontà del cosmo, una bontà che viene affermata, si badi bene, senza il concetto biblico di creazione, il quale nega la divinità del cosmo e lo rende un oggetto sottomesso a una causa e a un fine.
Inoltre, al pari di ogni mistico, Bruno vede Dio presente in tute le cose, secondo la dialettica cusaniana di complicatio-explicatio, ma come Uno che è al di là dell’essere e al di là del molteplice. Più che di panteismo, fa notare Vannini[101], sarebbe corretto parlare di panenteismo, riferendoci all’autentica Mistica.
È nel dialogo De gli eroici furori che il platonismo bruniano ha come esito il misticismo più puro, misticismo che consta di amore intellettuale e intelligenza attiva.
L’eroico furore altro non è, spiega Vannini[102], se non l’amore del Simposio platonico; nello specifico, il primato, nell’opera, è della contemplazione, la quale conduce l’uomo a identificarsi col divino, al di là di ogni temporalità. Mentre la vita attiva, infatti, è dominata dalle passioni (“furori”) più basse, la vita contemplativa è dominata da quell’aspirazione alla bellezza divina che è l’eroico furore: al termine della contemplazione, si ha l’identificazione con il divino, previo l’abbandono il molteplice e il rientrare nel profondo della mente.
Per le sue idee, e per il suo reiterato rifiuto ad abiurare, Bruno sarà arso vivo in Campo de’ Fiori, a Roma, nel 1600.
1.4.2) Spinoza e l’Etica
Spinoza è, a tutti gli effetti, un uomo moderno, un uomo di scienza, che costruisce il suo capolavoro, l’Etica, con rigore matematico.
Con un percorso totalmente razionale, l’Etica di Spinoza conduce da Dio (sostanza unica, infinita, eterna, causa di se stessa) alla dimostrazione che nell’uomo è possibile la beatitudine,che consiste, spiega Vannini, «nell’amore nei confronti di Dio e verso la salus, che consiste nel “sapere di sé, di Dio, delle cose, per un’eterna necessità”. Tale itinerario non solo non passa per le religioni positive, ma presuppone anzi la rimozione di tutti quei loro contenuti irrazionali e superstiziosi che impediscono il conseguimento dell’obbiettivo»[103].
In Spinoza, nello specifico, troviamo la dissoluzione dell’io come sostanza.
In effetti, rileva Vannini[104], c’è un rapporto logico tra l’intuizione dell’unità e bontà del Tutto e la fine del soggetto personale, con i suoi legami. Questo, a sua volta, con la fine delle pretese di merito, di valore, ecc. dipende dalla più ampia intuizione dell’universale dominio della necessità. Pertanto Spinoza non si stanca di polemizzare con certe concezioni antropomorfiche del divino: è una bestemmia e segno di grande ignoranza il pensare a un Dio determinato, finito (omnis determinatio est negatio) che, in quanto tale, può pensare ad altre cose e disporsi a finalità estrinseche. In fondo, però, tutti i pregiudizi umani non dipendono forse da questo, come suggerisce Vannini[105]? E da questo pregiudizio nasce, poi, il pensiero del male.
Nel complesso, il grande sistema razionalistico dell’Etica non è altro, come rileva Vannini, «che la forma scolastica e cartesiana di questa intuizione dell’unità del Tutto e della sua bontà, che procede dall’essere di Dio»[106]; allo stesso tempo, siamo qui in presenza di un misticismo allo stato puro che coincide con il razionalismo, stante la necessità, in Spinoza, di riportare tutto a Dio, all’Uno e di pensare Dio in ogni singolo istante.
1.4.3) Spener e il pietismo
Dando uno sguardo all’ambito protestante, il più grande movimento spirituale ha un’origine istituzionale nei collegia pietatis fondati da Philipp Jacob Spener (1635-1705), a partire da Francoforte sul Meno nel 1670. Per Spener, il cristianesimo non andava considerato una forma di sapere, ma un’attività pratica, consistente essenzialmente nell’adempimento del precetto dell’amore.
Su questo terreno, spiega Vannini[107], il cristiano si può conformare a Cristo, fino a identificarsi con Lui. Spener, nondimeno, intuì perfettamente l’impossibilità di una società cristiana, di una Chiesa in grado di racchiudere in sé la società civile e di una società civile che potesse sinceramente professarsi cristiana. Soprattutto, intuì il disaccordo tra il cristianesimo comune e i più elevati valori umani e religiosi.
Come accennato in precedenza, nel Settecento si assiste al diffondersi di tendenze misticheggianti, in particolare nell’ambito protestante/massonico, o comunque con una spiccata tendenza all’esoterismo. Ora, se da un lato si deve sottolineare, sulla scorta di Vannini[108], come la mistica sia di per se stessa ostile alla fumosità dell’esoterismo (in quanto essa esprime, come si è visto, l’esigenza universale del logos che tocca l’essenza profonda di ogni uomo) bisogna però, dall’altro, riconoscere che le più serie figure di esoteristi settecenteschi tentarono proprio di salvare l’universale della ragione in un mondo ecclesiastico che si era rinchiuso su se stesso, ignorando o facendo finta di ignorare la realtà storica e scientifica.
1.4.4) Swedenborg
Una figura interessante di questo periodo è quella di Emanuel Swedenborg (1688-1772), importante per il suo tentativo di porre in stretto rapporto il mondo sensibile e quello soprasensibile, della luce divina, comprese, ovviamente, le anime individuali. Pertanto, secondo Swedenborg, tutti i fenomeni naturali e organici, come anche quelli intellettuali e psichici, sono in rapporto con i fenomeni spirituali, per cui ogni singolo evento non è casuale, ma espressione e simbolo di una realtà soprannaturale. Conseguentemente, l’uomo può entrare in relazione con le realtà spirituali dell’universo, che Swedenborg descrive come un grande vivente popolato da spiriti, angeli e demoni.
Ora, senza dubbio Swedenborg (che ebbe uno scontro filosofico con Kant) esprimeva anche fondate critiche all’universo meccanicistico di stampo newtoniano, nel quale Dio è visto come “grande orologiaio”, presenza estranea e meccanica. In particolare, pur con tutte le riserve del caso, appartiene senza dubbio alla mistica, come osserva Vannini[10909], l’intuizione per cui il soggetto attivo in ogni atto di pensiero è Dio stesso, realtà che tutto pervade.
L’illuminismo, come abbiamo visto, costituisce un punto di svolta essenziale anche per la storia della mistica. Dopo di esso, l’esperienza spirituale deve infatti reggersi da sola, in totale indipendenza dalla Scrittura, cui resta (eventualmente) soltanto quel valore retorico, di riferimento culturale, che tuttora possiede.
Da notare, però, che l’illuminismo tedesco, quello che qui ci interessa, ha una profonda radice religiosa: nel pietismo, con le sue esigenze di interiorità e nella ricerca di verità che anima la filologia neo- e veterotestamentaria si trovano infatti quei moventi che porteranno, per Vannini[110], a proibirsi le menzogne della mitologia biblica.
1.4.5) Fichte: distinzione tra dogmatismo e idealismo
La prima importante figura che incontriamo è quella di Fichte (1762-1814), il quale punta sin dall’inizio sul soggetto e sull’interiorità. Già il Saggio di una critica di ogni rivelazione (1791) sviluppa concetti kantiani in un senso che è certamente idealistico, ma prima ancora mistico: una verità, spiega Vannini, «che giungesse dall’esterno, come rivelazione, appunto, sarebbe destinata a restare altra ed estranea e, dal punto di vista morale distruggerebbe quella vita autonoma della ragione che, sola, ne assicura insieme libertà e universalità»[111].
Si tratta, prima di tutto, di comprendere che ogni sapere è solo un sapere di se stesso, dal momento che la coscienza non esce mai da sé, e che ciò che si ritiene coscienza dell’oggetto non è altro che la coscienza del nostro porre un oggetto. La coscienza delle cose fuori di noi non è dunque altro che il prodotto della nostra facoltà rappresentativa, per cui di una certa cosa sappiamo quello che produciamo. Da questa consapevolezza, si ricava un assoluto distacco nei confronti di tutte le nostre recuperando le antiche concezioni neoplatoniche secondo le quali tutto l’universo è emanazione rappresentazioni, di tutti i contenuti, assieme alla liberazione da ogni timore.
Nell’ambito del pensiero, la distinzione fondamentale, per capire il discorso, è quella tra dogmatismo e idealismo. Dogmatico è, come scrive Vannini, «chi pensa come prodotto da una cosa in sé tutto quel che si presenta nella coscienza; egli è di necessità anche materialista: il suo eventuale Dio non può essere pensato altro che come un oggetto, una cosa, sia pure grossa e potente, e non sarà mai Spirito. Ma il dogmatismo consiste soprattutto nella negazione dell’autonomia dell’io, sulla quale invece si fonda l’idealismo, e la distinzione tra i due modi di pensare è […] anzitutto una distinzione morale»[112].
1.4.6) Schelling: identità di natura e spirito
Nella “triade” dei grandi filosofi idealisti tedeschi, Schelling (1775-1854) è senza dubbio quello che ha più studiato e utilizzato scrittori appartenenti alla tradizione mistica, ad esempio Eckhart, Taulero, Böhme, la Teologia tedesca, Silesius. Ciò non significa, però, ci mette in guardia Vannini[113], che egli sia il più vicino a tale tradizione.
In generale, si può dire che il filosofo tedesco utilizzi spesso la letteratura mistica come spunto di riflessione, ma senza avervi vera parte. Effettivamente, come rileva Vannini, a Schelling «è propria solo una idea veramente tipica della mistica in quanto esperienza dell’Uno: quella dell’identità tra natura e spirito, per la quale “la natura è lo spirito visibile, lo spirito è la natura invisibile”»[114].
Nella “filosofia positiva” dell’ultimo Schelling, si riprendono invece tradizioni religiose che sono impropriamente chiamate “mistiche”, e che sarebbe meglio definire “gnostiche” ed “esoteriche”: tali, ad esempio, le “potenze” di Dio (di cabalistica memoria), o le “età del mondo” (derivate da Gioacchino da Fiore). Qui si pone un problema di un certo rilievo, per la mistica, come osserva Vannini[115]: infatti, ogni teologia e ogni gnosi, con il suo presunto sapere di Dio, negano radicalmente quell’identità di essere e sapere di cui consiste l’esperienza spirituale, nella quale al “nulla sapere” di Dio come altro corrisponde la generazione del Logos, come abbiamo visto.
1.4.7) Hegel e la Fenomenologia dello spirito
Limitatamente alla nostra ricerca, l’esperienza dello spirito, in Hegel (1770-1831), descritta nella sua opera più importante, la Fenomenologia dello spirito, è esperienza di una vita che non cede alla finitezza.
La perdita di ogni oggettività, spiega Vannini[116], l’estremo distacco da ogni sapere e valore, indicato dalla morte di Dio, è, come in Eckhart, quell’atto supremo di onestà e coraggio che l’intelligenza deve compiere affinché si apra il regno dello spirito: al volontario annichilamento della volontà personale, corrisponde l’esperienza di una Presenza assoluta. E lo spirito, il distacco non sta in opposizione al mondo: è, anzi, un sereno “sì” detto a tutte le cose, anche se superiore a tutte, non catturato da nessuna.
In Hegel, sulla linea di Eckhart, si delinea, come rileva Vannini[117], un concetto di spiritualità che non è di tipo monastico, separata dall’elemento mondano, limitata dal pensiero del male che, in realtà, secondo le parole di Vannini, è un non-pensiero.
Il male, che risiede nell’incomprensione del Tutto e, conseguentemente, nella volontà di conservare la finitezza, in opposizione ad altre finitezze, ancora nel sentimento, prosegue Vannini[118], è male non solo teoreticamente e moralmente, ma anche nel senso di malattia: la salute si ha quando tutto l’elemento psichico è visto nella sua finitezza ed è perciò superato.
Ma, Vannini ci mette in guardia[119], qui non si parla di “salvezza” dell’anima, poiché l’anima deve, piuttosto, ritrovare il giusto equilibrio.
1.4.8) Schopenhauer: Il mondo come volontà e rappresentazione
Uno dei più accaniti avversari dell’idealismo, e di Hegel in particolare, vale a dire Schopenhauer (1788-1860) prende spunto anch’egli, significativamente, dalla mistica tedesca.
In particolare, spiega Vannini, «una delle ragioni della sua avversità per Hegel sta[...] nel consapevole inserirsi di quest’ultimo nella tradizione cristiana, mentre Schopenhauer si sente un uomo libero, fuori da ogni religione. Eppure [...] manifesta una comprensione del cristianesimo e una stima per la sua mistica che pochi altri hanno avuto»[120].
La riflessione schopenhaueriana parte dalla consapevolezza che il mondo è una nostra rappresentazione per giungere ad affermare che, in quanto l’uomo ha un corpo, è un individuo, la rappresentazione è comandata dalla volontà e la sua oggettivazione varia a seconda del variare del volere. La volontà, in quanto tale, è sempre egoistica, volontà di vivere e di conservarsi, e porta con sé la sua pena.
Poiché è inutile cercare salvezza nella volontà, il filosofo propone un itinerario di liberazione dalla volontà. Anzitutto, prosegue Vannini[121], la liberazione proviene dall’arte, in quanto pura contemplazione disinteressata: nel momento estetico, tuttavia di breve durata, l’oggetto viene visto privo di ogni relazione.
Una vera liberazione inizia sul terreno morale, morale che ha per fondamento la “compassione”, ossia la conoscenza del dolore altrui, ma con una autentica compartecipazione umana.
Ma non basta: occorre una completa negazione della volontà, con un atto di vera a propria noluntas, che distrugga alla base l’Io. Ed è proprio su questo punto cruciale che il pensiero di Schopenhauer si incontra, nei suoi tratti essenziali, con la mistica cristiana, come ben rileva Vannini[122]. Il passaggio dalla necessità alla libertà avviene grazie alla conoscenza che, come insegna Eckhart, è distacco e distacca.
1.4.9) Nietzsche: egoismo e sublimazione
La filosofia di Nietzsche (1844-1900), che, procede anzitutto da uno scavo nel profondo dell’anima, alla ricerca dei più egoistici moventi della volontà, come proponeva Schopenhauer, ma va oltre, nel senso che riconosce nell’ascesi l’estremo della volontà di potenza e nella noluntas una forma anch’essa particolarmente raffinata della volontà.
Una volta esperita l’impossibilità di penetrare negli abissi dell’amor proprio, a Nietzsche si apre davanti la fine di ogni pretesa di essere, di sapere, di valere e, insieme, l’accettazione e l’amore per tutte le cose. Così, prosegue Vannini[123], il filosofo tedesco si incontra con alcune delle caratteristiche essenziali della mistica, in primis il distacco dall’io e dal concetto di sostanza, derivati, ambedue, dalla paura del divenire e dalla volontà di permanenza e conservazione.
Questo distacco, come si è visto, non può avvenire senza la liberazione da tutti i legami, compreso, aggiunge Vannini[124], il concetto di Dio (visto come simbolo di ogni vincolo), che può avvenire solo in riferimento all’Assoluto, in virtù del quale tutto diventa luce e il presente diventa eterno.
Altro elemento in comune con la mistica, rileva Vannini[125], è l’amor fati, che è espresso nella teoria nietzschiana dell’eterno ritorno: amore per tutto ciò che è, visto nella sua bontà e bellezza.
Ora, il rapporto di Nietzsche con il cristianesimo è complesso e, per evitare malintesi, è bene distinguere tra la polemica contro la morale cristiana e la Chiesa, e il rispetto per la figura dell’uomo Gesù, oltre che per il Suo insegnamento, opposto a quello della Chiesa.
Se passiamo alle forme della mistica contemporanea, profondamente influenzate dalla cultura dei nostri giorni, notiamo che, accanto al permanere delle tradizionali esperienze devozionali cristiane, assistiamo al diffondersi di influenze orientali, o orientaleggianti, spesso piegate, come rileva Vannini, al consumismo occidentale e ancor più a forme sincretistiche di scarso valore, tutte improntate all’utilitarismo psicologico, e che valgono solo come testimonianza del disagio dell’uomo contemporaneo.
Tra le molte figure che si potrebbero prendere in esame quali mistici del XX secolo, sono particolarmente rilevanti quelle di Ludwig Wittgenstein (1889-1951) e di Simone Weil (1909-1943).
1.4.10) Wittgenstein e l’”ineffabile”
Wittgenstein mostra come la scienza, la tecnica, la cultura positivistica siano incomplete. Anche se la religione tradizionale non è in grado di offrire risposte adeguate, l’intelligenza trova comunque da sola la via che egli stesso definisce das Mystische, “il mistico”: così, infatti, il suo capolavoro, il Tractatus logico-philosophicus, definisce l’“ineffabile” come un sentire il mondo sub specie aeterni. La vita nel presente ci offre un’intuizione estatico-estetica del mondo, nella quale, come rileva Vannini[126], scompare il soggetto pensante e l’Io si comprende a un livello più elevato di realtà, dove la sua vita e il mondo sono un tutt’uno.
In questo contesto, il compito della filosofia stessa, quanto mai importante, è quello, chiosa Vannini[127], di portare alla completa comprensione di tutte le nostre proposizioni, dell’intero nostro linguaggio, che è sempre dotato di senso. Tale comprensione significa, spinozianamente, la soluzione dei problemi, riportati tutti al relativo, ossia la liberazione dalla tirannia dei contenuti.
1.4.11) Weil e l'universalismo mistico
L’“inattualità” è uno dei molti tratti che accomunano due personalità, peraltro così diverse come quelle di Wittgenstein e di Simone Weil.
Quest’ultima, della quale abbiamo parlato all’inizio del capitolo, vede, nel mondo contemporaneo, il dispiegarsi della forza, ossia dell’alienazione, vista come lontananza dal bene, che è Dio. A ciò si è arrivati, in particolar modo, attraverso il cristianesimo, che ha fatto propria l’idea di un Dio-Forza e ha altresì imposto la convinzione, come scrive Vannini, che la forza «sia il valore supremo, quello che si deve adorare e perseguire»[128].
Nondimeno, per Simone Weil, il cristianesimo, ricondotto alla sua fonte greca (e non ebraica, come riteneva Nietzsche), ossia alla sua verità, si configura come la pura e semplice apertura al soprannaturale, alla grazia, senza l’affermazione di qualsivoglia contenuto o credenza mistificante, capace di colmare (apparentemente) i vuoti: a tutto questo non si può giungere, però, senza l’amor fati e la soppressione dei legami dell’Io.
Capitolo 2
Mistica e filosofia: il Logos
2.1) Premessa: l’importanza di Platone
Come premessa al capitolo, e anche al fine di prevenire obiezioni metodologiche, è bene far presente che Vannini, nell’esporre le sue concezioni filosofiche riguardanti la mistica, procede attraverso una graduale esposizione del pensiero di filosofi e filosofe che ritiene essere i capisaldi della rivalutazione del Logos e del distacco, principi cardine a suo avviso di ogni esperienza mistica.
Come vide Simone Weil, Platone non è solo il coniatore del termine “teologia”, ma, sottolinea Vannini, il fondatore della mistica occidentale: basti accennare al Teeteto, al Convito, al Fedone. Infatti è chiaro, in Platone, che, da un lato, non vi è un sapere positivo su Dio, poiché Egli non si mescola agli umani, e che, dall’altro, Amore e Ragione sono mediazioni tra Dio e l’uomo, per cui, con l’aiuto dell’amore e della ragione, l’uomo può compiere il cammino che lo porta a rendersi simile a Dio. Questo cammino è la filosofia, che, per Platone, è esercitarsi a morire, ossia quella purificazione consistente nel separare il più possibile l’anima dal corpo, affinché essa possa raccogliersi in se stessa. Questo distacco e questa separazione dell’anima dal corpo si chiama morte.
Il cammino di purificazione è descritto dettagliatamente nel Convito: si tratta di progredire in Amore e Ragione (dialetticamente uniti), vedendo, in particolare, sempre il relativo di ciò che ci si presentava come assoluto.
La filosofia, pertanto, consiste essenzialmente nella dialettica, il cui elemento essenziale è la negazione, la confutazione di tutti i contenuti: il distacco è, infatti, un’operazione intellettuale e morale al contempo, che richiede la dissoluzione di tutti i contenuti, senza la quale si resta ancorati al particolare, come abbiano accennato precedentemente.
Si noti la conclusione di Vannini sulle orme di Platone: «Il cammino della filosofia, l’esercitarsi a morire, per rendersi simili a Dio (per quanto è possibile), rende felici, qui ed ora, in questa vita, [poiché è un] approdo alla terraferma. [...] In questo vuoto, che è la “morte” cui il filosofo si esercita, non si ha “conoscenza di Dio” come conoscenza di un Altro, [...] bensì uscita da sé ed unione all’Uno»[129]: questa è la vera filosofia.
2.2) Margherita Porete: umiltà e distacco
Al culmine della civiltà cristiana, in pieno Medioevo, troviamo questo libro straordinario che è lo Specchio delle anime semplici, nel quale, per Vannini, giunge a compimento il meglio della tradizione spirituale d’Occidente. Ne sottolineiamo i punti principali.
L’inizio del cammino, in cui Amore, Fede, Ragione, co-operano, è con l’umiltà, ossia con la conoscenza della propria sottomissione alla necessità, e quindi distruzione di tutto il determinato; solo così si potrà diventare la cosa stessa. Essenzialmente, si tratta di spogliarsi della propria volontà, dell’accidentalità, attingendo l’universale, tutto comprendendo, nell’indifferenza a tutte le cose. Il non-sapere e il non-volere sono alla base della condizione dell’anima nella non-alterità dell’essere. Il sapere, infatti, è sempre un desiderio, un tendere verso qualcosa e, al contempo, un porre alterità verso di esso.
E la Scrittura?
Vannini è molto chiaro: «Nel fondarsi sulla Scrittura v’è l’atto di menzogna e di malizia più radicale e più grande di quanti si possano fare: la menzogna è nel porre come assoluto ciò che, in realtà, è determinato, “dimenticando” per così dire il lato della finitezza»[130]. La Scrittura costituisce, semmai, un gradino iniziale, dopo il quale bisogna camminare con le proprie gambe, proprio per non restare nella schiavitù dell’alterità.
Ci si potrebbe chiedere cosa vi sia di specificamente cristiano in questo cammino. Infatti, si può fondatamente ritenere che il percorso di Margherita (come poi quello di Eckhart e di tanta mistica simile) sia cristiano accidentalmente, ovvero sia possibile, in parallelo, nell’ambito di una spiritualità di tipo neoplatonico. Al contempo, però, è bene riconoscere il tratto intimamente cristiano che contraddistingue questa mistica e che ne fa un unicum anche dal punto di vista filosofico.
La componente cristiana, su cui ci si interroga, è presente, in una prima fase, sotto forma di imitatio: «L’imitazione di Cristo compare nel cammino della virtù, che va compiuto fino in fondo, ma poi alle virtù bisogna dare congedo, perché lo spirito divenga signore»[131].
Margherita, tuttavia, va oltre, e afferma esplicitamente (come farà Eckhart e altri dopo di lui) che è necessario abbandonare l’immagine umana di Cristo, dal momento che l’amore di Cristo uomo impedisce l’amore di Dio. Di più, occorre liberarsi di ogni immagine determinata di Dio, di modo che il pensiero, l’opinione e la credenza non possano avere più presa alcuna sulla nostra anima: l’anima deve, infatti, stare da sola, senza nulla volere, sola con se stessa.
Scendendo nel dettaglio, Margherita asserisce che non si deve cercare Dio con i sacramenti, le penitenze, i pensieri e le opere: tutte queste pratiche non producono, per Margherita, quel necessario distacco che è la vita dello spirito, bensì producono una maggiore auto-affermatività dell’Io.
Si comprende, così, la verità delle parole che Giovanni mette in bocca a Gesù al momento del suo commiato dai discepoli: «è necessario che io me ne vada, ma, andandomene, manderò a voi lo Spirito, che vi guiderà a tutta la verità»[132].
Su questa linea, a Margherita è chiarissimo, come lo sarà ad Eckhart, che lo Spirito è dato solo a coloro che vivono nel Figlio, ossia riescono a vedere il relativo e l’umano dentro l’Assoluto stesso: tutta la realtà, infatti, anche la più umile quotidianità, dischiude il divino, che si offre senza sforzo e senza perché all’intelletto dell’anima semplice, ovvero nobile, la quale, proprio nel distacco, lascia essere l’essere.
Ma che cos’è la vita dello spirito, se non il primato della conoscenza, ovvero del distacco, osserva Vannini, e, in ultima analisi, la filosofia stessa, nel significato più nobile della parola?[133]
2.3) Meister Eckhart
Il precetto dell’Apollo delfico (conosci te stesso, e conoscerai te stesso e Dio) può essere considerato fondante anche per l’insegnamento del già citato Meister Eckhart: esso, infatti, si muove intorno a due poli: l’anima e Dio.
Il domenicano tedesco, in particolare, non insegna a conoscere l’anima e Dio, ma a generare il Logos, ossia a diventare quello che si è, Logos, appunto, spirito, e dunque a vivere la vera vita, che è la vita dello spirito. Come in ogni grande maestro, non vi è, in Eckhart, un conoscere separato dall’essere, dalla vita; pertanto, non sono essenziali i libri, nemmeno i testi sacri, per quanto il domenicano abbia nei confronti della Scrittura tutto il rispetto che un uomo del Medioevo poteva avere, e al commento della Scrittura stessa abbia dedicato buona parte del suo lavoro intellettuale.
Il cammino della conoscenza, dunque, è un itinerario di vita, per la conoscenza di noi stessi, della nostra anima e, in particolare, della sua vera realtà: il suo fondo.
2.3.1) Il “fondo” dell’anima
L’espressione Grund der Seele, “fondo dell’anima”, è una delle tante che Eckhart usa per indicare la realtà più profonda e più vera dell’uomo, ove si trova la sua essenza, molto diversa dalle determinazioni accidentali (famiglia, ambiente, cultura e, per Vannini, religione, per fare un esempio). Ora, un uomo onesto e vero non ha difficoltà ad ammettere che il proprio io psicologico è determinato da elementi inessenziali, ossia da fattori ambientali, culturali, ideologici, come accennato.
Si impongono qui, seguendo Vannini, due considerazioni: «La prima è che nessuno trova se stesso in quanto anima, [a causa della mutevolezza della] psiche, [che è un] continuo rimandare da un contenuto ad un altro, senza posa, [...] mentre noi, nel profondo del nostro essere, abbiamo fortissimo il senso di una realtà nostra che permane immutata, al di sotto di tutti i mutamenti psicologici, anzi, indifferente ad essi. […] La seconda considerazione è che questo terreno impermanente, insieme ai pensieri che incessantemente produce, [...] è esso stesso male e dolore»[134] poiché è l’abisso della molteplicità in cui si naufraga e, anzi, si affoga. Come si può trovare il fondo dell’anima, in queste condizioni?
Chiaro che occorre trovare una terra ferma, un fondamento, che non muti al mutare delle situazioni e degli stati d’animo. Assurdo, come scrive Vannini, pensare di trovare questo fondamento nella costruzione intellettuale, poiché essa «è sempre dipendente da qualcosa di determinato e cade in pezzi appena quel qualcosa scompare»[135].
Si dovrà pertanto ricorrere alla rimozione, alla purificazione dall’accidentale, rimuovendo ciò che è inessenziale e trovando così il “fondo” dell’anima, immutabile e non determinato da alcunché.
Una conseguenza importantissima, di carattere ontologico, che si deduce subito è che, in quanto immutabile ed indeterminato, il fondo dell’anima è purissimo essere e, dunque, nulla, come scrive Vannini, «in perfetta corrispondenza a quell’essere purissimo e indeterminato – e dunque anch’esso nulla – che è Dio»[1365].
Il fondo (Grund) è dunque un abisso (Abgund) senza fondo, soprattutto in senso dinamico, ovvero in quanto dobbiamo evitare di farlo valere appunto come fondamento, altrimenti sarebbe un elemento psichico determinato, come gli altri.
2.3.2) Il distacco
La spoliazione dall’accidentalità dell’io psicologico deve essere completa: si deve esercitare il distacco non tanto nell’esteriorità, quanto nell’interiorità, eliminando l’autoaffermatività e la volontà personale, in quanto espressione della determinatezza separata dall’universalità, come scrive Vannini.
Infatti, tutto quel che è personale, è male: Eckhart prosegue in quell’analisi psicologica che già il mondo antico aveva compiuto, e mette in luce le radici egoistiche del nostro agire, anche quando esso sembra avere fini buoni. In realtà, dove c’è un fine, c’è un “perché” e, quindi, l’azione non èdisinteressata e pura. Anzi, Eckhart va ben oltre, asserendo che, come non vi sono opere “buone”, non vi sono neppure luoghi più sacri di altri: nel mistico tedesco vive la concezione platonica secondo cui il bene è al di là dell’essere.
Su questa linea, l’insegnamento eckhartiano del distacco, implica la rimozione di ogni “immagine” e di ogni presunto “sapere”, che viene compreso nella sua finitezza, e va rimosso. Anche le rappresentazioni bibliche, i disegni salvifici, come scrive Vannini[137] chiosando Eckhart, devono sparire, in quanto frutto di ideologia, variabile a seconda dei tempi e delle situazioni, senza contare che, in quanto ponendosi come verità relativa a Dio, costituiscono una vera e propria bestemmia, facendo di Dio un oggetto finito.
Qual è dunque la dimensione propria del distacco? La dialettica, nella quale tutti i contenuti sono visti nella loro verità relativa e nella loro assoluta falsità e infondatezza.
L’uomo nobile, utilizzando la terminologia eckhartiana, è l’uomo del distacco.
In relazione al distacco, Eckhart usa il termine Demut, “umiltà”, ma non si tratta di passività, bensì della conoscenza del dominio della necessità. Dunque, soltanto l’uomo nobile è capace di umiltà, perché è colui che non cede e non consente a tale dominio: solo muovendosi al di sopra dei contenuti, come scrive Vannini[138], può sfuggire al determinismo e all’utilitarismo che gli è necessariamente legato. Centrale, peraltro, in Eckhart, è il rapporto distacco-giustizia. Non si può sfuggire all’utilitarismo, alla volontà di autoaffermazione dell’io psicologico, che in rapporto all’Assoluto, ossia in rapporto a una grandezza sempre trascendente: solo per essa è possibile il distacco, e solo per essa è possibile giungere all’universalità, ovvero all’impersonalità, superando l’io psicologico, vivendo nella giustizia e in Dio, che è la giustizia stessa.
2.3.3) La fede
Chiara è l’equivalenza, nondimeno, tra distacco e fede. Fede, specifica Vannini, intesa non «come credenza, […] [ma come] rimozione di ogni determinato e, in questo senso, negazione di ogni contenuto religioso»[139].
Il punto fondamentale di tutto questo, che deve essere ben presente, è che la nostra stessa anima, con il distacco, si è fatta nulla, e così giunge all’Uno, ove non c’è più alterità e non si può più vedere l’Altro; così, seguendo Vannini[140], Dio-Uno si configura come nulla, presente ovunque e in nessun luogo.
Il distacco e la fede sono possibili, peraltro, in ogni situazione e su ogni situazione: niente condiziona il fondo dell’anima, che rimane impermeabile alla contingenza spazio-temporale.
2.3.4) La grazia
L’esperienza di profonda gioia e libertà che è propria del distacco, è quella che il mondo cristianochiama grazia. La grazia, sempre seguendo il commento di Vannini ad Eckhart, «appartiene al solo intelletto, non alle potenze dell’anima, ma al suo fondo, ed è sconosciuta all’intelletto che sta nella sua sola luce naturale, ovvero a servizio delle cose, privo di verità e di giustizia. Solo l’intelletto separato, ovvero, l’intelletto attivo aristotelico, è ragione e libertà, non sottoposto al determinismo, non legato all’io e ai suoi desideri»[141].
Per cui possiamo dire che questo intelletto è la grazia stessa presente in noi: non a caso, Aristotele lo chiama appunto “separato”, immortale, e ripete che giunge all’uomo dall’esterno, pur costituendo la parte più elevata dell’anima umana, ed Eckhart, dal canto suo, conferma che lo spirito è distacco, uscita dai legami spazio-temporali, ingresso nella dimensione dell’essere e, al contempo, nella vera realtà di noi stessi.
Ad ogni modo, e qui va notato il confronto, «agostinianamente, rimane vero anche per Eckhart, che si ama con l’intelligenza, e che si ama nel distacco. Non sorprende, dunque, che solo all’intelletto sia legata l’esperienza di grazia, giacché esso ed essa sono sostanzialmente amore. Solo l’intelletto, quindi, è libero e deiforme, e Dio, che è amore, è intelletto»[142].
2.3.5) L’amore
Il distacco da ogni legame spazio-temporale, da ogni attaccamento e ogni conseguimento personale, non è altro che l’amore, ovvero, «volontà di bene infinito che, in quanto tale, dimentica se stesso come soggetto e si preclude ogni fine determinato»[143]. L’anima nobile, infatti, ossia l’anima che ama infinitamente, è totalmente disappropriata di se stessa e del proprio volere, tanto da poter dire, paradossalmente, che non ama e non vuole nulla. Nello specifico, la fine della volontà personale significa la fine dell’amore in quanto desiderio; ma, se questa fine avviene per la traboccante ricchezza dell’amore stesso, l’anima cessa di amare in quanto diviene essa stessa Amore, e vi è identità tra amante e amato, tra l’anima e Dio.
2.3.6) Lo spirito
Nel distacco, in quanto somma di intelligenza e amore, si passa dall’accidentale psichico all’essenziale, alla vera sostanza dell’anima, che è lo spirito; lo spirito, nello specifico, «non è un qualcosa che si conosca come oggetto, né il credere può surrogare l’essere (e perciò, come si è detto, la vera fede non è una credenza, e chi crede non è ancora Figlio)»[144].
La nozione di “spirito” diviene chiara e comprensibile solo quando si ha l’esperienza del nous, dell’intelletto attivo, distaccato, e, insieme, dell’amore infinito come volontà di assoluto bene: il concetto di “spirito”, appunto, sintetizza al meglio questa esperienza di distacco/amore. Eckhart, perciò, afferma che lo spirito è uguale al Logos e, inoltre, l’esperienza dello spirito è da Eckhart chiamata “generazione del Verbo”, nascita di Dio (che è appunto Parola) nell’anima.
2.3.7) La generazione del Verbo
La generazione del Verbo è infatti lo stesso atto di amore/distacco, essenziale e possibile in ogni istante, con quell’infinita gioia che è la gioia stessa di Dio creatore. Non si tratta di un sapere, che pone sempre nel dualismo soggetto-oggetto, e dunque nell’alienazione dall’essere. Parlare di “conoscenza di Dio”, come scrive Vannini, è assurdo: «come Dio ama se stesso in se stesso, così conosce se stesso in se stesso, e così noi conosciamo Dio solo quando lo siamo, ovvero quando lo generiamo in noi»[145].
Di fronte alla banale concezione oggettivistica del sapere come fondato sull’alterità, Eckhart fa valere (come ogni grande maestro spirituale), la coincidenza tra conoscere ed essere, poiché è proprio un generare. Nello spirito, a differenza della dimensione psicologica, non si ricerca Dio, poiché nessuno ha bisogno di ciò che già possiede, e Dio non è più alterità, bensì è Verbo che si genera in noi. Conseguenza importantissima è che il rapporto tra Dio e l’uomo non passa mai per l’esteriorità, e non conosce mediazione; a Dio, infatti, è estranea ogni mediazione, e quindi vengono esclusi libri, profeti, chiese, rivelazioni, visioni e così via: tutto ciò, come scrive Vannini[1], è esteriorità e alienazione. Il rapporto tra Dio e l’uomo è solo nello spirito.
In particolar modo, come rileva Vannini, e qui è decisivo riguardo alla concezione dello spirito, «solo la concezione trinitaria cristiana permette di pensare Dio come spirito, e, allo stesso tempo, unitas spiritus tra Dio e l’uomo, senza che ciò divenga quel panteismo che tanto spesso rozzi critici, che parlano di ciò di cui non hanno esperienza, hanno rimproverato ad Eckhart»[147]. L’esperienza della generazione del Verbo è quella di un infinito amore che investe la creatura, qui ed ora, però senza legame, senza alcun rapporto con se stesso o con qualche finalismo, dunque con assoluto distacco.
E l’opera buona? Come accennato, l’opera buona, per Eckhart, non ha bisogno di un atto esteriore: è tutta data in un atto di amore/distacco, ed è divina non perché ha Dio come cause causa o come fine, dal momento che ciò che conta è il come, non il che cosa, se vogliamo attribuire valore ad un’opera. Di più, precisa Vannini, «come non vi è opera buona compiuta per un fine diverso dall’opera stessa, così non può esservi vita divina altro che nel presente, là dove è presente lo spirito, nel suo essere amore e distacco»[148]. E Dio non è nell’alterità, bensì è in quanto Parola, Logos, generato nel fondo dell’anima, che è il fondo stesso di Dio. Logos è ciò che l’intelletto produce, ma anche l’intelletto stesso: solo in questo duplice senso, Dio è Logos.
Del resto, come possiamo generare il Verbo, se non lo siamo? E, anche ammettendo un Dio-alterità, prosegue Vannini, «la riflessione mostra che Dio stesso, nel mondo, diviene sempre intramondano, [...] e dunque storico, finito, umano. [...] Proprio la riflessione cristiana, incentrata sulla coincidenza di umano e divino in Cristo, [ci] ha reso esperti della dialettica dei due termini: ogni “divino” passa necessariamente nell’“umano”, ovvero nel finito e nel mondano»[149].
2.4) Cusano: visio Dei, Deus absconditus
Intelligente e appassionato interprete e difensore di Eckhart (e di tutta la tradizione neoplatonica), Niccolò Cusano, altro grande nome della mistica cristiana studiato da Vannini, esprime con chiarezza i migliori risultati dell’esperienza dello spirito. La sua eredità, all’interno del cristianesimo, è andata quasi del tutto perduta, si rammarica Vannini[150], con l’avvento del protestantesimo e dalla conseguente Controriforma.
Cusano rifiuta anzitutto la retorica, il ricorso alla Bibbia e alle auctoritates, e si appellaall’esperienza, rilevando, nondimeno, la facilitas dell’esperienza mistica, che proprio sull’esperienza si fonda. In secondo luogo, sgombra il campo da ogni psicologismo e da ogni visione determinata.
Visio Dei, scrive Vannini, non è «la visione di un Dio oggetto-altro, ma il vedere da parte nostra ogni cosa con gli occhi stessi di Dio»[151], il quale è l’essere assoluto di tutte le cose. Ma, dal momento che, per Cusano, Dio è absconditus, proprio Dio si rivelerà enigmaticamente, e non chiaramente, in ogni volto, fino a che non si vada al di là di tutti i volti, entrando nel silenzio e nullificando i concetti che si hanno del volto: sottraendosi a ogni visione determinata si accede allo splendore del volto di Dio. Questo, però, precisa Vannini, «non significa affatto non vedere nulla, ma significa rientrare in noi stessi, essere padroni di noi stessi, ponendo fine alla passione, alla contrazione»[152], ossia ascoltare il Verbo che incessantemente parla nell’anima, e continuamente risplende nella ragione.
Nondimeno, Dio sta al di sopra della verità e al di sopra di ogni ascesa dell’intelletto, come già Eckhart aveva affermato; non vi è accesso a Lui se non attraverso la coincidentia oppositorum, via che appare impraticabile ai più. Nello specifico, operando un confronto, «la logica dialettica della generazione del Verbo in noi, in cui generante e generato coincidono – è Dio che genera, ed è Lui il generato –, quale si affaccia nel De Trinitate agostiniano e quale Eckhart ha portato a compimento, si ripropone in queste pagine»[153]. Pertanto, Dio è, per un verso, invisibile, ma, per un altro verso, è visibile, in tutte le cose che sono, e che sono proprio in quanto “vedute” da Dio.
Con altrettanto grande chiarezza, Cusano nega, su questo filone, la dottrina biblica della creazione (fondamento di tutta l’alienazione) per la quale il mondo e l’uomo sono altro da Dio. Inoltre, prosegue Cusano, determinare Dio, farlo oggetto di azioni e portatore di attributi, costituisce la bestemmia più grande, poiché impedisce la generazione del Verbo in noi. Ragion per cui, ci si potrebbe chiedere, come può l’alterità essere principio dell’essere?
Ma c’è un ulteriore problema: posto che l’essere di Dio, che, come sappiamo, è infinità in senso assoluto e ha rapporto con l’essere di tutte le cose, come conciliare finito ed infinito, Dio e il finito?
La risposta di Cusano è chiara: mediante l’unità e trinità di Dio.
Riferendosi poi al problema principale della mistica (amore o intelligenza?), Cusano asserisce che non vi è amore senza intelligenza. Come spiega Vannini, «amore e intelligenza sono lo stesso; lostesso atto del negare, proprio dell’intelletto, è quello che distacca dal molteplice e conduce all’Uno, unico oggetto di amore»[154]. Del resto, per Cusano, l’insegnamento di Cristo ha alla base due cose soltanto: la fede e l’amore: mediante la fede, scrive, l’intelletto può accedere al Verbo e, mediante l’amore, si unisce a Lui.
2.5) Ibn ’Arabi: l’unità
Sarebbe senza dubbio piaciuto a uomini come Eckhart o Cusano – che scrisse il De pace fidei e la Cribratio Alchorani, persuaso dell’intima unità di tutte le religioni – conoscere l’opera del mistico Ibn ’Arabi. Nel breve Trattato dell’Unità (o Trattato della conoscenza del Signore attraverso la conoscenza di se stessi), Ibn ’Arabi asserisce che chi conosce se stesso, conosce anche Dio, e questo conoscersi è il riconoscersi come nulla, non come essere altro da Dio, e perciò uno nell’Uno, polemizzando, tra l’altro, contro quei mistici che sostenevano la necessità di estinguere l’esistenza dell’io, dal momento che la conoscenza, a suo dire, non esige l’estinzione dell’io.
Significativamente, troviamo anche qui l’affermazione che il pensiero dell’Altro è somma sciocchezza, e suprema idolatria. Infatti, qualcosa che esistesse fuori di Dio, di per se stesso e come altro da Dio, non avrebbe bisogno di Dio, e sarebbe un secondo Dio.
Ora, quando si supera l’anima determinata da attributi limitati, si conosce davvero se stessi, e allora si vede che la nostra esistenza è la Sua esistenza. Quando si prende coscienza del nostro io limitato, ci si libera dal dualismo, e si sa di non essere altro che Dio.
Conseguenza evidente, per Vannini, «come in Eckhart e Cusano, tutte le cose sono un solo essere e il mondo è Dio stesso»[155]. L’esistenza delle cose è infatti la Sua esistenza, senza che le cose siano. E, alla banale accusa di identificare Dio con la sporcizia e con le altre cose basse dell’esistenza (la ricorrente accusa di panteismo), il filosofo risponde che il suo discorso è rivolto non ai ciechi, ma a coloro che vedono. “Cieco” è chi non conosce se stesso, e a chi non conosce se stesso, a chi non vede altro che quel che vede, a chi vede qualcosa al di fuori di Dio, non ci sono risposte da dare; ma colui che conosce se stesso, non vede altro che Dio.
Pur se sussistono similarità con la mistica germanica, sottolinea Vannini (e qui comprendiamo il senso critico di tale riferimento a questo esponente della mistica araba) «non dobbiamo però dimenticare la differenza: il filosofo arabo supera sì la biblica alterità di Dio (Colui che crea è lo stesso di ciò che è creato, proprio come Colui che vede è identico a ciò che è visto), ma non ha la Trinità, e perciò non ha Spirito. Non si può parlare dell’Unità come unitas spiritus, e resta dunque privo di dialettica, prigioniero dei limiti del suo linguaggio»[156].
2.6) Angelus Silesius: poesia dello spirito
Altro fiore della mistica renana è il Pellegrino cherubico, un sublime fiore di poesia, il cui autore è Angelus Silesius. Qui, sottolinea Vannini introducendo questa figura, «la poesia è il frutto dello spirito, non della psiche, e perciò in essa manca ogni autocompiacimento e ogni riferimento al soggetto. Il poeta ha qui dimenticato se stesso e ogni smania di celebrità letteraria»[157], parlando proprio come un ispirato da Dio.
Nella fattispecie, l’esperienza religiosa silesiana, quale traspare da questo libro, non ha pretesa di originalità, ed è in perfetta sintonia con la sua vita: l’abbandono della confessione evangelica in cui era nato e cresciuto e la conversione al cattolicesimo significano anzitutto l’uscita dalla tirannia della morta Scrittura e il recupero della Parola viva, ossia della vita dello spirito. La Scrittura, infatti, costituisce il fondamento dell’alterità di Dio, dell’alterità dello spirito, e dunque di una religione che non oltrepassa mai lo stadio dell’oggettività, ossia dell’idolatria. Dunque, che funzione avrà la Scrittura? Propedeutica, ma mai, comunque, finale, dal momento che la cosa più importante è diventare la verità, che non è cosa che stia nei libri, dal momento che è Cristo (si veda Giovanni 14, 6).
In tal senso, il poeta parla di “diventare la Scrittura”, ossia di essere in realtà, concretamente, quello che la Scrittura può solo indicare. Diventare l’Essere, andando oltre l’alterità di Dio. La Parola che spiritualmente conta, per Vannini, chiosando Silesius, «è la Parola eterna, il Figlio: è Lui che deve essere generato in noi, poiché ogni generazione al di fuori di noi non ha importanza. Questo i libri non possono farlo e, anzi, nella misura in cui comunicano “verità”, ovvero contenuti positivi, essi conseguono l’effetto contrario, giacché la generazione della Parola, del Logos, avviene a partire dal “silenzio”, dal nulla, ovvero dall’assenza di ogni pretesa conoscenza»[158].
Alla lettura di molti libri, il poeta contrappone la lettura, se così si può dire, di quel libro vivente che è il Cristo, nel senso di una comunione spirituale con Lui, più che lettura dei Vangeli.
Nel primo libro, si trova un gruppo di componimenti che, da solo, esprime già compiutamente quelli che sono i fondamenti dell’insegnamento silesiano. Ripercorriamoli.
Anzitutto, la dissoluzione del soggetto psicologico. Non si può trovare se stessi in quanto serie di contenuti, pensieri e volizioni determinabili. Io non sono affatto questa persona che pensa questo, e vuole quello: tutte queste determinazioni sono accidentali e non costituiscono affatto il vero e autentico io. Certo, è vero che la vita determina la coscienza, ma è anche vero che io non sono quella coscienza che è determinata dalla vita: l’io essenziale, come abbiamo visto, giace nel profondo, indifferente al mutamento della vita e della coscienza. Perciò, come del resto insegnava Eraclito, non si trova se stessi se non come Logos. E questa indagine non si fa studiando, bensì diventando spirito, Logos nel Logos, Dio in Dio, come chiosa Vannini[159].
Qui, di conseguenza, la logica del discorso non basta più: secondo Vannini, «occorre una logica dialettica, in grado di superare l’apparente opposizione dei contrari: infatti mi accorgo di essere insieme finito e infinito. [...] La logica dialettica è quella della ragione-spirito: per Silesius, infatti, come per Eckhart, “quando l’anima è nella luce dell’intelletto, essa non sa più niente dei contrari”»[160]. Coincidentia oppositorum, dunque.
E solo nel distacco si può scoprire di non essere dei meri contenuti psicologici, poiché il distacco è lo spirito stesso, e nel distacco, dunque, ci scopriamo come spirito.
Di più, il poeta vuol farci capire che Dio, il quale è spirito e non può manifestarsi che nello spirito.
Senza il mio spirito (che però, non è mio in opposizione ad altri) non è presente Dio in quanto vita, ma solo in quanto idolo. Si tratta, dunque, di fare il vuoto di tutto, discendere nel nulla, ove si affossa ogni determinazione e ogni valore, fare il vuoto anche delle religioni positive, che, ad un certo punto, cessano di essere sostegno e divengono, anzi, impedimento. La generazione del Logos è solo a partire dal vuoto, dal nulla: non a caso, Gesù disse ai suoi discepoli che doveva andarsene, altrimenti non poteva giungere lo spirito[161].
È altresì interessante rilevare che il tema dell’amore è quello di gran lunga predominante nell’opera silesiana, anche nel senso che, ad esso, sono dedicati più componimenti, in tutti i libri che compongono il Pellegrino cherubico. In effetti, ogni passione ed ogni movente umano consiste di amore o ad esso si riconduce, sia pure sotto il segno negativo dell’avversione e dell’odio, per Vannini.
Memore della lezione agostiniana, per Silesius ci si trasforma in ciò che si ama: in Dio se amiamo Dio, in terra se amiamo la terra. Un amore ben ordinato è quello che è anzitutto amore del sommo bene e poi amore del prossimo come se stesso e di tutto il resto meno di se stesso. In questo senso, amare significa anche imparare a non stimare, disprezzando sempre il proprio io, che sta alla base di ogni male. L’amore vero è carità, è l’anima della fede e della stessa santità. Di grado in grado, Silesius giunge alla comprensione delle più profonde parole evangeliche: Dio stesso è amore; anzi, l’amore costituisce la Trinità divina.
Qui, però, puntualizza Vannini, «l’amore non è più una passione, non è più un sentimento determinato dal suo oggetto, ma è diventato l’essere stesso. Infatti quell’amore, che non è più passione, […] è lo stesso Spirito Santo, che su tutto soffia, senza principio né fine»[162]: è la stessa vita divina, nella quale eternamente siamo.
Amore puro, dunque, senza ricerca di altro, neppure di beatitudine e ricompensa eterna. Che significa amare Dio, dunque? Significa essenzialmente morire a se stessi, rinunziare a se stessi, e, in questa morte, “patire Dio”, ossia sperimentare, come spiega Vannini[163], la presenza di Dio in noi in modo puramente passivo, come opera non nostra, ma della grazia in noi, al punto che la nostra vita non è più nostra, ma è la vita di Dio in noi, per cui si può parlare di un “vivere Dio”, che è poi, come ricorda Vannini, l’esperienza paolina.
Chiaro che, finché permane la credenza, che è una dimensione alienante, in cui Dio è altro e limitato dai modi e dalla sua stessa alterità, non si può sperimentare la presenza di Dio e non si può vivere la vita divina nell’unitas spiritus, ciò che invece costituisce in Eckhart e Silesio, la “nascita di Dio nell’anima”, la generazione del Logos nell’anima.
Il punto di partenza per questa nascita del Figlio nell’anima è, come si è visto, il distacco. Solo nel distacco, il Verbo eterno viene generato in eterno (non una volta sola a Betlemme, o nell’eternità del seno paterno), anche nell’anima nostra; anzi, è questa il luogo della nascita di Dio.
Ripetendo una dottrina che non è solo della mistica tedesca, ma che affonda le sue radici nel profondo della Patristica, Silesius afferma che la nascita è di tre specie: quella da parte del Padre in eterno, quella da parte di Maria nel mondo, quella da parte mia interiormente, nello spirito; comunque, alla fine, si tratta sempre della medesima nascita. Nondimeno, si tratta di una duplice nascita: da parte di Dio in noi e di noi in Dio.
Come rileva Vannini[164], nel mondo latino è di impronta agostiniana la dottrina per cui si conosce se stessi conoscendo Dio. Nel porre l’Assoluto la ragione si fa assoluta, ossia scopre se stessa come incondizionata e come identica a ciò che ha posto. Agostino afferma, infatti, che il Verbo è identico nella sua concezione e nella sua nascita, quando la volontà si riposa nella conoscenza, cosa che accade nell’amore delle realtà spirituali. Perciò il Verbo è conoscenza unita all’amore. Quando lo spirito si conosce e si ama, il suo Verbo gli è unito tramite l’amore e, poiché ama la conoscenza e conosce l’amore, il Verbo è nell’amore e l’amore nel Verbo e tutti e due nello spirito che ama e proferisce il Verbo, come scrive Vannini[165]. Per il fatto che si conosce, genera una conoscenza uguale a sé, poiché la sua conoscenza non è quella di un’altra essenza.
Il concetto della generazione del Logos, come precisa Vannini, «non ha [...] niente di “mistico” [...]. Si tratta invece della potenza della ragione pienamente dispiegata, là dove il cristianesimo è il miglior erede del pensiero classico: dunque, di un concetto e di un’esperienza filosofica, intendendo filosofia nel suo senso più forte e pieno [...] come attività che [co]involge tutta la vita»[166].
2.7) Hegel: soggetto e dialettica
2.7.1) Morte mistica
Dopo Silesius, seguendo l’itinerario di Vannini, l’apice della tradizione spirituale greco-cristiana in Occidente è rappresentato da Hegel. La filosofia hegeliana, infatti, segna il compimento dell’esperienza della mors mystica, esperienza non certo esclusivamente cristiana (ricordiamo le radici platoniche); e, del resto, a partire dalle antichissime religioni misteriche fino al concetto neoplatonico di “scintilla dell’anima”, passando per Aristotele e lo stoicismo, è chiaro che lo spirito non può emergere se prima non si rimuove lo psichico e, quindi, senza “morte dell’anima”.
La mistica tedesca si mostra maggiormente aderente all’ispirazione neoplatonica, dal momento chesi tiene fermo il principio che deve trattarsi di morte della volontà, di morte a se stesso e ad ogni legame, ivi compreso quello religioso ad una immagine determinata di Dio. Questo volontario morire, come abbiamo visto, va inteso come volontaria rinuncia alla propria volontà, nella convinzione che ogni sentimento, anche e soprattutto quello religioso, costituisce legame dell’io e passione, e impedisce così una vera morte della volontà.
La morte mistica, l’annientamento di tutto l’io psicologico, compiuto sotto il segno del distacco, costituisce quindi l’inizio della libertà. Infatti, è l’atto dell’intelligenza che si libera dal condizionamento spazio-temporale, da ogni legame, ed assume quella forma “separata”, come scrive Vannini, che anche Aristotele riconosce al nous poetikòs. Di qui il rigoroso primato dell’intelletto sull’essere che Eckhart sostiene, come si è visto.
L'uomo può tuttavia distaccarsi da se stesso, abbandonare la propria “particolarità” e liberarsi dal volere personale solamente perché è già libero nel suo fondo. Infatti, l’uomo è, al suo fondo, quella scintilla animae che sola è libera, e che gli consente la libertà. Il distacco dall’accidentale psicologico non è altro che il portare alla luce l’elemento di libertà che è al fondo dell’anima: diventare ciò che si è, purificandosi dalle scorie dell’io.
L’uomo così pervenuto a se stesso è l’uomo libero, senza Eigenschaft, senza più l’accidentale psicologico. Vannini sottolinea, giustamente, per evitare fraintendimenti, «che l’Io universale, in cui si effonde l’anima, è assolutamente impersonale, giacché ogni distinzione personale deve essere scomparsa, se l’anima deve giungere nel suo fondo»[167].
Ora, l’idea della morte mistica come atto proprio della vita morale è il cuore della filosofia hegeliana della religione e del diritto, poiché questo atto di volontà costituisce l’esistenza religiosa e morale. Già negli anni di Berna, quando venne a contatto per la prima volta con Eckhart, Hegel ha contrapposto la dottrina mistica della “scintilla divina” e dell’unitas spiritus a quella, predominante, che vedeva l’uomo solo come elemento della natura. Ma è nella Fenomenologia dello spirito che vengono a maturazione le riflessioni degli anni giovanili.
Consideriamo, ad esempio, la figura del servo[168]. Dal momento che abbandona il proprio io perché sottomesso al signore, rappresenta l’inizio della saggezza, dal momento che sottomette l’egoismo personale. Qui è evidente l’eco della meditazione cristiana sull’umiltà come virtù essenziale, la sola che può far uscire dal mondo del determinismo naturale e portare nella dimensione della grazia, ossia dello spirito. In tal senso, è vero anche, come scrive Vannini, chiosando Hegel, «che la sofferenza e la sottomissione [...] possono essere l’inizio della sapienza. Lo sono infatti se rimane forte l’orientamento all’Assoluto, il cui essere si sostituisce a quello, relativo, del povero e piccolo io psicologico; ma non lo sono se viene meno tale orientamento, e allora rimane solo la strada del ressentiment, la creazione delle morali di compensazione, e dunque la nascita di un uomo assai meschino – come ben vide Nietzsche»[169].
L’uomo diviene veramente libero solo quando la naturalità del volere viene superata e la singolarità naturale si concilia con la razionalità; è chiaro, però, che tale conciliazione avviene solo in quanto l’uomo rinuncia alla volontà particolare: viene ucciso non l’istinto naturale in quanto tale, ma il contenuto del volere viene eticizzato e così superati la separatezza e il male. Questa autoalienazione dello spirito, tramite la quale esso si perde in quanto natura, è chiamata, da Hegel, “morte”. Ma anche il suo giungere a se stesso è una forma di morte, la negazione della negazione, l’annichilimento.
Hegel, nondimeno, insiste sull’aspetto prevalentemente pratico di questo processo, che passa essenzialmente per la volontà, come abbiamo visto, e che ha come primo momento la devozione. Infatti, nella devozione, il soggetto rinuncia a se stesso secondo le proprie particolarità, in modo che il suo oggetto divenga l’universale. La devozione, come scrive Vannini, «è una forma di “abnegazione dell’anima”, che trova compimento [...] nel suo oggetto, in Dio. [...] La devozione [...] è già l’immergersi della coscienza nell’essenza assoluta, superando ogni separatezza»[170].
Va sottolineato «che tutto ciò è possibile in quanto la devozione è costituita dall’elemento fede, inteso nel suo senso fiduciale, quale amore verso un Assoluto personale, termine di riferimento della dedizione»[171].
L’elevazione dello spirito dalla sua volontà naturale è negazione del volere particolare, e può perciò essere chiamato “morte”. Ma non è con la propria forza che si esce dallo psicologico: è Dio stesso che compie il supremo atto di amore/distacco, perché questo è lo spirito, e non v’è spirito dell’uomo diverso o separato dallo spirito di Dio. Perciò, nella Fenomenologia dello spirito, la forza che guarda in faccia il negativo dell’essere, senza liquidarlo sbrigativamente come falso o cattivo, viene chiamata Zauberkraft, forza magica: infatti essa sfugge alle leggi proprie della realtà naturale e opera qualcosa di miracoloso, di magico. Tale forza, come scrive Vannini, «è la grazia, essa stessa spirito di Dio, non meno che spirito dell’uomo»[172].
Ora, tolta ogni alterità dell’essere, ogni oggettivismo, ogni dualità tra conoscente e conosciuto, il sapere dello spirito è lo spirito stesso. Esso, spiega Vannini, «non è solo un contenuto della coscienza, ma reale (wirklich) spirito; e lo è nel suo e per il suo essere appunto spirito, ovvero movimento, nel suo andamento trinitario, da una realtà sempre presente, e che perciò si pensa astrattamente immobile, a una che entra nella finitezza, e che perciò deve attraversare il negativo e la morte, a quella realtà che da entrambe le prime è costituita, e insieme entrambe le costituisce»[173].
2.7.2) Il male
Proseguendo nel suo linguaggio preso direttamente dalla tradizione religiosa, Hegel afferma che la comprensione dello spirito per noi si ha quando si perdona il male, e così si abbandonano quella unilateralità e immutabilità che costituiscono la dimensione rigida della volontà naturale, della finitezza, col suo pensiero del male. Allora, ciò che appariva astrattamente opposto (l’altro, il due, che è sempre il male) viene riconosciuto come uno e medesimo: ciò appare palese alla coscienza religiosa, se essa dimentica se stessa nell’essenza assoluta di Dio. Dunque, commenta Vannini in proposito, «la condizione prima per essere nell’essere è il superamento di quella dualità che è data dal pensiero del male – il due (dys) per eccellenza. [Occorre liberarsi] di quel dualismo di fondo che è sancito dalla Bibbia, in cui da una parte c’è Dio, l’essere (cfr. Esodo 3, 14) e, dall’altra, in posizione ovviamente inferiore, il mondo e l’uomo. In questa prospettiva permane sempre il due, e dunque il male. Perciò nella Bibbia, procede essenzialmente e strutturalmente l’alienazione generale del nostro mondo, con i suoi piccoli uomini incapaci di comprendere il tutto, e dunque vittime sempre del ressentiment»[174].
Tuttavia, come abbiamo visto, i grandi filosofi del logos, cristiani o no, hanno sempre riproposto la corretta visione del problema: inesistenza del male in senso ontologico, comprensione del tutto e della sua unità. In Hegel ritroviamo tutto questo. Già l’importantissima Prefazione alla Fenomenologia dello spirito è tutta impostata sulla necessità di comprendere la verità come il tutto, ossia di superare il pensiero del cattivo, e del falso suo correlato. Questa comprensione conduce allo speculativo, ossia al dialettico, allo spirito.
La verità come tutto, precisa Vannini, con riferimento a Spinoza, «non va intesa solo come sostanza, alla maniera spinoziana, giacché in tale concezione va a fondo l’autocoscienza; va intesa altrettanto come soggetto, e soprattutto [...] come movimento, come spirito. Bisogna sottolineare che il soggetto di cui parla Hegel non è il piccolo io psicologico; anzi, questo è la finitezza che deve sparire, proprio perché si comprenda il vero come l’intero: è impossibile, infatti, questo pensiero là dove permanga un centro di interesse particolare»[175].
Parallelamente, il filosofo tedesco sottolinea l’importanza dell’elemento riflessivo, per sé, che sta a significare il momento della consapevolezza, della negazione, in cui l’oggettività è posta, e poi anche superata, riflessa in se stessa. Occorre sempre riportare tutto quanto al soggetto, inserire il negativo in ogni elemento della coscienza: infatti, se un pensiero non ha al suo interno il negativo, esso è precisamente il male dell’affermatività non dialettica, non in grado di comprendere, spiega Vannini[176], l’opposto.
Contro la superficialità di coloro che pensano alla verità come esprimibile in un giudizio, in una proposizione, Hegel ribadisce che la natura della proposizione, in generale, viene distrutta dall’elemento speculativo. Per la precisione, secondo Hegel, la proposizione esprime ciò che il vero è; tuttavia il vero è essenzialmente il movimento dialettico, il cammino che produce se stesso, che si spinge oltre e rientra, poi, in se stesso.
Lo speculativo è ciò che i medievali chiamavano mistico; per cui ci è chiara l’ispirazione hegeliana:il procedere che produce se stesso è quello che, solo, ha vita, non prendendo movimento da altro, poiché è lo spirito; in particolare, Vannini ribadisce che «il sentimento [è] il legame al soggetto psicologico; è esso che costituisce l’interesse personale, opposto all’universale; in questo senso, non vi sono “buoni” sentimenti: il sentimento è sempre antiumano [...], bestiale [...]. Il sentimento è precisamente ciò che non lascia essere lo spirito»[177].
Finché si rimane nell’ambito del sentimento (dunque del particolare e dell’utilitaristico) non si esce dall’accidentale e dal determinato. Questo è avvenuto, sostiene Vannini, «per la religione, che si è così avvilita in superstizione; ma è avvenuto anche per la filosofia, quando essa ha perduto il legame con l’assoluto, è diventata solo intelletto critico – in breve, Illuminismo. La lotta dell’Illuminismo contro la superstizione, è la lotta di due potenze che credono di essere diverse l’una dall’altra, ma che, in fondo, sono invece la stessa cosa, ed infatti passano tranquillamente l’una nell’altra»[178].
La parte sulla “Religione rivelata”, sempre nella Fenomenologia dello spirito, affronta il tema del male. Essa si svolge fra due “morti di Dio”: la prima è la morte degli dèi della Grecia, al sorgere della “coscienza infelice”; la seconda è la morte di Cristo, morte del mediatore, la quale sta a significare, secondo le parole di Hegel, tanto la morte del sensibile che invano i discepoli cercavano di trattenere, quanto la morte dell’insondabile, dell’oltremondano, che, restando al di là, condannerebbe irrimediabilmente tutta l’esistenza umana; è in questa morte che la sostanza si trasforma interamente in soggetto.
A questo punto della trattazione si innesta il tema del male e del suo superamento. È necessario che vi sia il male, l’alterità, il negativo, perché vi sia spirito: il male, per Hegel, è il primo esserci della coscienza entrata in sé, ossia il fissarsi, chiudendosi ed opponendosi all’esser-altro, prescindendo così dall’automovimento ed escludendo quella negazione che è conciliazione con l’opposizione. Ora, la coscienza religiosa che rimane al livello della rappresentazione (e dunque dell’esteriorità) non può fare altro che considerare il male come un accadere estraneo all’essenza divina, ma non riesce a comprenderlo.È evidente, commenta Vannini, «che l’essere dell’uomo nel mondo è sempre un essere-così, un essere determinato e dunque, già la consapevolezza del male è un uscire dall’immediatezza della natura, che è determinata come il male, e perciò un “morire al peccato”»[179]. Volendo fare un confronto, l’insegnamento di Eraclito, agli inizi del pensiero greco, coincide così con quello di Hegel, al compimento della riflessione cristiana, nel superamento del pensiero dell’altro, del male, il che non meraviglia, poiché si tratta della stessa esperienza del Logos, che è Dio.
2.8) Nietzsche: guardare nel profondo
Dopo Hegel, il caso Nietzsche è per noi di particolare rilievo: esso mostra dove giunga un’attività di ricerca (anzi, la vita stessa come ricerca) quando è condotta con impegno totale, da filosofo, nel senso classico del termine, anche nel nostro tempo.
Nietzsche, nel suo percorso ha veramente pensato nel profondo proprio per il suo guardare senza limite, senza arrestarsi di fronte a niente, o, almeno, con la consapevolezza che l’arrestarsi a un certo punto è sempre un qualcosa di arbitrario e, dunque, da considerare con sospetto.
Nietzsche, nondimeno, riconosce onestamente che è sempre in azione l’egoismo e la volontà di potenza; infatti, spiega Vannini, «è sempre il soggetto e la sua radicale volontà di potenza a dirigere il pensiero e l’interpretazione nella direzione voluta, e in tal modo si compie sempre “ingiustizia” nei confronti delle cose, perché ad esse si sovrappone quella volontà personale che, some insegnava Eckhart, le “insozza”»[180].
Nietzsche ha l’onestà di riconoscere come la mente sia sempre collegata alla menzogna: essa è sempre un costruire immagini, rappresentazioni, che servono al soggetto e alla sua volontà di affermazione. Questo, secondo Vannini, «è l’essenziale della psicologia nietzschiana del profondo: riconoscere la menzogna radicale che è nel soggetto e in ciò che lo costituisce come tale, ovvero la volontà – poi si tratterà soltanto di ritrovare, appunto, la “morfologia” della volontà stessa, nel suo multiforme manifestarsi e, soprattutto, nel suo multiforme mascherarsi»[181].
In Umano troppo umano, testo straordinario per la profondità psicologica, nel quale stanno le radici di tante pagine nietzschiane, ma, ancor di più, un’impronta generale data a tutta l’impostazione morale e psicologica del nostro filosofo, troviamo una considerazione[182] che potremmo definire “dialettica” dell’amor proprio, capace di essere tutto e il contrario di tutto: con ciò viene spazzato via ogni tentativo di fare una “meccanica delle passioni”, come vedremo nel capitolo successivo, da Cartesio, a Spinoza, agli psicologi meccanicisti del Settecento francese, a quelli positivisti tanto avversati da Nietzsche, a Freud. Si trova inoltre la capacità di ricondurre a un principio essenziale le molte passioni, apparentemente contrastanti. La Rochefoucauld (scrittore caro a Nietzsche) chiama questo principio “amore proprio”, secondo il linguaggio della spiritualità classico-cristiana, ma, secondo Vannini, «non c’è dubbio che questa sia la volontà, o la volontà di potenza, nietzschianoschopenhaueriana»[183].
Dove sta la saggezza nietzschiana? Vannini è chiaro: nel «riconoscere il male che è al fondo vuol dire, ipso facto, scoprire un “fondo” più profondo di quel male stesso, e che sta proprio in questa capacità di riconoscerlo pienamente senza identificarsi con esso, anzi, distogliendosene per quanto possibile con tutte le forze – capacità che non appartiene dunque al regno dell’egoismo, al dominio della volontà, o dell’amor proprio. In essa, infatti, non c’è alcun interesse personale: anzi, il soggetto guarda qui a se stesso come a un oggetto-altro, indifferente alla sua sorte»[184]. Perciò il filosofo tedesco esalta sempre la potenza dell’amore, dal momento che è in esso soltanto che l’anima apprende a discernere con chiarezza e a guardare oltre di sé, a cercare un sé più alto, ancora nascosto.
2.8.1) Sublimazione
Alla discesa nel profondo corrisponde allora la scoperta dello spirito; analizzando il concetto di “sublimazione”, utilizzato da Nietzsche in senso positivo, si nota come questa scoperta costituisca un notevole arricchimento per l’uomo. Accanto a Sublimation compare, infatti, come analogo,Vergeistigung, “spiritualizzazione”: in essa il profondo diviene l’alto, il luminoso, il chiaro e nobile, e così si raggiunge la libertà dello spirito.
Lo spirito, spiega Vannini[185], è nel profondo, nella ricchezza degli istinti, dopo aver guardato senza timore nell’abisso della volontà, là dove non c’è mai verità, né libertà. Sublimazione, spiritualizzazione, significa guardare in faccia questa realtà, senza però diventare per questo vili e meschini – ecco perché Nietzsche preferisce parlare di disprezzo, piuttosto che di distacco: disprezzo significa non assoggettarsi al dominio della volontà, come è privilegio delle creature nobili. Nietzsche, peraltro, parlando esplicitamente di superamento della volontà di potenza al suo culmine, usa il termine hegeliano Aufhebung con lo stesso significato di Sublimation; e qui il discorso del filosofo tedesco diventa davvero simile al discorso cristiano della grazia, quella grazia che egli chiama “autosuperamento della giustizia”, che è privilegio dei più forti.
L’ateo Nietzsche, come si è visto, perviene dunque, proprio in quanto “spirito libero”, a quella stessa “libertà dello spirito” che è propria della tradizione classico-cristiana. La libertà essenziale è infatti, come insegna la Teologia tedesca, così cara a Schopenhauer, la libertà dal volere personale: è esso che, per eccellenza, rende schiavi. Non ci meraviglia, dunque, constatare come anche in Nietzsche l’itinerario di verità verso l’Assoluto conduca alla dissoluzione del soggetto individuale. Parallelamente al concetto di soggetto, se ne va quello corrispondente di sostanza, grazie al quale ci si attacca alle cose e le si padroneggia (o almeno si intende farlo). È la paura del divenire a far sì che l’uomo cerchi una concretezza, un essere, che dovrebbe metterlo al riparo dal fluire delle cose e dal determinismo che tutto regge. Ma tutto ciò, prosegue Vannini, è illusorio: solo arbitrariamente si fissa il principio e la fine, “ritagliando” l’essere.
Significativamente, Vannini cita l’aforisma 292 della Gaia Scienza, nel quale si ripropone la celebre frase eckhartiana: «Prego Dio che mi liberi da Dio»[186], come unico possibile fondamento di una vera morale. L’espressione apparentemente paradossale indica la liberazione da tutti i legami, la conquista della libertà dello spirito – infatti, chiosa Vannini, «Dio è il più grosso legame, il simbolo di ogni valore –; ma [l’espressione di cui sopra] indica anche che questa liberazione è possibile solo in riferimento all’assoluto: solo grazie a questo orientamento possiamo “liberarci di Dio”, ovvero mandare a fondo ogni pretesa di valore, e conquistare chiarezza di sguardo e luce»[187].
Non più schiavo della pretesa di valore, l’uomo libero nulla vuole, di nulla si preoccupa e il suo cuore è tranquillo: tutto questo rimanda all’esperienza dello spirito. Esso è il vero “profondo”, il chiaro e luminoso e, nondimeno, la dimensione della grazia, dello spirito. Lo Űbermensch nietzschiano si configura come l’uomo della grazia, come lo Edel Mensch eckhartiano – uomo dell’oltre, uomo sempre al di là della volontà propria e di ogni appropriazione, perciò oltre ogni oggettivismo –: per lui, tutto diviene luce e il presente si eternizza.
2.9) Weil: universalismo e mistica
Altro punto cardine dell’esposizione del rapporto tra filosofia e mistica, nonché della stessa concezione vanniniana della mistica, è Simone Weil, come abbiamo visto nella parte storica. Vannini, introducendo questa figura, ritiene che la Weil «– anche grazie alla sua indipendenza, al suo situarsi al crocevia delle tradizioni mistiche dell’umanità, senza legami di appartenenza a questa o a quella – rappresenti non solo un punto elevatissimo di speculazione, ma si ponga anche come figura esemplare di quell’universalismo religioso che appare sempre più vero e sempre più necessario, al momento presente»[188].
Effettivamente, nei Quaderni della Weil, si trovano, benché nella forma a-sistematica propria di quegli scritti, rimasti allo stato di abbozzo, tutti gli elementi fondamentali di una radicale esperienza mistica, intesa nel senso di esperienza piena della vita. Essenzialmente, questa esperienza, spiega Vannini, «è costituita dal distacco, soprattutto dal distacco dall’io, che deve scomparire, in modo che compaia l’unico vero io, che è Dio. Allora tutto appare uno, tutto appare buono, con un senso di realtà-bellezza-gioia che indica, per trasparenza, l’eterno nel presente»[189].
Ora, che il reale sia bene, è pensiero della Weil, che la accomuna ai grandi mistici di ogni tempo, a partire da Eraclito. In più, che tutto ciò che è sia buono, è necessariamente implicato dal fatto che tutto ciò che è deve essere volontà di Dio – non è possibile pensare che qualcosa avvenga fuori di essa –, e neppure possiamo pensare che Dio voglia il male. La Weil ripete spesso il pensiero platonico: noi possiamo sapere, di Dio, solo che è buono, e che da Lui derivano solo beni.
Qual è il “grande segreto”, per Simone Weil? È, ci svela Vannini, «l’identità del reale e del bene e, insieme, la distanza infinita tra il necessario e il bene»[190] che, del resto, è l’insegnamento platonico fondamentale. Non si deve temere la contraddizione, poiché l’identità dei contrari appare chiara all’anima distaccata, come ben sa la mistica di ogni tempo (compreso quell’Hegel che la Weil poco amava ma, bisogna dire, che poco conosceva), ancora una volta a partire da Eraclito. Il male è la distanza tra la creatura e Dio, ma l’intelligenza è in grado di sopprimere il male (operazione che la Weil chiama de-creazione) nel distacco, e allora si ha un profondo senso di realtà, bellezza e gioia nel presente, che appare come eterno. Infatti, ciò che soffoca lo spirito è l’attaccamento.
Nei suoi scritti, come ricorda Vannini[191], la Weil cita anche le Upanishad: fu proprio la lettura della letteratura sacra dell’India a condurla a quella comprensione che, alla fine della sua vita, ritrovò anche nella mistica cristiana. Perciò lei pensò a un’unica verità religiosa, che i diversi popoli avevano espresso in vari modi, dal folklore alla mitologia, fino alla più pura delle filosofie (quella platonica), sottolineando ciascuno un aspetto della medesima verità. Pur riconoscendo come vocazione tipica di Israele quella di sostenere l’unicità di Dio, non c’è dubbio che la Weil attribuisca un valore particolare all’induismo, da un lato, e al cristianesimo, dall’altro. Nel primo, infatti, spiega Vannini, «riconosce la peculiarità di sostenere l’assimilazione tra Dio e l’anima attraverso il distacco; nel secondo, il rilievo dato all’umanità di un Dio sofferente, in Cristo, con la comprensione piena del significato della sventura, della sofferenza e dell’infelicità»[192].
Inoltre, nei suoi scritti, la Weil ripete che Dio si offre all’uomo o in quanto potenza o in quanto perfezione: bisogna scegliere. Proprio per questo motivo, a suo dire, induismo e cristianesimo sarebbero vicini, e lontani dall’ebraismo e dall’islamismo.
Israele, che pure aveva vissuto a lungo accanto agli Egiziani, ha sostituito alla nozione di bene quella di onnipotenza, e ha reso Dio uno strumento di potenza nazionale. Purtroppo, scrive Vannini, il modello di santità elaborato da Israele è passato nella Chiesa. Sotto questo punto di vista, non c’è dubbio che abbia ragione Lévinas, quando sostiene che la Weil non è ebrea e neppure cristiana, bensì “pagana”, poiché rifiuta il dogma dell’elezione divina di Israele: solo che, puntualizza Vannini, «il paganesimo della Weil significa in realtà la sua classicità e la sua fedeltà alla “fonte greca”, ovvero all’universalità della ragione, all’onestà della verità, nel rifiuto di menzogne colmatrici di vuoti»[193].
Come giustamente aggiunge Vannini, «ai nostri tempi c’è bisogno di un nuovo tipo di santità, una santità che porti il segno dell’universalità in modo esplicito»[194], e la Weil, dal canto suo, era fortemente convinta di questo, tanto da non voler aderire ad alcuna Chiesa.
Accanto alle religioni sopra citate, in questa universalità rientra anche il pensiero buddhista, che la Weil ha studiato soprattutto attraverso l’opera di Daisetz Teitaro Suzuki e quella di Alexandra David-Neel, ove si sottolineano i passi relativi allo sradicamento dell’io. Nel buddhismo, la Weil vede un pensiero eracliteo, fondato sul rapporto, per cui le cose non hanno altro essere che il rapporto e la verità, nondimeno, si produce dal rapporto tra due o più proposizioni. Soprattutto, si vede nel buddhismo il cammino di estinzione del desiderio, che conduce all’annichilimento.
Sono però le Upanishad e la Bhagavad Gita (quest’ultima ancor di più) a risultare più congeniali alla Weil e a fornirle le chiavi di comprensione dell’esperienza spirituale. In particolar modo, della Bhagavad Gita la Weil studia l’analisi delle diverse componenti dell’anima (i tre guna: sattva, rajas, tamas) e dei loro rapporti, sempre per risolvere il “grande segreto” della necessità e libertà, ossia del bene e del male. Inoltre, la Bhagavad Gita e il Vangelo sono letti, dalla Weil, assieme, accostati, nella convinzione che i significati profondi, veri, autentici siano presenti in modo armonico in tutte le grandi religioni, pensiero condiviso anche da chi scrive.
2.10) Il lieto annuncio: unità del tutto e non-alterità di Dio
Nell’ultimo capitolo di Mistica e filosofia[195], Vannini ripercorre, per fare chiarezza, quello che è il suo percorso filosofico e le sue convinzioni relative alla mistica, partendo proprio dal Vangelo, il Lieto annuncio, l’annuncio dell’unità del tutto e della non-alterità di Dio: e questo è precisamente il messaggio di Gesù, che non esprime un mito, ma una concreta esperienza, vale a dire l’esperienza della non alterità dell’essere.
Benché, come si è visto, anche figure come Ibn ’Arabi si siano poste a favore di questa concezione, è chiaro, per Vannini, «che questa esperienza sia più che mai forte e consapevole nel cristianesimo, tutto imperniato sulla figura di Gesù Cristo, e dunque sull’Incarnazione di Dio e sulla Trinità»[196].
Come puntualizza Vannini, su questa linea, «non si deve attenuare, bensì sottolineare la profonda differenza tra il vero lieto annuncio e la visione alienata e malevola [...] della coscienza comune, religiosa o laica che sia, per la quale Dio è altro, altro il bene, e il mondo è diviso in buoni e cattivi. Si deve sottolineare l’opposizione, al fine di recuperare il senso vero dell’evanghelion: io sono nel Padre e il Padre è in me; anzi, “chi vede me vede il Padre” (Giovanni 14, 9). Ciò che Gesù afferma, può dirlo ogni essere umano, e se non lo dice è segno che non lo pensa, e non lo prova: per lui non ci sono lieti annunci, ma solo chiacchiere teologiche»[197].
Tutto dipende, come si è visto, dal modo in cui pensiamo l’“io” e, parallelamente, da come pensiamo Dio. Nello specifico, prosegue l’autore, è necessario che l’io, questa mente menzognera, «si sveli per quello che realmente è – pura auto-affermatività. [...] Bisogna che vada a fondo il presunto soggetto, e questa è innanzitutto l’esperienza dell’umiltà: riconoscimento della soggezione alle circostanze, del nostro esser parte della natura, anche in quanto “anima”»[198].
L’anima che ha così tolto e, anzi, superato se stessa, trova se stessa come nous, come spirito, che anche Aristotele (pensatore non certo in odore di misticismo) considera come un altro genere di anima, ripetendo che il nous ci giunge dall’esterno, dal divino, per la precisione.
È bene precisare che non si tratta di perdersi nell’Assoluto, nel Padre – un perdersi che, come avverte Vannini[199], sarebbe finto e nasconderebbe dietro di sé la solita modalità appropriativa/affermativa del soggetto – bensì si tratta di vera unità: unità, e non unione, poiché ciò che è unito non è uno e, nondimeno, unità non come l’immota unità dell’essere parmenideo o della sostanza spinoziana, ma unitas spiritus, unità dialettica, in cui è superato l’oggetto-altro, il Dioforza della tradizione biblica. Giustamente, argomenta Vannini, «la teologia latina sostiene la processione dello Spirito non solo dal Padre, ma anche dal Figlio (filioque), senza di cui si rende lo Spirito qualcosa di mitico, ovvero si ritorna all’ebraismo, nella religione dell’alienazione assoluta»[200].
E, prosegue Vannini, «vi è pari necessità dell’umano e del divino, del Figlio e del Padre, perché vi sia la verità, che è lo spirito. Nessuno dei due si regge da solo: da solo diventa rigido, astratto, vuota rappresentazione»[201].
Finché si continuerà a concepire Dio come persona-altro, non si farà che adorare la forza in corrispondenza di un fortissimo io, concepito ed esperito come volontà di affermazione e centro di forza. La concezione dialettica di Dio come spirito esclude invece ogni potere, dal momento che si identifica con la totalità e lì non ha senso il potere rivolto contro se stesso: è concepibile solo l’aspetto di armonia, di kosmos, di Uno.
Al concetto di Dio come altro-personale (e determinato) corrisponde quello di un io altrettanto determinato, con tutto ciò che ne deriva in termini di alienazione, come abbiamo visto a più riprese. Semmai, e Vannini lo sottolinea, «la “personalità” di Dio [...] sta [proprio] nella sua realtà di spirito.
Infatti solo un’infinità reale – in corrispondenza cioè di un infinito amore, di una realtà nostra come spirito, e non come soggetto finito – dà luogo ad una vera distinzione, e dunque a una vera personalità»[202]: la personalità di Dio, insomma, sta nell’identità del nostro essere divino («Chi vede me vede il Padre») e, quindi, il volto di Dio è, per Vannini, il nostro volto[203].
Si tratta, nello specifico, non di cogliere Dio, come se si trattasse di un’alterità da catturare, ma di divenire noi spirito, far nascere Dio in noi e noi in Dio.
Riguardo proprio all’alterità di Dio, illuminante è la considerazione di Vannini riguardo all’ateismo: «come davvero ateo non è chi è privo di una rappresentazione religiosa, ma chi non è e non ha spirito; così anche i cosiddetti credenti sono atei, dato che la credenza regge l’alterità di Dio, e così tiene lontana la fede come conoscenza dello spirito nello spirito»[204].
Gesù visse dall’interno dell’ebraismo l’esperienza dell’assoluta alterità di Dio, per comprendere poi l’unità con Lui, la fine dell’alterità; e la fine dell’alterità venne intesa come fine della trascendenza, con lo stesso errore che è stato fatto innumerevoli volte, e così fu condannato a morte come bestemmiatore dagli ebrei. Ma nemmeno i cristiani lo hanno capito, prosegue Vannini[205], mettendo sostanzialmente da parte quelle parole, presenti soprattutto in Giovanni, che esprimono appieno la realtà dello spirito; invece, è nato il mito salvifico, il “cristianesimo” e la chiesa, che ha riproposto appieno la positività del giudaismo, vale a dire il libri sacri, i riti, la morale, l’auctoritas, la divisione.
Il sentimentalismo ignorante, settario ed ipocrita non comprese la libertà di Gesù nei confronti del sacro, del rito, delle teologia e delle Scritture. Quando si spezzano le catene dell’io, ci si scopre tutt’uno con Dio, ovvero con la natura, che è lo spirito visibile e non, Vannini lo ribadisce[206], nel senso di un facile panteismo, che costringe a rappresentazioni assurde, ma nel senso di unità spirituale di logos e sarx, di spirito e materia, superando certa filosofia che oppone i due termini. Cosa sono il pane e il vino dell’Eucarestia, prosegue, se non il simbolo della natura, della quel quale essi stessi sono frutto e parte?
Ancora, nel pensiero classico non esiste il “soprannaturale”, poiché esso ha compreso benissimo che tutto ha uno e un solo modo di essere, di generarsi, di svolgersi; e non a caso, nel Vangelo – per Vannini[207], ultima espressione del genio greco – è presente il rifiuto del “soprannaturale” nel senso miracolistico del termine. Gesù esprime più volte riprovazione per i giudei, che cercano miracoli, che vogliono veder “segni” per la loro adorazione della forza.
Sulla scia dell’alterità e della conseguente alienazione, si creano le morali, le quali, come ben scriveVannini[208], sono il frutto dell’alterità del bene e dell’alterità di Dio e, nella fattispecie, sono frutto della volontà di appropriazione dell’io psicologico, che soffoca l’essere, come si è visto, e cerca di impadronirsi di quel bene che non può intendere che come alterità.
L’aver trasformato il lieto annuncio in una morale significa averlo completamente stravolto, corrompendo il mondo e l’uomo, e la corruzione sta proprio nella divisione, nel lacerare l’unità del tutto; è, prosegue Vannini, «la menzogna radicale, la adikìa, da cui derivano tutte le altre: distinguere le cose a seconda di fini arbitrari, dividerle in buone e cattive in corrispondenza alla loro utilità per questi fini : allora esse non sono più lasciate nel loro essere, ma giudicate per un “perché”, e così falsate»[209].
Capitolo 3
Dalla mistica alla psicologia
3.1) Cartesio e Le passioni dell’anima
Nell’Ottocento, indicativamente dopo Hegel, la mistica decadde sempre più e, divenendo scienza dell’anima, divenne poi palesemente psicologia. [questa però è solo l’opinione di Vannini]. Dobbiamo però fare un passo indietro, per capire bene da dove (o, meglio, da chi) questo processo sia iniziato: in quest’operazione, ci aiuterà il testo di Vannini La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia[210].
Ora, che Cartesio sia stato l’iniziatore della filosofia moderna e, insieme a Galileo, uno dei principali artefici del nuovo spirito scientifico, è opinione condivisa e non occorre soffermarsi in proposito. Altrettanto condivisa e diffusa è l’opinione che anche la psicologia abbia ricevuto da Cartesio, direttamente o indirettamente, uno straordinario impulso, in conformità, spiega Vannini, alla grandissima attenzione che il filosofo dette ai problemi dell’anima.
Infatti, in tutta l’opera cartesiana, e nell’epistolario in particolare, abbondano le riflessioni psicologiche, in armonia, del resto, con quella che fu una vera a e propria tendenza generale del suo tempo, in Francia.
Tuttavia è il testo de Le passioni dell’anima quello che si può considerare davvero come il primo trattato moderno sull’anima, dove “moderno” significa uno studio delle passioni non disgiunto da quello del rapporto con il corpo. Bisogna notare, infatti, che da un lato Cartesio ritiene l’uomo essenzialmente spirito, res cogitans, distinto dalla materia, dal corpo, res extensa; dall’altro, prosegue Vannini, «pensa anche a una loro unione sostanziale, ed è proprio ai problemi dell’interazione spirito-corpo che dedica un’attenzione costante»[211].
Ora, per conoscere esattamente le passioni dell’anima è necessario esaminare la differenza tra anima e corpo, dal momento che, per Cartesio, ciò che è in essa una passione, è un’azione nel corpo. Dopo aver esaminato le funzioni esclusive del corpo, è facile accorgersi che nulla resta in noi da doversi attribuire all’anima, se non i pensieri, i quali sono di due tipi: le azioni dell’anima (atti volontari) e le passioni (tutte quelle percezioni e conoscenze di ogni sorta che si trovano in noi).
Per Cartesio, l’anima non ha un potere assoluto sulle passioni e non può disporne a completo piacimento; infatti le passioni non sono solo causate, ma anche mantenute e rafforzate dal movimento degli spiriti animali, per cui, finché dura l’emozione provocata dagli spiriti, le passioni restano presenti al nostro pensiero, come gli sono presenti gli oggetti sensibili finché agiscono sugli organi di senso.
Il potere dell’anima sulle passioni, prosegue, è indiretto, nel senso che esse non possono essere suscitate o soppresse direttamente dall’azione della volontà, ma possono invece esserlo indirettamente, ossia attraverso la rappresentazione delle cose abitualmente congiunte con le passioni che vogliamo avere, e contrarie a quelle che volgiamo respingere.
Un’importante conseguenza della teoria cartesiana sull’anima, nota Vannini, «è l’esplicita negazione della distinzione (platonica) tra le varie componenti dell’anima, [...] giacché in noi “c’è una e una sola anima, che non ha alcuna diversità di parti”»[212]. L’errore che è stato commesso facendole incarnare diversi personaggi, per lo più contrastanti tra loro, deriva dal non aver distinto le funzioni dell’anima da quelle del corpo, al quale soltanto va attribuito quanto in noi è in contrasto con la ragione.
Altra importante conseguenza, prosegue Vannini, «è che l’eventuale conflitto tra anima e corpo, tra volontà e passioni, viene vinto dalla prima se essa usa le sue armi proprie, ovvero “giudizi saldi e precisi sulla conoscenza del bene e del male”»[213]. Ora, dal momento che, come rileva Cartesio, le cause delle passioni sono per la maggior parte esterne all’anima, è necessario che essa sia ben guidata. La trattazione diviene davvero importante negli ultimi articoli della seconda parte (139-148), là dove il filosofo parla dell’uso delle passioni in quanto appartengono all’anima: infatti noi non abbiamo solo il corpo, che non è neppure la parte migliore di noi, ma invece la meno importante.
Nella fattispecie, nella trattazione “psicologica” del filosofo francese compaiono termini cui le psicologie moderne hanno rinunziato: vero e falso. Vi sono, in primo luogo, delle verità e di conseguenza dei valori (conoscenza vera, cosa buona), e in questo campo non c’è più misura: secondo l’assioma di origine agostiniana, chiosa Vannini[214], la misura dell’amore è amare senza misura. Ma ancor più di stile agostiniano, e comunque appartenente in pieno alla tradizione spirituale, quello che segue: siccome ci si trasforma in ciò che si ama, l’amore per i beni veri congiunge a quei beni stessi, portandoci alla loro medesima perfezione; per quanto riguarda l’amore del bene in sé, il filosofo parla chiaramente del dimenticare se stessi.
La misura ritorna, peraltro, subito dopo, quando si tratta degli effetti che le passioni causano al corpo. Se è vero che da una conoscenza vera non può che derivare un desiderio buono, è altrettanto vero che può essere eccessivo: se non avessimo il corpo, potremmo dire, prosegue Vannini, «che l’amore e la gioia non sono mai abbastanza, [...] ma i moti corporei che vi si accompagnano possono sempre nuocere alla salute se sono troppo violenti, mentre le sono utili quando sono misurati»[215].
La conclusione della parte seconda è molto importante, sia per significato filosofico che per sottigliezza psicologica. Cartesio ribadisce che il nostro bene e il nostro male dipendono principalmente dalle emozioni interiori dell’anima, che sono suscitate dall’anima stessa, ma ripete che esse possono unirsi alle passioni, che provengono dagli spiriti animali, non solo loro simili, ma anche diversi, e nascere talvolta persino da passioni contrarie: possibilità, dunque, di compresenza di una passione e di una emozione, ma netta superiorità di ciò che è interiore rispetto a ciò che è esteriore. Certo, non si può restare insensibili al dolore, tuttavia l’“uomo esteriore” può esser preso dal dolore (o da altra passione), mentre l’“uomo interiore” permane in un distacco immutabile.
L’influsso cartesiano, come accennato in precedenza, è stato determinante nella cultura europea, ed anche in quella che si chiamerà psicologia. Il problema del rapporto spirito-corpo è quello che più di ogni altro affaticherà i filosofi dopo Cartesio, non convinti della bontà della soluzione da lui offerta con la ghiandola pineale.
Nello specifico, queste osservazioni riguardanti Cartesio sono utili per capire come è iniziato quel processo che, dalla mistica, ha portato alla psicologia.
3.2) Spinoza e l’Ethica: una meccanica delle passioni
Buona parte della filosofia e poi della psicologia moderne imboccheranno risolutamente la strada del corpo, tralasciando lo spirito: è la via che nel Seicento prese Hobbes e che, attraverso le teorie settecentesche dell’“uomo macchina”, approda a tanta parte della cultura del positivismo, fino a giungere al nostro tempo e alle nostre scienze. È la strada, come ben scrive Vannini, «che porta alla perdita dell’anima, alla perdita del logos, oltre che, ovviamente, alla perdita di Dio»[216].
Dal canto suo, Spinoza, come si vede in particolare nella terza parte dell’Etica, ove si tratta dell’origine e della natura delle passioni, dipende molto da Le passioni dell’anima di Cartesio, da cui pure intende differenziarsi in alcuni punti essenziali.
Per Spinoza, Cartesio, cercando di spiegare le passioni secondo le loro cause prime, ha mostrato solo l’acume del suo ingegno. Nulla, infatti, avviene in natura che possa attribuirsi a un suo vizio, giacché la natura è sempre la medesima, e la virtù e la potenza del suo agire è dappertutto una sola e medesima: quindi, si devono considerare, per Spinoza, le passioni dell’anima secondo la medesima virtù della natura da cui seguono tutte le altre cose; si tratta, nello specifico, non di esecrare o deridere le passioni degli uomini, o reprimerle, ma di comprenderle.
Per cui, dichiara il filosofo olandese, si studieranno le passioni con lo stesso metodo con cui si è proceduto per Dio e per lo spirito, ovvero con rigore geometrico, considerandole come se si trattasse di linee, superfici e corpi.
Essenziale, per Vannini, è rilevare come, al termine di questa terza parte, e proprio per passare alle ultime due, conclusive, «Spinoza definisca l’affetto [...] come un’idea confusa mediante la quale lo spirito afferma una forza di esistere del suo corpo, o di una parte di esso, maggiore o minore di quella che affermava prima, e, data la quale, lo spirito stesso è determinato a pensare questo piuttosto che quello»[217]. Il filosofo olandese ricorda altresì, nella spiegazione che segue la definizione, che lo spirito è passivo, in quanto ha idee confuse, o inadeguate.
3.2.1) Bene, male, virtù
Per quanto concerne la quarta parte della trattazione spinoziana, è opportuno, come fa Vannini[218], seguire il discorso del filosofo in relazione al bene, al male e alla virtù.
La conoscenza del bene e del male, asserisce Spinoza, non è altro che l’affetto di letizia o tristezza, in quanto ne siamo coscienti. Infatti chiamiamo buono o cattivo ciò che giova o nuoce alla conservazione del nostro essere, ossia ciò che accresce o diminuisce, asseconda o ostacola la nostra potenza di agire. Ciascuno appetisce o avversa necessariamente per le leggi della sua natura ciò che giudica esser buono o cattivo. In tal senso, commenta Vannini, «si comprende come la definizione di virtù proceda essenzialmente dallo sforzo di conservare se stessi, che è l’essenza propria di ciascuna cosa, per cui si può dire che lo sforzo di conservare se stessi è il primo ed unico fondamento della virtù [...]. Non si può dire però che l’uomo agisca virtuosamente quando è determinato da idee inadeguate, ma solo quando è determinato dalla comprensione. Agire per virtù non significa altro che agire, vivere, conservare il proprio essere [...] sotto la guida della ragione, e ciò sul fondamento della ricerca del proprio utile»[219].
Lo sforzo, prosegue, che procede dalla ragione non è altro che il conoscere, e lo spirito, in quanto si serve della ragione, non giudica che le sia utile altro che quel che conduce alla conoscenza, e nessuna cosa sappiamo con certezza essere buona o cattiva se non ciò che conduce realmente alla conoscenza, o che può ostacolarla. E lo spirito non desidera altro che la conoscenza.
Si può allora dedurre che il bene supremo dello spirito è la conoscenza di Dio, e suprema virtù dello spirito conoscere Dio. Qui, commenta Vannini, «l’esito mistico giunge a partire da quello che potrebbe sembrare un utilitarismo, con un percorso ben diverso da quello cui si è abituati nella storia della spiritualità, ma non v’è dubbio che l’esito sia il medesimo»[220].
Il pensare il male, spiega Vannini, «deriva dall’ingiustizia, ossia da quel non essere uguale in tutte le cose che dipende dal legame con se stesso, un se stesso che si oppone agli altri e alle cose.
Nell’uomo iniquo [...] la passione, l’interesse personale prende il sopravvento e tutte le cose vengono distorte da esso e per esso. Dato che tutte le cose sono regolate in conformità a ciò che richiede il fine, vero o stimato, ne consegue che, sovvertito e pervertito il fine, venga pervertito tutto ciò che vi si riferisce»[221]. A livello religioso, il pensiero del male è essenzialmente il pensiero dell’alterità dell’essere, del dualismo, che, ricorda incessantemente Vannini, «dà luogo ad una rappresentazione superstiziosa di un Dio che invia, a suo piacimento, beni e mali, ma può avere anche un aspetto ateistico, in quanto comune è l’alterità dell’essere, la lontananza del bene»[222].
Quali conseguenza trarre, dunque, da tutto questo? Per Vannini, «chi è privo, in un modo o nell’altro di Dio, deve pensare il male, pensar male; perciò non dispiega la sua ragione, e dunque non è libero, ma schiavo [...] della passione, prigioniero del suo piccolo io»[223]. E che dire, prosegue, di chi, pensando il male, si pone come medico delle anime? Dove mai le condurrà? Seguiamo la risposta che ci dà Spinoza nella quinta e conclusiva parte della sua Etica.
La libertà dello spirito è per il filosofo olandese, la beatitudine stessa, di cui si gode quando la ragione, che è la potenza dello spirito, governa gli affetti. Ora, la chiave per la libertà dello spirito è la comprensione che delle passioni stesse si può e si deve avere. Infatti, le affezioni del corpo, cioè le immagini delle cose, si concatenano al modo con cui i pensieri e le idee delle cose si ordinano e concatenano nello spirito, e se noi separiamo una commozione o un affetto dell’animo dal pensiero della sua causa esterna e l’uniamo ad altri pensieri, saranno distrutti amor e odio, insieme a tutte le fluttuazioni d’animo derivanti da tali affetti. Una passione, infatti, chiosa Vannini, «è un’idea confusa, ma se noi [...] la spieghiamo, la comprendiamo e la riportiamo alla necessità, [...] la ragione avrà potere su di essa tanto più quanto più la conosciamo e, parallelamente, tanto meno ne patiremo»[224].
La liberazione in cosa consiste, dunque? Essenzialmente, spiega Vannini[225], nel riportare tutti gli affetti a Dio; ma chi conosce sé e i suoi affetti in modo chiaro e distinto, ama Dio, e tanto più quanto più conosce sé e i suoi affetti: la conoscenza, infatti, rende gioiosi e, se è accompagnata dall’idea di Dio, diviene amore di Dio, che è amore assolutamente distaccato. Ed è, questo, il conoscere sub specie aeternitatis: le cose sono conosciute in Dio.
3.3) Hegel e l’Enciclopedia delle scienze filosofiche: la malattia
Facciamo ora un salto in avanti e, relativamente al tema di questo capitolo, prendiamo in esame la posizione hegeliana così come emerge dall’Enciclopedia delle scienze filosofiche[226], in particolare, la parte terza, che tratta della filosofia dello spirito.
Con tutta la tradizione classica e cristiana, Hegel ripete che la conoscenza di se stesso presuppone e significa la conoscenza della verità, verità dell’uomo e verità in se e per sé. Hegel, nello specifico, polemizza contro il frazionamento dello spirito in facoltà diverse, concepite indipendenti l’una rispetto all’altra, in forze o attività distinte – frazionamento che nega lo spirito come unità vivente. Infatti, è evidente, sia da un punto di vista concettuale che secondo la realtà storica, come lo psicologismo più o meno esasperato nasca e si sviluppi proprio quando si perde l’esperienza del “fondo” dell’anima come unità essenziale della medesima, che precede e fonda le potenze: è allora che si perde anche il concetto di spirito come unità vivente.
La mancanza dello speculativo, ovvero del mistico, esprime e significa insieme l’incapacità che la psicologia razionale ed empirica hanno di comprendere il concetto di spirito. Hegel definisce lo spirito come negatività assoluta, e dunque libertà assoluta, aggiungendo che, perciò, lo spirito è in grado di astrarre da ogni cosa esteriore, e persino dalla sua propria esteriorità, dalla sua esistenza (Dasein): è in grado di sopportare la negazione della sua immediatezza individuale; può, cioè, mantenersi affermativo in tale negatività ed essere identico per sé.
Veramente significativo è il rimando al male, visto come quella vanitas che tiene fermo il finito, sta legata a qualcosa di determinato, perché è legame a se stesso, è la Eigenschaft, ossia quello che si potrebbe definire il peccato elementare. L’uomo giusto, come dice Eckhart, ossia l’uomo interiore, sfugge sempre a se stesso, è in un perenne distacco.
L’elemento nuovo che Hegel apporta è la comprensione che quel male etico e teoretico che sta nel legame alla propria soggettività, è anche l’origine della follia, o la follia stessa – il vanum che diventa wahn, ovvero, spiega Vannini[227], la vanitas come Wahsinn –, mentre invece lo spirito può sopportare il dolore infinito della propria stessa morte come soggettività: infatti, perché emerga lo spirito, occorre che l’anima muoia, parallelamente alla morte di Dio. Se ciò non avviene, se l’anima resta chiusa in se stessa, nella sua immediatezza, si ha, come dicevamo, il male e la follia.
Nell’Enciclopedia, trattando dell’anima senziente, Hegel scrive che ogni individuo è un insieme di sensazioni, rappresentazioni, conoscenze, pensieri, ecc.; ma io sono assolutamente semplice, sono un fondo indeterminato, nel quale tutto ciò è serbato. Solo quando, prosegue Hegel, io richiamo a mente una rappresentazione, io la porto fuori da quell’interno all’esistenza dinanzi alla coscienza.
La “semplicità” dello spirito, chiosa Vannini, «non sopporta il molteplice e non si lascia frazionare da esso, ma lo risolve nella propria unità. In quanto idealità, ossia “totalità negativa”, ovvero in quanto potenza negativa assoluta, lo spirito stesso contiene virtualmente in sé il tutto. L’inconscio scaturisce pertanto dall’unità dialettica di corpo e spirito e ha origine dal contrasto delle rispettive determinazioni fondamentali, naturalità e idealità»[228]. A causa di tale unità dialettica, l’inconscio, se per un verso si oppone allo spirito, per un altro non è mai in stato di alterità assoluta rispetto ad esso. L’intelligenza, dunque, prosegue Vannini, «va concepita come un “fondo tenebroso in cui è conservato un mondo di immagini e rappresentazioni, senza che esse siano nella coscienza”, ovvero da concepire come un “fondo inconscio”»[229].
A questo punto della trattazione, compare la malattia, vale a dire la malattia dell’anima, la follia. Questa è da considerarsi, in primo luogo, come una forma o una tappa dello sviluppo dello spirito. In questo aspetto, essa è un fenomeno necessario, che consiste nella mancanza di mediazione con cui l’individuo sta in rapporto al contenuto concreto di se stesso, ossia in una condizione non distaccata nei confronti dei propri contenuti. È evidente che questa sia una condizione, commenta Vannini[230], che ogni essere umano attraversa, dal momento che il distacco, la riflessione e la mediazione, sono una conquista della maturità, e dunque in ciò non vi è niente di gravemente patologico, almeno, si precisa, finché questa separazione tra coscienza ponderata di sé e connessione intellettiva del mondo resta in limiti tollerabili, benché sia comunque condizione di sofferenza.
Però, prosegue Hegel, anche il soggetto elevato alla coscienza intellettiva è ancora suscettibile si malattia, allorquando resta impigliato in una determinazione particolare e non assegna a questo contenuto particolare il suo posto e la sua subordinazione all’interno del soggetto: si ha la contraddizione tra la totalità del soggetto e la determinatezza particolare e la conseguente follia. La follia è, dunque, spiega Vannini, essenzialmente «quell’errore che sta nell’incapacità di comprendere le rappresentazioni e i sentimenti particolari, risolvendoli in una totalità ordinata. Come tale, essa è [...] condizione comune del normale sviluppo spirituale dell’individuo, ma il fatto è che non sempre l’anima si eleva a spirito, negando se stessa»[231]. Allora lo spirito resta come qualcosa che solo è, senza mediazione in se stesso, ossia privo di distacco, di movimento e di vita – e, in questo senso, malato. E lo spirito, dal canto suo, per trovare se stesso , deve attraversare e superare, nello specifico senso dell’Aufhebung, gli estremi del male e della follia. Potrà farlo senza perdersi in essi se sarà capace di riconoscerli e guardarli davvero in faccia, sopportando il “dolore infinito” della negazione dell’immediatezza individuale, vale a dire, la morte dell’anima.
Fede nel logos e nella verità, come conoscenza spirituale – questo, come scrive Vannini[232], è il principio regolatore dell’intera filosofia hegeliana e anche la sua psicologia. La sua, come sarà noto, non è la strada prevalentemente seguita dalla psicologia, e questo lo comprese benissimo il filosofo di Stoccarda che, descrivendo lo stato presente della scienza, ma con un lucidissimo presentimento dell’avvenire, osservò come, nella scienza dell’anima, così come nella religione, l’irrazionale avesse oramai preso il sopravvento, istituendo il regno del soggettivismo, dell’arbitrio e della retorica, stante il fatto che, nello specifico, al centro della ricerca psicologica stava l’empiricità dei fatti della coscienza umana, i quali come fatti venivano analizzati, nella loro determinatezza, rinunciando, in tal modo, al concetto e alla verità.
3.4) La psicologia razionale ottocentesca: utilitarismo e preconcetti
Hegel, come scrive Vannini[233], fu un buon profeta. La psicologia “razionale” naufragò assieme alla metafisica che la sosteneva, e la disciplina prese, nell’Ottocento, risolutamente la strada dell’empiricità, del fatto, del dato. Tuttavia, dopo le ingenue speranze di Wundt, che voleva fare una psicologia “scientifica”, con metodi sperimentali, prendendo a modello le scienze fisiche e naturali, già ai primi del Novecento si cominciò a parlare di crisi e, soprattutto, di “torre di Babele” della psicologia. Quarant’anni dopo, utilizzando il concetto di “paradigma” mutuato da Kuhn, lo storico della psicologia Watson parla della disciplina come di una scienza ancora pre-paradigmatica, il che equivale a considerarla ancora non scientifica.
Per Watson[234], la psicologia opera partendo da preconcetti e pregiudizi, dati per scontati dallo psicologo, ossia presi come “dati di fatto”, senza un’esplicita ammissione, diversi tra le diverse scuole psicologiche. Tali prescrizioni, spiega Vannini[235], sono vere e proprie idee guida, sulla base delle quali lo psicologo sceglie il problema, lo formula e lo elabora.
Conseguentemente, si riscontra l’emergere di una forma ancor più radicale di relativismo, per cui siabbandona perfino l’idea empiristico-positivistica di partenza e la realtà stessa, prosegue Vannini, «comincia a essere dichiarata non qualcosa di esistente in sé, che la scienza scopre in un percorso di progressiva approssimazione, ma qualcosa che una cultura, una società, una comunità scientifica ritiene che sia tale»[236]. Nel campo specifico della psicologia, concetti come identità, sé, emozione, ecc., vengono considerati non esistenti al di fuori del contesto culturale e della comunità scientifica che li ha elaborati; essi mutano nel corso della storia e nelle varie culture.
Peraltro, prosegue Vannini[237], dopo la caduta dei grandi miti scientisti ottocenteschi e la recuperata consapevolezza della storicità del sapere, si è affossata anche la ragione e la scienza, nel senso che la psicologia non sa più neanche definire quale sia il suo oggetto: non l’anima, che è scomparsa insieme a Dio, ma neanche la mente, la coscienza, la persona... Tutto ciò viene distrutto come inconsistente, frutto di culture e scelte parziali.
Dunque, commenta amaramente Vannini, è facile che «al posto del logos subentri la mera retorica e lo psicologo assuma così il ruolo di un moderno sofista»[238], di un venditore di fumo e nebbia, incapace di approcciarsi davvero all’umano, e ciò lo conferma appieno chi scrive. Sembra però che anche l’idea di logos di Vannini abbia un che di fumoso: Vannini, infatti, non chiarisce e non definisce mai compiutamente il Logos.
Si deve peraltro rilevare[239] come già il fondatore del positivismo, Comte, lucidamente negasse lo statuto di scienza alla psicologia, riassumendola, da un lato, nella biologia, dall’altro nella sociologia. Comte, nello specifico, nega infatti il valore conoscitivo dell’introspezione, è ciò non meraviglia, dal momento che ha negato, in successione, Dio, lo spirito e, dunque, anche l’anima. Del resto, il filosofo francese nega il concetto stesso tradizionale di scienza come conoscenza delle cause, sostituendovi quello della semplice correlazione dei fenomeni. Così vi si possono cogliere “dati” in modo del tutto accidentale e confusionario, senza concetto e senza verità, come abbiamo visto.
La psicologia, continua Vannini[240], si presente oggi come una sorta di “tuttologia”, mancante però dell’essenziale, ossia la conoscenza di se stessi. Riguardo proprio alla conoscenza di sé, la rinuncia dipende dal terrore di scendere al di sotto delle potenze, nel fondo dell’anima, ove è il nulla.
Ed è sufficiente prendere in considerazione Nietzsche, come abbiamo visto, focalizzando l’attenzione sul testo Al di là del bene e del male[241]. Fu infatti la penetrante critica di Nietzsche a mostrare la debolezza della psicologia. Non gli fu difficile mostrare che, come non esistono i “dati”, i “fatti”, se non nella misura in cui son scelti da noi, ossia come frutto di una selezione/interpretazione, così la filosofia è frutto di qualcosa di cui non rendiamo ragione per disonestà, ovvero perché vittime noi stessi di oscuri legami e moventi i quali, per Vannini[242], si riconducono essenzialmente all’affermatività dell’io, che è la volontà di potenza nietzschiana.
Vi è però un altro motivo oggettivo, storico, per il quale noi, oggi, abbiamo psicologie senza spirito e senz’anima. Questo motivo, afferma Vannini, «va ricercato soprattutto nella storia religiosa dell’Occidente cristiano, proprio là dove la psicologia è nata. E qui è interessante rilevare, che il termine stesso nasce in ambito luterano, dove fu coniato, o perlomeno diffuso, in un contesto educativo, morale e religioso. La psicologia nasce dunque finalizzata alla “cura d’anime”, ove lo scopo finale della “cura” è la salus, qui ancora come salvezza eterna»[243].
La storia della psicologia, dalla sua origine in ambiente religioso alla sua realtà attuale, altro non è che la storia della progressiva banalizzazione dell’utile, del “perché”: da quello che era la salvezza dell’anima alla salute che non è più dell’anima, ma di qualcos’altro, della psiche prima, della mente poi, per scadere sempre più, una volta persi concetto e verità, e cessare anche di essere salute; diviene così un soggettivo “benessere” (su cui, a mio avviso, si potrebbe discutere), fino a naufragare definitivamente nell’“igiene mentale”.
Del resto, la religione, prosegue l’autore, in quanto basata sull’attaccamento e sulla positività, «può ben andare d’accordo con la psicologia, se questa è disposta a lasciarle lo spazio del “soprannaturale” (ovvero a rinunciare ad essere davvero scienza) [...]. E qui bisogna rilevare come proprio la distinzione naturale/soprannaturale sia ciò che più di tutto ha contribuito, nell’ambito religioso, a [...] eliminare di fatto la nozione di spirito, lasciando libero spazio allo psicologismo»[244].
Spieghiamo bene questo passaggio, con le parole di Vannini, per chiarire meglio questa connessione. «Se andiamo a vedere, nella filosofia greca la parola physis indicava tutto l’essere, [...] proprio in quanto movimento, nascita, crescita, morte. La physis è l’essere proprio in quanto phyei, genera, diviene: unità di ciò che è diverso in ogni istante. Il pensiero classico, che sulla riflessione “sulla natura” è nato, ha chiara l’unità dialettica del tutto, sa benissimo che la dualità è il male ed è perciò fin dall’inizio pensiero dell’Uno. Questo, non significa certo che tutto sia dell’uomo: perciò i greci parlano degli dèi come immortali, diversi dai mortali, ed anche di un mondo yperourànios o yperkòsmios, diverso da quello terrestre. […] Gli dèi, beati ed immortali, possono compiere azioni eccezionali e fuori dall’ordinario, ma sono anch’essi soggetti alla legge della necessità [...] e tra uomini e dèi c’è comunque un rapporto che ne sottolinea la profonda unità, espressa anche nel concetto di kòsmos»[245]. Tale concezione, tuttavia, sembra essere un’immagine stereotipata che Vannini riprende come se fosse ovvia: solo con Parmenide, forse, o con i presocratici, si può pensare la filosofia come pensiero dell’Uno.
Perciò nella filosofia greca non esiste il “soprannaturale”, dal momento che il pensiero greco ha ben compreso che tutto ha un modo di generarsi, di svolgersi, di essere, e tale modo è, appunto, la physis.
Nello specifico, afferma Vannini[246], nella nostra società la religione tradizionale ha perduto lacapacità salvifica, poiché non ha affrontato veramente l’Illuminismo, e non ha quindi visto che l’Illuminismo è un momento stesso di quella mistica che è stata, a sua volta, rifiutata, e ha così cercato rifugio nella mitologia e nel sentimentalismo. Non meraviglia, perciò, prosegue Vannini,«che la nostra società ex-cristiana sia una società di malati, e non solo nel senso spinoziano ed hegeliano che abbiamo visto, ma anche in uno più banale e consueto, come società alla ricerca di terapie dell’anima di vario tipo, da quelle farmacologiche a quelle psicologiche»[247].
3.5) Freud: alienazione ed istinti
Sarebbe impossibile, in questa sede, e, del resto, esulerebbe dal tema centrale di questa esposizione, tentare un esame dell’infinito mondo delle psicoterapie e affini, ma ci limiteremo a parlare della psicanalisi, come fa Vannini, del resto.
Per quanto Freud abbia tentato di presentarla come scienza, essa nasce e si sviluppa su un terreno assolutamente irrazionalistico, che è quello stesso, per Vannini[248], del suo fondatore. L’irrazionalismo di fondo sta nella negazione dell’essenza razionale e spirituale dell’uomo, concepito invece come un oscuro groviglio di istinti che, dal basso, emergono, parzialmente, verso l’alto, nelle regioni pre-conscie e conscie, e dai quali deriva anche l’elemento prescrittivo, morale, il cosiddetto “super-io”. Naturalmente, ciascuno vede solo quello che può e che vuole vedere, e non è un caso, prosegue Vannini[249], se l’uomo appariva a Freud come deterministico fascio di istinti, giacché lui stesso era così; la smania di potere, di successo, l’autoaffermatività sono infatti le chiavi della sua vita, e poi della psicanalisi come associazione settaria, che ha tentato di imporsi come detentrice del sapere essenziale, perché sapere della psiche, traendone tutti i vantaggi del caso.
Una costellazione di suicidi, fa notare Vannini[250], segna la storia della psicanalisi, sin da suo inizio (Honegger, Tausk, Rosenthal, Kahane, Silberer, Benussi, Sokolnicka, Morgenstern, Stekel, Happel, Federn, Bettelheim, solo per citare alcuni nomi di psicanalisti che, dal 1911 al 1990, hanno posto fine ai loro giorni). E suicida fu anche Freud, che, in piena lucidità, si fece somministrare dal suo medico personale, Max Schur, la dose letale di morfina, nella notte del 23 settembre 1939, per porre fine alle proprie sofferenze. Se si considera il ruolo che la morte, le pulsioni di morte, assumono nelle opere di Freud, non si può non vedere nella sua figura, rileva Vannini[251], e in tutta la psicanalisi, altro che la forma tragica della lontananza dall’essere, l’alienazione della cultura contemporanea.
Nondimeno, prosegue Vannini, «dalla forma primaria dell’alienazione, l’ebraismo, Freud prese quelle caratteristiche essenziali su cui tanto acutamente aveva riflettuto il giovane Hegel: il dualismo, il pensiero del male, l’incapacità della conciliazione e del perdono – ovvero le caratteristiche fondamentali della malattia dell’anima, incapace di elevarsi a spirito, e perciò condannata allo sradicamento e all’infelicità, che infatti egli considerava condizione normale per l’uomo»[252]. Sempre dall’ebraismo, Freud riprese il concetto dell’assoluta trascendenza di Dio, con l’impossibilità di pensare Dio e l’uomo come spirito, ma, dal positivismo della cultura del tempo, riprese l’ateismo, per cui non gli rimase altro che un concetto della religione come alienazione, o come nevrosi collettiva, in modo non dissimile a quanto aveva pensato Marx.
Nel quadro psicanalitico, positivista e ateo, non è possibile, stante ciò che si è visto, una catarsi. Certo, è possibile rendersi conto dell’origine inconsapevole di ciò che procura sofferenza – ammesso che ciò sia vero e nei casi in cui è vero –, ma il rendersene conto non basta a guarire, qualora venga a mancare l’inserimento del fatto in un quadro luminoso, in cui tutto viene da Dio ed è in Dio. Il comprendere l’origine della sofferenza, afferma Vannini[253], non basta a guarire, se permane l’orientamento malvagio del soggetto sofferente, ossia se permangono sentimenti negativi, i quali sono frutto dell’incomprensione.
3.6) Jung: la crisi del cristianesimo psicologistico
Il caso di Jung e della sua scuola testimonia invece meglio la crisi del cristianesimo psicologistico nel nostro tempo, e la sua incapacità, in quanto tale, di condurre a spirito, fornendo risposte inadeguate alla domanda di verità, di felicità, di luce, dell’uomo contemporaneo.
Come onestamente ammette Vannini[254], bisogna peraltro dare atto a Jung di essersi subito reso conto che il problema psicologico di fondo, anche nei suoi aspetti patologici, è il problema religioso: dalla crisi della religione nasce la spaventosa afflizione dell’anima dell’uomo contemporaneo, e dalla religione soltanto può venire la cura e la salvezza.
Ma come intende Jung la religione? Dai suoi scritti, si nota che la religione è considerata nel suo aspetto psicologistico, irrazionalistico, e dunque anche simbolico e magico, come un tipo di esperienza che colpisce profondamente a livello emozionale (questa è la categoria di “numinoso”, che rimanda a Il sacro[255] di Rudolf Otto). È assente la comprensione della religione cristiana come religione dello spirito – e perciò religione trinitaria – e quel che è peggio, lo spirito è sostituito da un torbido e confusionario spiritualismo e addirittura dallo spiritismo.
Ciò spiega perché, intorno allo psicologo svizzero, si sia creata quell’aura di “misticismo” che, insopportabile per alcuni, è però seducente per altri. Si tratta, in realtà, precisa Vannini[256], di un misticismo assolutamente lontano dalla via maestra del mondo cristiano, nel quale Cristo è il logos e chiama alla chiarezza e alla luce del logos: questo, invece, è l’esatto contrario, un misticismo misterico e mistificatorio, nel quale un agglomerato caotico e scriteriato di occultismo, spiritismo, tarocchi, chiromanzia, alchimia, massoneria, teosofia, astrologia, I Ching e chi più ne ha, più ne metta, dovrebbero servire alla comprensione di se stessi, alla realizzazione del sé.
Dal misticismo, Jung riprese l’idea della presenza del divino in noi, nel fondo o nel profondo dell’anima, ma in lui non c’è esperienza di spirito, non c’è dialettica, e perciò egli interpreta il divino dentro di noi ad esclusione del divino che è fuori di noi.
Seguendo il linguaggio di von Hartmann, e più ancora di Schopenhauer e Nietzsche, spiega Vannini, «lo psicologo svizzero allude alla necessità di “distaccarsi dal divino” per diventare interamente se stessi, e qui parrebbe di sentire un’eco della voce di Meister Eckhart ma si tratta di un Eckhart interpretato parzialmente, come lo intesero forse i Fratelli del Libero Spirito»[257].
Peraltro, il divino dentro di noi ad esclusione di quello fuori di noi non può essere spirito, non può essere distacco, ma si configura come un elemento vitalistico biologicamente inteso, come un elemento di forza; il distacco da Dio, dunque, non sarà in nome di Dio, ma in nome dell’io.
Come ha cura di precisare Vannini[258], non è da discutere l’interpretazione, psicologicamente esatta, di ciò che la religione comunemente rappresenta, ma da rilevare come Jung non veda altro che quella, e che perciò, coerentemente con il suo punto di vista, ritenga che si tratti di sostituire attributi e simboli ad attributi e simboli, in un ambito che appartiene al sentimento. Ma il sentimento, come abbiamo visto parlando di Hegel, è proprio ciò che non lascia essere lo spirito e, dal canto suo, il simbolo è ciò che rimanda ad altro: è il segno, dunque, dell’alienazione.
È a da rilevare, inoltre, come Jung, il quale, per Vannini[259], aveva correttamente compreso che la “salute” dell’anima sta nel superamento dell’alterità dell’essere, dell’alterità di Dio, non comprendendo però che l’unione con Dio è unitas spiritus, un’unione che sta nella differenza e che vive nel rapporto, la cercasse non nella regione luminosa dello spirito, ma in quella oscura dell’inconscio, del sogno, ove risiede non il mistico, ma il misterico.
La profondità dello spirito, prosegue Vannini[260], si manifesta, come abbiamo visto, nel suo “perdersi”, ossia nel distacco, che è l’opposto di quanto praticato e insegnato da Jung, e dai suoi concetti di individuazione o costruzione del sé; solo nel distacco si può far pace con le potenze oscure dell’inconscio.
Conclusione
Nell’interpretazione che Marco Vannini ci offre dell’esperienza mistica, risultano centrali due termini: Logos e distacco; entrambi, come abbiamo visto, rimandano alla più pura tradizione filosofica greca (e con notevoli riferimenti, non casuali, con l’Oriente) ; in entrambi gioca un ruolo fondamentale l’antitesi all’Io e alle sue pretese di auto-affermatività : un’auto-affermatività dalla quale derivano non solo esaltazioni irrazionali, da un lato, e macerazioni altrettanto irrazionali, dall’altro, ma anche un’immagine di Dio completamente falsata, basata, fondamentalmente sull’alterità del divino.
Fintanto che si ferma all’alterità di Dio, senza riconoscerLo e senza riconoscersi come spirito, la religione non potrà mai porsi come verità, e il sentimentalismo/psicologismo della cosiddetta “fede” che essa stessa propone potrà forse dare qualche ristoro, così come tutto l’abisso caotico delle pratiche spirituali di stampo New age e affini, ma di certo non riuscirà a reggere il confronto con l’intelletto illuministico.
Al centro della concezione di Vannini della mistica, c’è il rapporto tra intelligenza e amore, rapporto che non è mai chiarito appieno e, che, anzi, sembra privilegiare l’intelligenza: ma non si rischierà un’intellettualizzazione della mistica? E a che cosa potrà portare questo? Certo, Vannini si preoccupa (forse eccessivamente) di combattere la “mistica del sentimento”, la mistica dell’irrazionalità: ma, difendendo la mistica dell’intelletto, non rischierà di finire all’estremo opposto? E gli estremi, come sappiamo, si toccano. Come possiamo allora meravigliarci che la religione stessa, con l’occultamento del “fondo”, la consegna dell’anima alle “potenze” e l’irrigidirsi/chiudersi nel dogmatismo, abbia perduto la scienza dell’anima e la capacità di curarla, proteggerla, custodirla, lasciando al suo posto una marea di anime sperdute e incerte, che non sanno più dove e a chi rivolgersi?
Come si è cercato di chiarire fin dagli inizi, la religione dovrebbe prendere coscienza che, nel suo cuore stesso, possiede il superamento dell’alienazione. Dal Vangelo di Giovanni alla filosofia di Hegel (e anche oltre), la mistica autentica ha infatti sempre conservato, al contempo, conoscenza di Dio e conoscenza dell’anima: l’esperienza dello spirito, là dove Dio e l’anima sono una cosa sola, senza alterità e alienazione; e, del resto, solo nel cristianesimo può esser preservata l’esperienza dello spirito, poiché il cristianesimo è religione trinitaria, come Vannini giustamente sottolinea.
Nel delineare le tappe della storia della mistica Vannini sembra procedere hegelianamente, considerando la storia della filosofia come espressione della filosofia stessa: come ho avuto modo di rilevare all’inizio del secondo capitolo, si fonda sulla storia della mistica per esporre (non tanto per costruire), o, meglio, lasciar intravedere (indicando quali pensatori e pensatrici meritano la nostra attenzione ) il suo pensiero al di sotto dell’abbondanza di riferimenti storico-filosofici. Ma c’è di più.
Proprio il suo approccio alla storia della mistica risulta alla fine singolare: l’intera sua ricerca si fonda sull’analisi e sull’esposizione di Meister Eckhart; l’intera storia della mistica (e della filosofia?) viene esaminata con la lente del pensiero eckhartiano, arrivando a considerazioni che possono sembrare paradossali, fino a chiamare in causa, per esempio l’intelletto attivo aristotelico che viene interpretato alla luce dell’esperienza mistica.
Anche la sua considerazione dell’importanza (basilare) del platonismo per la storia della mistica, andrebbe considerata e chiarita più a fondo, a meno che non si voglia intendere il platonismo alla luce della mistica di Eckhart (che, però, nei suoi sermoni, non specifica mai le sue fonti e non possedeva una conoscenza approfondita della filosofia platonica).
Per chiarire l’impostazione di fondo che caratterizza l’interpretazione che Vannini ci offre della mistica, può tornare utile, a mio avviso, il confronto con la fede filosofica di Karl Jaspers[261]. Nei giorni in cui mi sono occupato di questa tesi, e man mano che andavo scoprendo il pensiero di Vannini e la sua opposizione al dogmatismo, ho ravvisato una certa vicinanza, e finanche una complementarità, tra il richiamo al logos da parte di Vannini, e la fede filosofica jaspersiana.
Jaspers, nella fattispecie, denuncia il fallimento di ogni filosofia e, in generale, di ogni forma di conoscenza che si presenti come dogmatica e pretenda di comprendere in un sapere globalizzante l’essere che si sottrae invece a ogni comprensione, proprio perché costituisce l’orizzonte che tutto comprende (Umgreifende). Il dogmatismo non è fede, dato che rimane chiuso alla problematicità, al rischio, nella pretesa di possedere la sicurezza definitiva del successo e della verità.
Dal canto suo, la fede filosofica non conferisce a ciò che crede il valore di una verità universalmente valida, perché sa che questo carattere appartiene al sapere apodittico della coscienza in generale che presiede all’organizzazione scientifica del mondo, e non all’esistenza che, ubbidendo a un’esigenza incondizionata, oltrepassa il mondo per approdare a quella Trascendenza dove le categorie del mondo non hanno più valore. Convinta di non possedere una verità universalmente valida, la fede filosofica non condanna, non scomunica, non accende roghi, non dispone di libri sacri privilegiati rispetto ad altri, non si trincera in uno sterile e ottuso dogmatismo. Sa infatti che ciò in cui crede è autorevole non perché si impone sul mondo, ma perché rinvia alla Trascendenza; ma, allo stesso tempo, come si accennava, deve fare i conti con il rischio: rischio che ciò in cui crede possa o non possa rivelare la Trascendenza.
Sappiamo bene infatti che chi sceglie la via indicata da una determinata cifra fideistica corre il rischio del fallimento e, quindi, ha il dovere spirituale di non coinvolgere (o, peggio, costringere) gli altri in questo suo fallimento filosofico.
E tuttavia, come osserva Jaspers, ogni essere umano, con la sua cifra fideistico-esistenziale, rimane pur sempre aperto alla Trascendenza, come uno spiraglio da cui filtra la luce dell’infinito, per usare una frase di Confucio a proposito delle stelle del cielo; proprio per questo non può avere la pretesa di arrogarsi il possesso della verità assoluta.
E, infine, può la singolarità umana carpire per intero la Trascendenza? Certamente no, e anche ammesso che lo possa fare, forse non reggerebbe di certo. E poi, lo Spirito soffia dove vuole e non lo si può imbrigliare, come si è tante volte ripetuto in questa mia esposizione.
Note
[1] M. Vannini, Storia della mistica occidentale, Mondadori, Milano 2010, p. 40
[2] Ivi, p. 44.
[3] Ivi, p. 45.
[4] Ivi, p. 51.
[5] Ivi, p. 55.
[6] Ivi, p. 63.
[7] Ivi, p. 64.
[8] Ivi, p. 70.
[9] Ivi, p. 71.
[10] Ivi, p. 74.
[11] Ivi, p. 78.
[12] Ivi, p. 81.
[13] Ivi, p. 83.
[14] Ivi, p. 91.
[15] Ivi, pp. 93-94.
[16] Ivi, p. 95.
[17] Ibidem.
[18] Ivi, p. 98.
[19] Ivi, p. 99.
[20] Ibidem.
[21] Ivi, p. 100.
[22] Ivi, p. 102.
[23] Ivi, p. 104.
[24] Ivi, p. 115.
[25] Ibidem.
[26] Ivi, p. 116.
[27] Ivi, p. 118.
[28] Ivi, p. 119.
[29] Ivi, p. 119.
[30] Ivi, p. 125.
[31] Ibidem.
[32] Ivi, p. 128.
[33] Ibidem.
[34] Ivi, p. 130.
[35] Ivi, p. 135.
[36] Ibidem.
[37] Ivi, pp. 138-139.
[38] Ivi, p. 149.
[39] Ibidem.
[40] Ivi, p. 150.
[41] Ivi, p. 151.
[42] Ivi, p. 154.
[43] Ivi, p. 155.
[44] Ivi, p. 159.
[45] Ivi, p. 161.
[46] Ivi, p. 162.
[47] Ivi, p.163.
[48] Ivi, pp. 163-164.
[49] Ivi, p. 169.
[50] Ibidem.
[51] Ivi, pp. 179-180.
[52] Ivi, p. 181.
[53] Ivi, p. 184.
[54] Ivi, p. 186.
[55] Ivi, p. 187.
[56] Meister Eckhart, I sermoni, a cura di Marco Vannini, Ed. Paoline, Torino 2002, pp. 22-26.
[57] M. Vannini, Storia della mistica occidentale, cit., p. 188.
[58] Ivi, p. 203.
[59] Ivi, p. 208.
[60] Ibidem.
[61] Ibidem.
[62] Ivi, p. 209.
[63] Ivi, p. 210.
[64] Ivi, p. 211.
[65] Ivi, p. 212.
[66] Ivi, p. 215.
[67] Ibidem.
[68] Ivi, p. 218.
[69] Ivi, p. 220.
[70] Ivi, p. 221.
[71] Ivi, p. 222.
[72] Ivi, p. 224.
[73] Ivi, p. 226.
[74] Ivi, p. 229.
[75] Ivi, p. 230.
[76] Ivi, p. 231.
[77] Ivi, p. 242.
[78] Ivi, p. 242.
[79] Ivi, p. 243.
[80] Ibidem.
[81] Ivi, p. 245.
[82] Ivi, p. 253.
[83] Ivi, p. 254.
[84] Ibidem.
[85] Ibidem.
[86] Ivi, p. 261.
[87] Ivi, p. 262.
[88] Ibidem.
[89] Ivi, pp. 266-267.
[90] Ivi, p. 267.
[91] Ibidem.
[92] Ibidem.
[93] Ibidem.
[94] Ivi, p. 275.
[95] Ivi, p. 275.
[96] Ivi, p. 281.
[97] Ivi, p. 283.
[98] Ivi, pp. 284-285.
[99] Ivi, p. 290.
[100] Ivi, p. 290.
[101] Ivi, p. 292.
[102] Ibidem.
[103] Ivi, p. 294.
[104] Ivi, p. 296.
[105] Ivi, p. 297.
[106] Ibidem.
[107] Ivi, p. 303.
[108] Ivi, p. 305.
[109] Ivi, p. 306.
[110] Ivi, p. 309.
[111] Ivi, pp. 310-311.
[112] Ivi, pp. 311-312.
[113] Ivi, p. 313.
[114] Ibidem.
[115] Ivi, p. 314.
[116] Ivi, p. 315.
[117] Ibidem.
[118] Ivi, p. 318.
[119] Ibidem.
[120] Ivi, pp. 320-321.
[121] Ivi, p. 321.
[122] Ivi, p. 322.
[123] Ivi, p. 327.
[124] Ivi, p. 328.
[125] Ivi, p. 329.
[126] Ivi, p. 333.
[127] Ibidem.
[128] Ivi, p. 336.
[129] M. Vannini, Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2007, p. 21.
[130] Ivi, p. 24.
[131] Ivi, p. 27.
[132] Giovanni 16, 7-13.
[133] Si veda M. Vannini, Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2007, p. 32.
[134] Ivi, p. 36.
[135] Ivi, p. 37.
[136] Ivi, p. 38.
[137] Ivi, p. 42.
[138] Ivi, p. 44.
[139] Ivi, p. 45.
[140] Ivi, pp. 46-47.
[141] Ivi, p. 50.
[142] Ivi, p. 51.
[143] Ibidem.
[144] Ivi, p. 55.
[145] Ivi, p. 57.
[146] Ivi, p. 58.
[147] Ivi, p. 59.
[148] Ivi, pp. 60-61.
[149] Ivi, p. 63.
[150] Ivi, p. 67.
[151] Ivi, p. 69.
[152] Ivi, p. 70.
[153] Ivi, p. 72.
[154] Ivi, p. 77.
[155] Ivi, p. 80.
[156] Ivi, p. 83.
[157] Ivi, pp. 85-86.
[158] Ivi, p. 88.
[159] Ivi, p. 90.
[160] Ivi, p. 91.
[161] Giovanni 16, 7.
[162] M. Vannini, Mistica e filosofia, cit., p. 96.
[163] Ivi, p. 100.
[164] Ivi, p. 104.
[165] Ibidem.
[166] Ibidem.
[167] Ivi, p. 111.
[168] Ivi, p. 113.
[169] Ibidem.
[170] Ivi, p. 115.
[171] Ivi, p. 115.
[172] Ivi, p. 117.
[173] Ivi, p. 119.
[174] Ivi, p. 129.
[175] Ivi, pp. 137-138.
[176] Ivi, p. 138.
[177] Ivi, p. 139.
[178] Ivi, p. 140.
[179] Ivi, p. 146.
[180] Ivi, p. 152.
[181] Ibidem.
[182] Ivi, p. 154.
[183] Ivi, p. 155.
[184] Ibidem.
[185] Ivi, p. 156.
[186] Qualsiasi edizione.
[187] M. Vannini, Mistica e filosofia, cit., p. 160.
[188]8 Ivi, p. 164.
[189] Ibidem.
[190] Ivi, p. 169.
[191] Ivi, p. 171.
[192] Ivi, pp. 171-172.
[193] Ivi, p. 173.
[194] Ibidem.
[195] Op. cit.
[196] Ivi, p. 182.
[197] Ibidem.
[198] Ivi, p. 183.
[199] Ivi, p. 185.
[200] Ibidem.
[201] Ibidem.
[202] Ivi, p. 187.
[203] Ibidem.
[204] Ivi, p. 188.
[205] Ivi, p. 190.
[206] Ivi, pp. 193-194.
[207] Ivi, p. 195.
[208] Ivi, p. 197.
[209] Ivi, p. 198.
[210] Le Lettere, Firenze 2004.
[211]. Vannini, La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, Le Lettere, Firenze 2004, p. 179.
[212] Ivi, p. 182.
[213] Ivi, p. 183.
[214] Ivi, p. 193.
[215] Ibidem.
[216] Ivi, pp. 205-206.
[217] Ivi, p. 223.
[218] Ivi, p. 224.
[219] Ivi, p. 225.
[220] Ivi, p. 226.
[221] Ivi, p. 228.
[222] Ivi, p. 229.
[223] Ivi, p. 231.
[224] Ivi, p. 232.
[225] Ivi, p. 233.
[226] Qualsiasi edizione; Vannini usa Laterza, Bari 1975.
[227] Ivi, p. 269.
[228] Ivi, pp. 272-273.
[229][230] Ivi, p. 274.
[231] Ivi, pp. 277-278.
[232] Ivi, p. 283.
[233] Ivi, p. 287.
[234] Ivi, p. 288.
[235] Ivi, p. 288.
[236] Ibidem.
[237] Ivi, p. 289.
[238] Ibidem.
[239] IbiIbidemdem.
[240] Ivi, p. 290.
[241] Qualsiasi edizione.
[242] M. Vannini, La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, Le Lettere, Firenze 2004, cit., p. 291.
[243] Ivi, p. 299.
[244] Ivi, p. 303.
[245] Ivi, pp. 303-304.
[246] Ivi, pp. 313-314.
[247] Ivi, p. 314.
[248] Ivi, p. 315.
[249] Ivi, p. 316.
[250] Ivi, p. 319.
[251] Ivi, pp. 319-320.
[252] Ivi, p. 320.
[253] Ivi, p. 323.
[254] Ivi, p. 325.
[255] Qualsiasi edizione.
[256] M. Vannini, La morte dell’anima. Dalla mistica alla psicologia, cit., pp. 326-327.
[257] Ivi, p. 327.
[258] Ivi, p. 328.
[259] Ivi, p. 329.
[260] Ivi, p. 330.
[261] Si veda K. Jaspers, La fede filosofica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.
Bibliografia
Libri e articoli di M. Vannini
- Vannini, Filosofia e ascesi in Eckhart, in Giuseppe Beschin (a cura di), Filosofia e ascesi nel pensiero di Antonio Rosmini, Morcelliana, Brescia 1991.
- M. Vannini, Escatologia e mistica, in AA. VV, Sulle cose prime e ultime, Edizioni Augustinus, Palermo 1991.
- M. Vannini, Sulla mistica e il femminile, in P. Dinzelbacher – D. R. Bauer (cur.), Movimento religioso e mistica femminile nel Medioevo, Ed. Paoline, 1993.
- M. Vannini, Dall'illuminismo alla mistica, in AA.VV., Exodus, Congedi dal III millennio / z, Città Nuova Editrice/Augustinus, Roma 1994.
- M. Vannini, Filosofia e mistica. Un problema terminologico, in www.bibliotecacircolante.it, n. 18, maggio 199
- Vannini, La Weil e la discesa d'Amore, in Avvenire, 27/12/1998.
- Vannini, Agostino uomo “interiore”, in Avvenire, 14/2/ 1999.
- Vannini, Wittgenstein oltre il silenzio, in Avvenire, 11/7/1999.
- M. Vannini, Weil, la grazia alla fonte greca, in Avvenire, 18/7/1999.
- Vannini, La generazione del Logos. Da Giovanni a Eckhart, da Il volto del Dio nascosto, Mondadori Milano 1999.
- M. Vannini, Jakob Böhme, il teosofo di Silesius, in Avvenire, 24/6/2000.
- M. Vannini, Introduzione alla mistica, Morcelliana, Brescia 2000.
- M. Vannini, La morte dell'anima. Dalla mistica alla psicologia, Le Lettere, Firenze 2004.
- M. Vannini, L'universalismo mistico di Simone Weil, in Etica e politica / Ethics and Politics, VIII, 2006, 2, pp. 75-88.
- M. Vannini, Mistica e filosofia, Le Lettere, Firenze 2007.
- M. Vannini, Che senso ha la teologia?, in http://mondodomani.org , 20-21 marzo 2009
- M. Vannini, Storia delle mistica occidentale, Oscar Mondadori, Milano 2010.
Articoli su M. Vannini
- E. Bianchi, I mistici medievali, maestri d'azione, in La Stampa, 24/4/1999.
- G. Ravasi, Meister Eckhart, in Il Sole 24 Ore, 9/5/1999.
- A. Armati, Nietzsche, Dioniso o crocefisso?, in Avvenire, 15/8/2000.
Libri e articoli sul rapporto tra mistica e filosofia
4) K. Rahner, Visioni e profezie, Vita e Pensiero, Milano 1995.
5) A. Zichichi, Perché io credo in Colui che ha fatto il mondo, Mondolibri, Milano 2000.
6) Plotino, Enneadi, a cura di G. Faggin, Bompiani, Milano 2004.
7) Cusano, Il Dio nascosto, Laterza, Roma-Bari 2004.
8) K. Jaspers, La fede filosofica, Raffaello Cortina Editore, Milano 2005.
9) E. Swedenborg, Cielo e inferno, a cura di Paola Giovetti, Edizioni Mediterranee, Roma 2005
10) Meister Eckhart, I sermoni, a cura di M. Vannini, Paoline, Milano 2005.
11) Giovanni della Croce, Notte oscura, Edizioni OCD, Roma, 2007.
12) R. Talmelli, Ecco, io vedo i cieli aperti..., Edizioni OCD, Roma 2008.
13) E. Hillesum, Diario (1941-1943), Adelphi Edizioni, Milano 2010.
14) I, Kant, I sogni di un visionario. Spiegati coi sogni della metafisica, BUR, Milano 2010.
Ringraziamenti
Ringrazio, in primo luogo, il ch.mo professor Ferdinando Marcolungo, per la sua disponibilità, la sua perizia, e la sua assidua e preziosa direzione di questo lavoro.
Ringrazio la mia famiglia, mio padre, mia madre, mio fratello, mia nonna materna e mio nonno materno (che riposa ora nella pace di Dio e che, al contempo, sempre sento accanto a me): senza di loro, la mia intera carriera universitaria, nonché la mia vita su questa Terra, non avrebbero potuto esistere e sussistere.
Ringrazio il mio amico Emanuele Bettero, per la sua costante e sempre gradita presenza, nonché per i suoi consigli, specialmente in momenti difficili che ho incontrato nel mio percorso.
Ringrazio i miei Maestri di Jujitsu, Maestro Roberto e Maestro Werner, per i loro insegnamenti non solamente di natura tecnica, ma anche e soprattutto spirituale, che mi hanno permesso e mi permettono di far fronte a diversi aspetti della mia vita, non soltanto per quanto concerne la carriera universitaria.