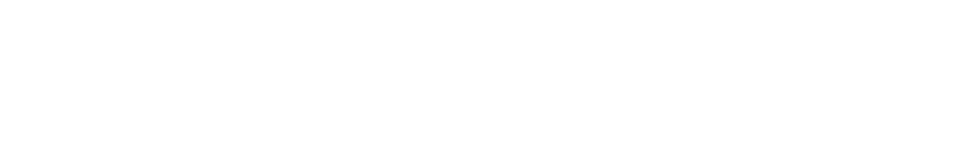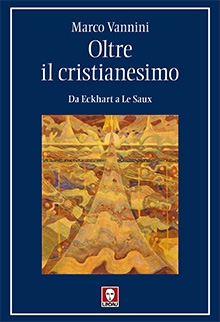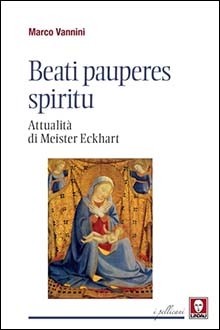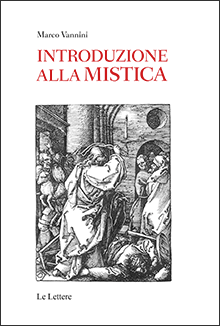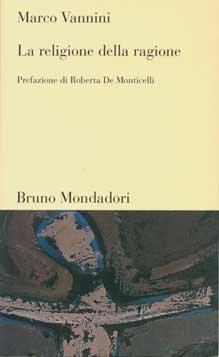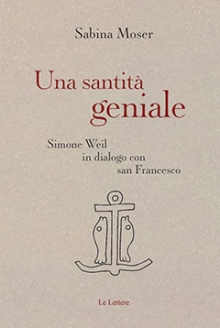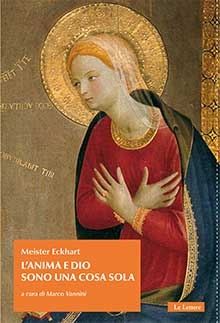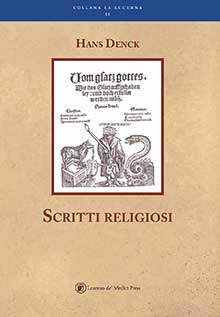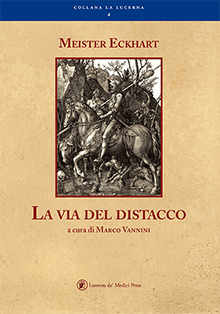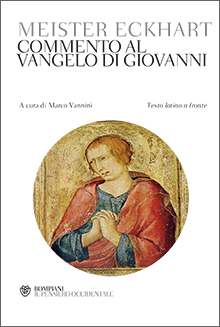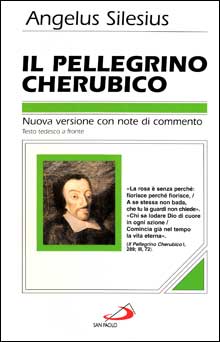Simone Weil. Attesa di Dio
La rinuncia a se stessi come cuore del secolo.
Il Manifesto - Alias, 25 ottobre 2008.
“Ho scelto il titolo Attesa di Dio perché era caro a Simone; ella vi scorgeva la vigilanza del servo che attende ansioso il ritorno del padrone” : così, con chiaro riferimento alla parabola evangelica, il domenicano Joseph-Marie Perrin introduceva la raccolta di scritti della Weil da lui pubblicata per la prima volta nel 1950. Dopo alcune precedenti edizioni italiane, approssimandosi il centenario della nascita della scrittrice francese, vede oggi la luce questa Attesa di Dio, a cura di Maria Concetta Sala, con un saggio di Giancarlo Gaeta (Biblioteca Adelphi), ampio volume con una ricca serie di appendici e di note.
Esso contiene innanzitutto sei lettere, dei primi mesi del 1942, indirizzate a padre Perrin, il religioso di Marsiglia con cui Simone fu in amichevole contatto, in cui spiega le ragioni che le impediscono di entrare nella Chiesa cattolica. Vi sono poi sei saggi, più o meno coevi, essenzialmente dedicati al tema dell’amore di Dio, tra i quali almeno due, Forme dell’amore implicito di Dio e L’amore di Dio e la sventura, sono tra le cose più belle e significative della Weil. Non a torto perciò Cristina Campo, nella Introduzione (firmata con lo pseudonimo di Benedetto P. d’Angelo) a una precedente edizione, definiva questo libro “un libro immenso. Un grande classico cristiano, o, più esattamente forse, un grande classico precristiano”.
Il titolo Attesa di Dio è davvero felice, e perciò gli editori successivi non hanno creduto di modificarlo, perché la dimensione dell’attesa, nel raccoglimento, nella vigilanza, nell’ attenzione (si noti la parentela linguistica e concettuale tra attesa e attenzione!), costituisce uno degli elementi essenziali del pensiero weiliano. L’ attesa/attenzione presuppone infatti che si sia lasciata ogni altra occupazione e ogni altro fine e si sia tutti rivolti a ciò che deve o può av/venire. Presuppone dunque un completo distacco, una completa libertà da tutto ciò che non riguardi quella stessa attesa/attenzione, lasciando “il proprio pensiero disponibile, vuoto e permeabile all’oggetto”.
Che si tratti dello studio scolastico – un problema di geometria, una versione di latino – o della ricerca di Dio, l’attenzione è l’unica cosa richiesta, ciò senza cui la ricerca non è possibile – anzi, è falsa. Perché quello che si richiede è solo “uno sguardo attento, in cui l’anima si svuota di contenuto proprio per accogliere in sé” quella realtà che solo così “essa vede nel suo aspetto vero”.
E’ evidente che l’attesa/attenzione di cui Simone parla, nel vuoto fatto in se stessi, fa tutt’uno con l’onestà intellettuale, in forza della quale si cerca la verità così come essa è, e non come serve ai nostri interessi, più o meno nobili. Sotto questo profilo l’attesa/attenzione presuppone anche la fine di ogni nostro pregiudizio, la libertà da ogni opinione, e, nello specifico caso del divino, la fine di ogni “immaginazione riempitrice di vuoti”. Proprio il vuoto, nel suo senso di purezza e disponibilità ad accogliere la luce, è uno dei termini-chiave dell’esperienza religiosa di Simone, che perciò giustamente Gaeta, nel saggio che chiude il volume in oggetto, iscrive in un “cristianesimo mistico”, ovvero in quella “autentica ispirazione cristiana conservata, secondo Simone Weil, soltanto dalla mistica” ( pp. 348-349).
Alla scrittrice francese, arrivata al cristianesimo per una libera ricerca intellettuale e dunque non gravata dalla precomprensione indotta dalle Chiese, non sfuggiva infatti il punto chiave: l’insegnamento essenziale di Gesù è quello dell’ abrenuntiare se ipsum, rinunciare a se stessi, odiare la propria anima, perché solo così essa si rende capace di accogliere Dio. Dunque la conversione non consiste nell’assumere una nuova credenza, ma in una “radicale trasformazione dell’anima” ( p. 346), che passi dall’amore di sé, dal naturale egoismo, all’amore soprannaturale di Dio – ove Dio, beninteso, non è l’oggetto amato, ma il soggetto che ama. Stante la distanza infinita che separa la necessità dal Bene, che è – platonicamente – sempre al di là dell’essere, all’uomo non è concesso infatti di “conoscere Dio” e neppure di “amare Dio”: ciò che può – e deve – fare è soltanto rifiutare di assumere idoli al posto di Dio e di amare cose che Dio non sono. Pati divina, dunque, souffrir Dieu, ossia lasciare che Dio agisca in noi: questo il nucleo mistico del pensiero religioso della Weil, alla luce del quale si comprendono due aspetti essenziali della sua riflessione, che compare in modo eminente in queste pagine: il primo è lo straordinario rilievo che ha in essa la sventura, il malheur (“parola mirabile; senza equivalenti in altre lingue. Non se n’è tratto profitto”, come scrive nei Quaderni ); il secondo la sostanziale indipendenza, anzi, distacco, da tutte le Chiese.
La sventura è infatti una cosa a sé, specifica, irriducibile, tutt’altro dalla semplice sofferenza: è qualcosa che “si impadronisce dell’anima e le imprime in profondità il suo marchio, quello della schiavitù”( p. 171). Si tratta della schiavitù essenziale dell’uomo, quella alla necessità, ovvero al cieco gioco di forze meccaniche (la pesanteur ) che rende l’uomo una cosa, al pari delle foglie o dei sassi. La sventura “sradica dalla vita, equivale, più o meno, alla morte”, per cui l’anima colpita dalla sventura è come la farfalla appuntata viva su un album, che si dibatte senza poter far nulla. Nello stesso tempo, però, la sventura rivela all’uomo con indiscutibile chiarezza la sua soggezione alla necessità, smontando le sue illusorie pretese di libertà, intorno alle quali si erge la tronfia costruzione dell’ io, ovvero l’ostacolo essenziale alla discesa di Dio nell’anima.
E, d’altra parte, la sventura non impedisce all’anima di mantenere il suo amore, ovvero il suo orientamento verso la verità, verso il Bene (“bisogna soltanto sapere che l’amore non è uno stato d’animo, ma un orientamento”), per cui l’anima che resta orientata verso Dio mentre è trafitta dal chiodo della sventura si trova ormai affrancata dalla pesanteur, “alla presenza stessa di Dio”. Sotto questo profilo, dunque, “la sventura è una meraviglia della tecnica divina” (p. 188).
E’ chiaro, in secondo luogo, che l’esperienza della Weil, per quanto vicina al cristianesimo e in particolare alla figura del Cristo, era inconciliabile con l’appartenenza ecclesiastica. Proprio le lettere a padre Perrin presenti in questo libro mostrano che ella non accetta, per onestà, le pretese della Chiesa di essere unica depositaria della verità e unica mediatrice di salvezza. Infatti la luce di Dio risplende in ogni tempo e in ogni luogo e non ha bisogno di mediazioni: le basta trovare un’anima vuota e in attesa di riceverla. Al cattolicesimo Simone rimprovera poi di aver fatto propria quell’ “idolatria sociale” che era per un verso dei Romani e per altro degli Ebrei, mettendo in secondo piano il suo autentico spirito di verità, che gli proviene invece dalla “fonte greca” e che è apparso soltanto nella civiltà catara. “Viviamo in un’epoca che non ha precedenti – conclude – e nell’attuale situazione l’universalità, che una volta poteva essere implicita, deve essere pienamente esplicita” (p. 58).
Purtroppo non si può fare a meno di convenire, ancora oggi, con quanto Gaeta già da tempo aveva rilevato : per una serie di censure e di tabù, il mondo cattolico ha rinunciato ad appropriarsi della Weil, e questa rinunzia è la manifestazione dell’impotenza a confrontarsi liberamente con la più alta esperienza spirituale del Novecento.