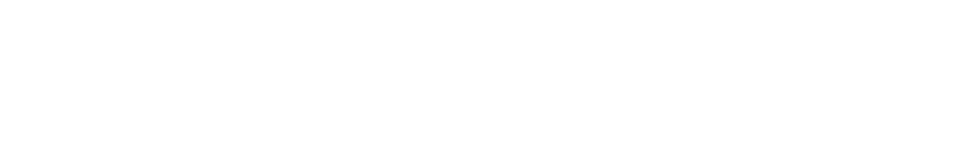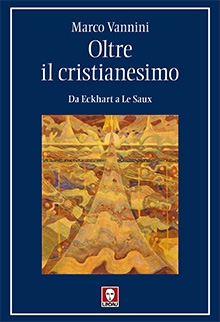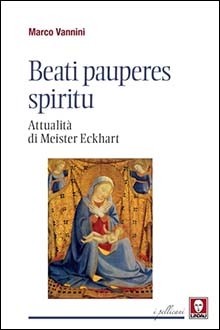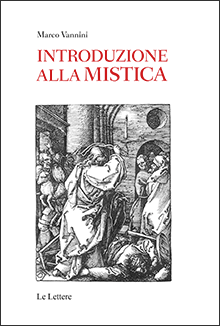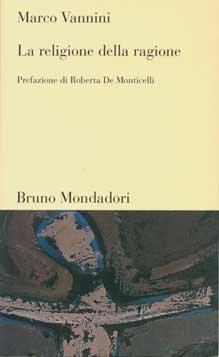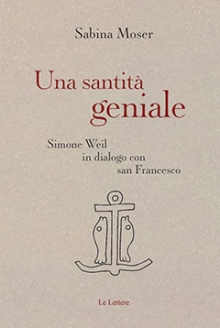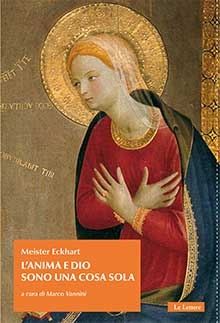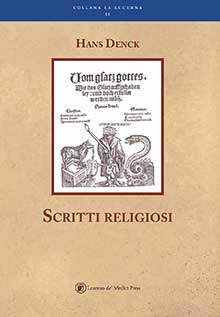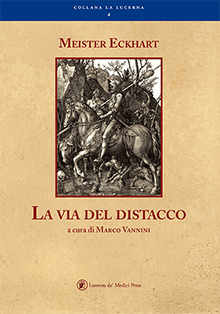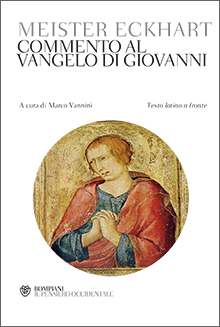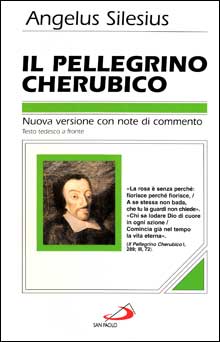Dante cataro? Una tesi ardita e paradossale
L'Osservatore Romano, 1 dicembre 2016
di Marco Vannini
Nel cuore di Firenze, a pochi passi da Santa Maria Novella, al centro di una piazzetta una croce in pietra ricorda lo scontro armato lì avvenuto nel 1244 tra cattolici e catari. Catari erano infatti presenti nella città sull’Arno in una proporzione che l’inquisitore domenicano Raniero Sacconi, che scrive in quegli anni la sua Summa de catharis, stima un terzo della popolazione, particolarmente nelle classi colte e nobili. Catare erano molte famiglie illustri, come i Nerli; cataro era Farinata degli Uberti che, morto nel 1264, fu condannato come eretico nel 1283 e la sua bara bruciata pubblicamente, mentre i beni di figli e nipoti venivano confiscati, dal momento che un crimine così orrendo come l’eresia andava punito non solum in vivos sed etiam in mortuos et etiam in heredes, come suonava appunto la legge inquisitoriale.
Nel 1283 Dante aveva diciotto anni e avrà probabilmente assistito al rogo della bara di Farinata (come non pensare alla somiglianza con la pena cui il capo ghibellino è sottoposto nell’Inferno!); cataro era il caro amico Guido Cavalcanti, per cui l’ipotesi di un Dante cataro, o comunque simpatizzante per i catari, non è poi così peregrina: è quanto ha sostenuto Maria Soresina nel suo Libertà va cercando. Il catarismo nella Commedia di Dante (Moretti e Vitali) uscito qualche anno fa, nel 2009.
Per chi, come chi scrive, è abituato a pensare all’Alighieri come al poeta cattolico per eccellenza, la tesi del libro suona ardita, quasi paradossale, ma va riconosciuto all’autrice il merito di avere rivolto l’indagine a un settore che — stranamente — gli studiosi non avevano mai preso in considerazione.
In primo luogo va detto che il suo libro è una precisa, puntuale analisi del testo, ove il fine di evidenziare come il catarismo sia una fonte primaria della Commedia (e non solo: si fa riferimento anche al Convivio e alle altre opere del poeta fiorentino ) è sostenuto su base rigorosamente filologica e storica, e non ha niente in comune con gli esoterismi e le fantasie che hanno spesso trovato alimento nel poema e che oggi vanno tanto di moda.
Per questo medesimo motivo, in secondo ma non secondario luogo, va detto che alcuni cruciali passi delle tre cantiche trovano nell’ambito della dottrina catara una spiegazione più convincente che non in quello tradizionale, di tipo tomista. Del resto, che il poeta percorra una via intellettuale autonoma, rivendicando una propria missione profetica, non era sfuggito a nessuno, né nel remoto passato, in cui la Commedia era stata condannata da molti teologi, né al presente: basti ricordare Hans Urs von Balthasar, che rileva acutamente come all’Alighieri sia del tutto estranea l’idea di redenzione e la croce reale di Cristo, ovvero la dottrina fondamentale del cristianesimo.
«Che il Padre consideri la Crocifissione del proprio Figlio unigenito come vendetta, cioè sfogo della sua ira contro un Innocente che paga per gli uomini colpevoli, né i Padri né i Dottori l’hanno mai detto ed è arditezza tale che soltanto l’Alighieri poteva permettersi» aveva già scritto Giovanni Papini a proposito del canto settimo del Paradiso.
Piccoli segni — a volte una sola parola del poema, posta però significativamente in evidenza — o interi canti sembrano comunque confermare la tesi di Maria Soresina, o, almeno, costringono a interrogarsi seriamente sulla sua interpretazione. Lo spazio di una rilettura non permette di darne conto, ma per chiunque conosca e ami la Divina Commedia, il libro è comunque avvincente. Nello stesso tempo esso contribuisce a gettare luce su un mondo, quello cataro, completamente scomparso, cui però alcuni — pensiamo ad esempio a Simone Weil — hanno guardato quasi come alla vera realizzazione dell’ideale cristiano.
“Buoni cristiani” chiamavano infatti se stessi quelli che noi chiamiamo catari, rivendicando il loro legame col cristianesimo delle origini, nel quale si trovava la dottrina che distingue nell’uomo tre componenti: corpo, anima e spirito (cfr. 1 Tessalonicesi 5, 23). La distinzione, anzi, l’opposizione tra anima e spirito (cfr. 1 Corinzi 2, 14-16) era essenziale per i catari, per i quali lo spirito è la scintilla divina, imprigionata nel corpo e nell’anima, anelante a tornare alla sua patria, ovvero al mondo di luce dal quale proviene. Questa idea era, nel catarismo, strettamente unita alla credenza nella reincarnazione (della quale l’autrice addita le tracce nella Commedia), ma non v’è dubbio che essa abbia il suo fondamento primario nella filosofia classica, nell’esperienza dell’intelletto attivo aristotelico, che è “separato, divino”, e proviene all’uomo “dall’esterno”, esperienza assolutamente indipendente dalla credenza nella reincarnazione.
In questo cruciale punto lo studio di Maria Soresina si interseca con quelli, ben noti, sull’averroismo di Dante, aprendo spazi di ricerca nuovi e affascinanti: pensiamo, ad esempio, al rapporto con l’eresia cosiddetta del “libero spirito” e con Eckhart, contemporaneo del poeta fiorentino.