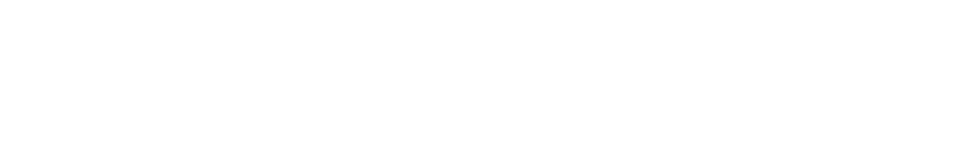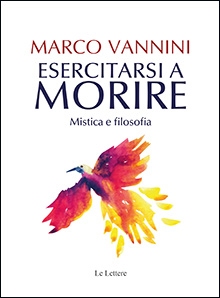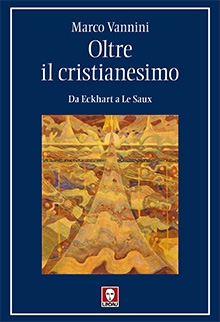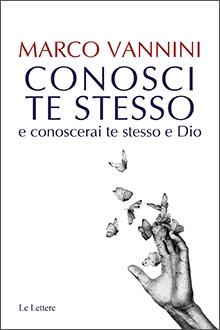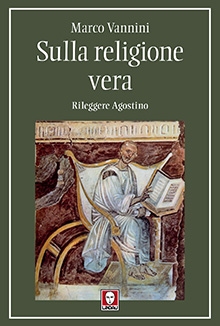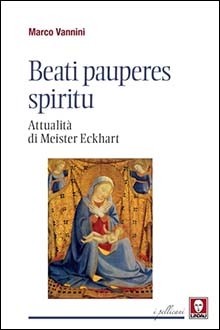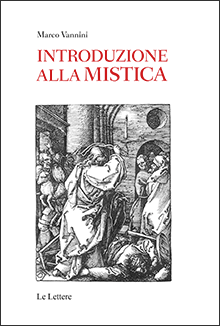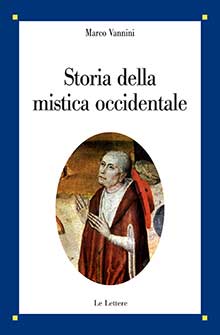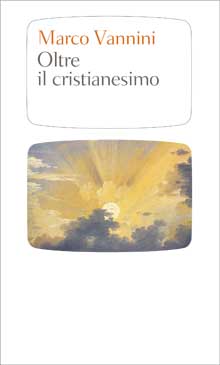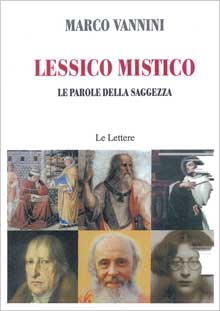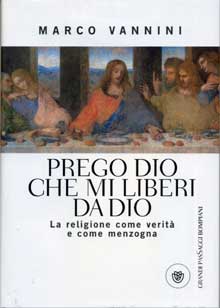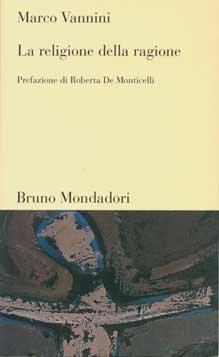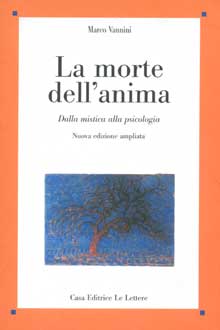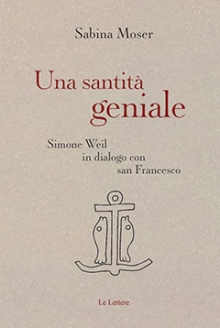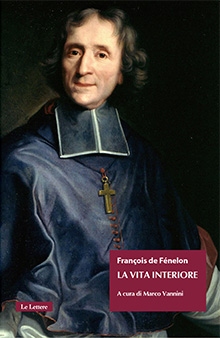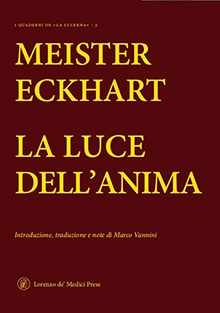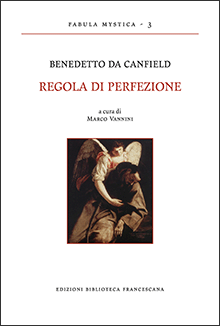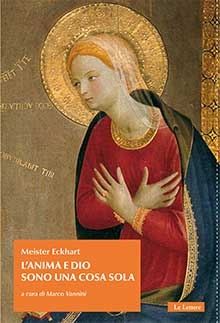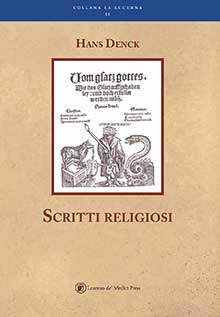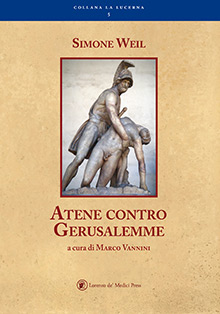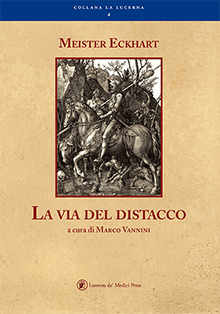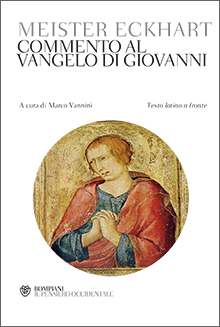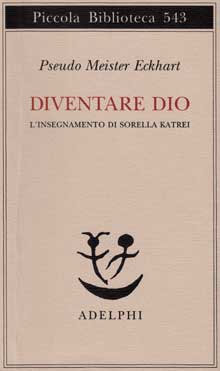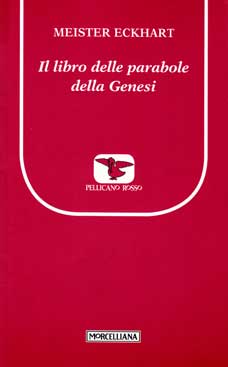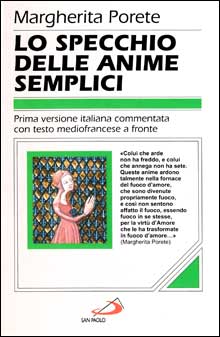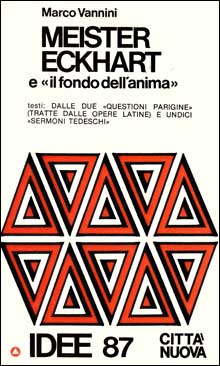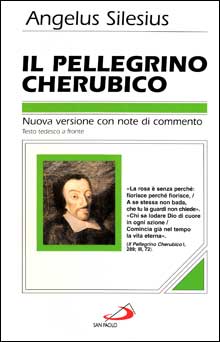Convenienza della notte
Il Manifesto - Alias, del 12 febbraio 2011
di Marco Vannini
“Sono rimasto molto sorpreso, vi assicuro, di vedere che voi volete rimettervi al giudizio dei teologi per una questione che non è di loro competenza : se si trattasse di processi o di casi di coscienza, sarebbe giusto chiedere consiglio ai giuristi o ai teologi; ma, quando si tratta della perfezione, si deve consultare solo chi la pratica”: così il francescano san Pietro d’Alcantara scriveva un giorno a santa Teresa d’Avila, che voleva consultare i teologi in merito alla sua vita interiore e alle sue fondazioni di monasteri. I teologi, scriveva del resto anche Hegel, sono come ragionieri, che tengono i conti di una ricchezza estranea, che non appartiene loro - testimonianza eloquente di un conflitto che da sempre separa mistica e teologia: la prima rapporto tra l’anima e Dio, senza mediazione alcuna; la seconda riflessione estrinseca sul divino, sempre mediata dalla cultura e perciò irrimediabilmente ideologizzata. Questo conflitto viene subito in mente di fronte agli scritti di san Giovanni della Croce, che oggi sono ripresentati in tutta la loro interezza nella splendida edizione Bompiani, Tutte le opere , con testo originale a fronte, a cura di Pier Luigi Boracco (Milano 2010, pp. 2330, euro 45,00). Sì, perché da sempre ci si chiede chi sia il destinatario “naturale” di questi scritti, che vanno dalle poesie, unanimemente considerate un capolavoro della letteratura castigliana e perfettamente fruibili nella loro liricità, alla descrizione precisa delle “notti” spirituali che si devono attraversare per giungere all’unione con Dio – pagine, queste, ardue come poche altre. La separazione fede-ragione, tanto superficiale quanto consueta nel nostro mondo, destina normalmente l’opera sanjuanista al teologo, o meglio ancora al lettore devoto, preferibilmente un religioso o una religiosa, alle prese con il suo “cammino di perfezione” (come recita il titolo di un’opera di santa Teresa d’Avila, che fu la grande amica, madre e figlia spirituale insieme, di san Giovanni della Croce). Ma non è proprio così: si può infatti a buon diritto sostenere che gli scritti del mistico castigliano costituiscano un grande classico filosofico, ed è perciò del tutto legittimo questo loro inserimento nella Collana “Il pensiero occidentale” . Il secolo appena trascorso ha, del resto, conosciuto, non solo all’interno del mondo cattolico, ma a livello del dibattito filosofico più generale, una grande riscoperta dell’opera sanjuanista: non è un caso se la monografia di gran lunga più fine su di essa, e, insieme, sul significato dell’esperienza mistica, si debba a uno studioso formalmente agnostico, il francese Jean Baruzi. Più di recente si è riscoperta e sottolineata la grande vicinanza e finanche la dipendenza di Giovanni della Croce da Plotino e, attraverso lui, dalla grande corrente neoplatonica che innerva tanto la mistica quanto la filosofia occidentale: non è forse vero, come sosteneva il compianto Pierre Hadot, che è la mistica la vera continuatrice della filosofia classica? Come nota anche un altro importante studioso del santo spagnolo, il gesuita Georges Morel, vanno rilevate innanzitutto le similitudini che egli presenta col più “mistico” dei filosofi d’ occidente, ovvero Spinoza: entrambi hanno provato la passione dell’ Assoluto, entrambi hanno desiderato non i segni, ma la realtà stessa; entrambi hanno riconosciuto che Dio non è accessibile che tramite Dio stesso e che, in verità, è la causa che manifesta gli effetti, ben più che l’inverso: “L’anima conosce le creature attraverso Dio e non Dio attraverso le creature […] Questo secondo modo di conoscere è secondario, essenziale è il primo”, scrive infatti, quasi anticipando il filosofo olandese, Giovanni della Croce in Fiamma viva d’amore (IV, 5). Ma, ben oltre Spinoza, è con Hegel che il mistico castigliano ha una profonda consonanza. Si vedano le strette somiglianze tra certi temi della Fenomenologia dello spirito e quelli della Notte oscura o del Cantico spirituale: senza voler praticare il minimo concordismo, è raro veder sorgere dal fondo dell’essere umano questo medesimo appello: l’ Assoluto, e non delle immagini! Per Giovanni della Croce come per Hegel l’ accesso al regno dello spirito presuppone necessariamente un lungo e paziente soggiorno nella “notte”, nella sofferenza, tanto che per entrambi si può dire che al centro del loro pensiero stia l’idea della morte, ovvero il riconoscimento della finitezza radicale delle cose come motore di quel movimento grazie al quale si esce per così dire da noi stessi e si riesce a guardare in faccia l’ Assoluto. La Fenomenologia dello spirito (dello spirito , appunto!) e l’opera del mistico castigliano sono entrambe la storia di un individuo che, morendo alla sua particolarità, portando a compimento ed esaurendo tutte le “figure” incontrate sulla sua strada, penetra infine nel mondo vero, non-figurativo. È grazie ad Hegel che la morte è reintrodotta al centro del reale, non per costrizione, non per accettazione stoica, ma per il lucido e libero riconoscimento dell’eterno all’opera nel mondo; ma quella che il filosofo tedesco chiama “morte” – erede in ciò di una tradizione che risale a Platone, ovvero al concetto di filosofia come melètema thanàtou , esercizio di morte, che percorre tutta la storia della mistica - è precisamente ciò che Giovanni della Croce chiama “notte”.
Il volume cui ci riferiamo presenta gli scritti del mistico castigliano iniziando con le Lettere , ritenendo che esse, insieme agli scritti cosiddetti minori, possano fornire un a prima introduzione alle più impegnative opere maggiori – Cantico spirituale , Fiamma d’amor viva , Salita del monte Carmelo , Notte oscura – poste invece al termine del volume. La scelta del Curatore, cui si deve anche un’ ampia Introduzione, è largamente condivisibile, anche perché queste lettere - spesso originate dalle ingiustizie e dalle sofferenze che a Giovanni della Croce furono provocate dai suoi confratelli, che lo tormentarono sempre, da quando lo rinchiusero nell’orrido carcere di Toledo, infliggendogli la tortura, e fin sul letto di morte - testimoniano una grandezza d’ animo quasi unica nella storia della spiritualità cristiana: nessuna accusa, nessun compianto per la propria sorte, rinuncia a difendersi, serenità e distacco completo, anche se di quando in quando affiora la sua tristezza ( filii matris meae pugnaverunt contra me , scrive infatti una volta, citando il Cantico dei Cantici ). Come nota giustamente Baruzi, già da queste lettere si mostra la sua fisionomia spirituale, che si può qualificare come imparagonabile, nello stretto senso della parola.
Tra le Lettere e le opere maggiori stanno le Poesie , che, con il loro linguaggio universale, sono per così dire al confine con la mistica, ed è infatti del commento proprio di alcune di esse che constano le opere maggiori del santo spagnolo.
Come tale, questo grosso volume ha perciò in Italia solo un termine di paragone, ovvero le Opere a cura della Postulazione Generale dei Carmelitani Scalzi (Roma 1967) e, in confronto a questo, gode dell’ incomparabile vantaggio di presentare il testo originale a fronte (pregio di tutta la Collana in cui è inserito). Non ha però le prime redazioni del Cantico spirituale e della Fiamma d’amor viva (le cosiddette versioni A), presenti invece in quelle Obras completas (Madrid, 1957) cui fanno riferimento entrambi i volumi, e neppure un Indice analitico. A parte altre piccole discordanze relative agli scritti minori, si può rilevare, infine, che, proprio all’opposto di quanto fa l’edizione dei Carmelitani sopra citata, è qui presente la bellissima immagine autografa del “Monte di perfezione” con la relativa descrizione, ma manca l’altrettanto significativo grafico del “Monte Carmelo”, tracciato dal santo per la figlia spirituale suor Maddalena, con tutti i suoi nada , nì eso, nì esotro , che tanto da vicino richiamano i neti, neti (“non questo, non questo”), delle Upanishad.
L'interesse maggiore dell’ opera sanjuanista è dato proprio dall'importanza centrale che il nulla, la “notte”, ovvero la negazione, hanno nella sua esperienza spirituale . La negazione costituisce infatti il nucleo del suo concetto di fede, che viene così sganciata completamente dal suo aspetto di credenza in questa o quella verità esteriore, legata alla storia o all'immaginazione teologica, e còlta invece nella sua essenza di movimento di tutta l'anima verso l' Assoluto, che rimuove perciò ogni relativo, ogni contenuto determinato, sia esso frutto dell'immaginazione o legato a qualche presunto evento storico. Di qui l’attualità del pensiero sanjuanista: nel nostro tempo la verità fattuale su cui la religione pensava fondarsi è apparsa, infatti, largamente insussistente e quella teologica è stata riconosciuta per ciò che è, ossia mero prodotto delle culture, variabile al pari di esse, per cui la fede viene spesso ridotta alla dimensione soggettiva del puro sentimentalismo, incapace perciò di vincere quella battaglia contro il “relativismo” che essa tenta spesso, pateticamente, di ingaggiare.
Se invece la fede viene riconosciuta per quello che è, “notte oscura che non solo non produce nozione o scienza, ma che, anzi, priva l'anima di qualsiasi notizia e conoscenza”, ovvero la costringe a guardare coraggiosamente in faccia il suo nulla, sciogliendo i legami che tengono avvinto l' io al suo egoismo e prigioniera l'intelligenza, allora appare in tutta la sua evidenza lo straordinario valore di questi scritti. Un valore in primo luogo psicologico, in quanto si tratta innanzitutto della conoscenza di se stessi, e poi anche “religioso”, giacché è da essa - ripete san Giovanni coi suoi maestri antichi – che deriva la conoscenza di Dio. Ma non la conoscenza di un oggetto-Altro, bensì una unione d'amore – ed amore era ed è, infatti, quella fede che ha compiuto il faticoso cammino, che ha salito il monte Carmelo, conducendo a beatitudine infinita. Non meraviglia perciò che il freddo, duro mistico castigliano, che incessantemente ripete i suoi “nulla”, sia anche l' appassionato poeta d'amore per tutte le creature, per tutta la natura, di cui canta la muta bellezza. A la tarde te examinaràn en el amor : alla sera, cioè alla fine della tua vita, è sull' amore che sarai giudicato, scrive, e sul letto di morte chiese che non gli recitassero preghiere funebri, ma gli leggessero invece il canto d’amore più bello che conosceva: il Cantico dei Cantici.