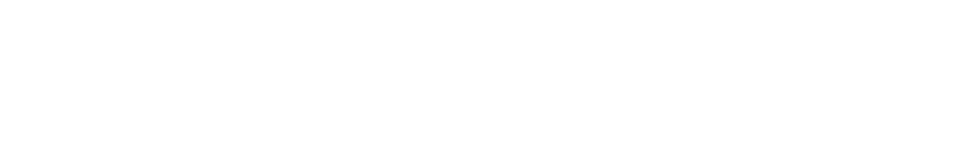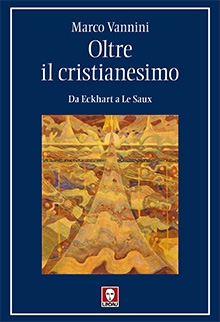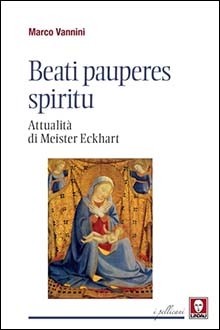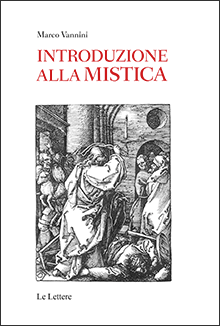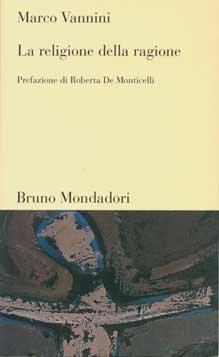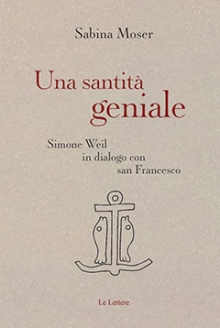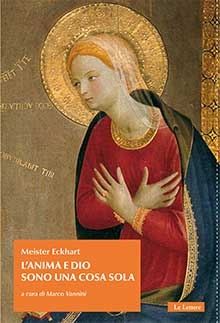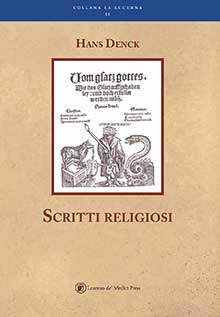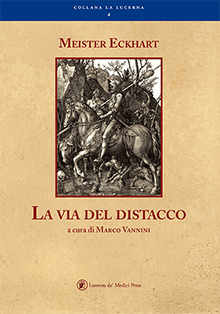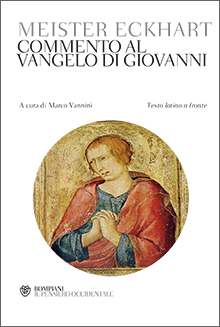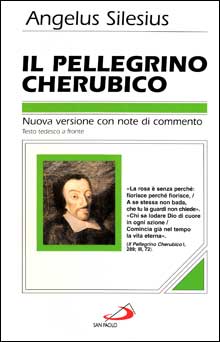L'interrogativo di Giobbe e la risposta del Logos
L'interrogativo di Giobbe e la risposta del Logos* , in: La domanda di Giobbe e la razionalità sconfitta, a cura di C. Gianotto, Ed. Università di Trento. Dipartimento di Scienze Filologiche e Storiche 1995, pp. 103-116. [presente anche in <Paradosso - Quadrimestrale di filosofia – Pagus Edizioni>, 5, 1993, pp. 175-186].
Marco Vannini
In questo mio piccolo contributo vorrei delineare la risposta all'interrogativo jobico sul male, sul dolore e sul suo "perché", quale si presenta nel mondo classico e in quello cristiano, secondo la linea che chiamerò del Logos. Secondo questa linea, la ragione non riceve scacco, ma risponde pienamente alla domanda, in quanto essa non è solo la piccola, limitata, ragione umana, ma il Logos stesso, che è Dio.
1. Alle origini della riflessione greca troviamo proprio il concetto di kosmos, cioè di un tutto ordinato, bello e buono, e il primo filosofo del Logos, Eraclito, scrive che "per la divinità tutte le cose sono belle, buone e giuste; gli uomini invece alcune cose ritengono ingiuste e altre giuste" (fr. 102). Il senso del frammento è che gli uomini si sbagliano perché sono "dormienti", non è vivo in essi il Logos, giacché i "desti" — cioè in coloro in cui vive il Logos — non pensano affatto il male, ma hanno lo stesso punto di vista del dio. Tutto ha una ragione, tutto ha una causa, e perciò tutto è giusto e buono — per quanto possa causare soggettivamente dolore —. Questo è il primo e fondamentale punto da sottolineare: il dolore e il male sono in rapporto al soggetto, al suo inter-esse nelle cose; scompaiono quando scompare questo inter-esse, e soprattutto quando si annulla il soggetto, nella sua alterità dall'essere. Il punto di vista di Dio, il punto di vista del logos, è quello "a tutti comune" (fr. 2), quello universale, non mio opposto a tuo, non determinato da un fine, da un "perché". Non vi sono "perché": «l'eterno è un fanciullo che gioca, che gioca a dadi; il suo regno è il regno di un fanciullo» (fr. 52). La concezione eraclitea di Dio e del cosmo è priva di ogni pregiudizio utilitaristico, e, non a caso, non v'è in essa la creazione: «questo cosmo nessuno degli dei lo fece, né degli uomini, ma sempre fu, è e sarà, fuoco che a misura si accende e a misura si spegne» (fr. 30).
Si noti bene che non v'è in ciò nessuna negazione o disprezzo per il dolore: è pur sempre il genio greco che ha prodotto la tragedia, e mai meditazione sulla sofferenza fu così grande come nel suo primo capolavoro, l'Iliade . Giustamente scrive Simone Weil che niente lo uguaglia in profondità e purezza: certo non la Bibbia, tutta intrisa di idolatria sociale (il pregiudizio di essere la nazione eletta da Dio), e in essa - guarda caso - solo "talune parti del poema di Giobbe" hanno un suono paragonabile a quello dell'epopea greca.[1] Non ha perciò alcun senso affrontare il problema accumulando esempi di dolore e di male, a piacere: campi di sterminio hitleriani o staliniani, massacri ed "olocausti", ecc. Per un certo verso, infatti, il problema del male è tutto contenuto nella sofferenza di un singolo essere - direi anche, evangelicamente, di un solo passerotto -; per altro verso, poi, non vi sono massacri o stermini sufficienti a toccare un problema che non è di macelleria, ma di filosofia.
Proseguendo in questa riflessione, tutta orientata sulla giustizia (ancora la Weil: il pensiero greco fu grande perché ebbe un unico problema, quello della giustizia), Platone - colui al quale dobbiamo non solo la parola "teologia", ma, credo, anche la cosa - afferma che è necessario che ci siano i mali, «giacché è pur necessario che ci sia sempre qualcosa di contrario al bene; né possono aver sede tra gli dèi, ma di necessità devono aggirarsi intorno alla natura mortale e a questi luoghi terreni. Ed anche perciò a noi conviene adoperarci a fuggire di qui al più presto per andarcene lassù; e questo fuggire è assomigliarsi a Dio per quanto è possibile, e assomigliare a lui vuol dire acquistare giustizia e santità con intelligenza» ... «ma la verità, diciamolo chiaro, è questa: che Dio non è in nessun caso, per nessuna maniera, ingiusto, ma in sommo grado giustissimo; e non c'è nulla di più simile a lui di chi tra noi sia divenuto, a sua volta, giustissimo quanto può» (Teeteto, 176): Dio è buono, e da lui vengono solo beni, come dall'uomo giusto, simile a Dio.
È fin dall'inizio evidente la differenza profonda tra questo concetto e quello biblico: Giobbe è convinto che da Dio vengano anche i mali certo per qualche motivo che non conosciamo, e che dobbiamo accettare, come da lui accettiamo i beni:
«Come parlerebbe una stolta tu hai parlato!
Se da Dio accettiamo il bene, perché non dovremmo accettare il male?» (Gb 2,10).
Qui c'è l'idea di un Dio volontà personale, assoluto arbitrio. È noto infatti che lo "io sono colui che sono" di Es 3,14 è in effetti l'affermazione di una assoluta sovranità, di un'assoluta volontà, di fronte alla quale sono nulla le altre volontà.[2]
Al contrario i greci hanno l'idea di dio, o dèi, sottomessi anch'essi a qualcosa di più alto, più giusto e più imparziale - fin da Omero, Iliade, VIII, 69; XXII, 209 -. Eraclito scrive che neppure il Sole può uscire dai suoi limiti, altrimenti le Erinni, ancelle della Giustizia, ve lo ricondurrebbero (fr. 94).
Ma non si tratta di differenze soltanto teologiche: come sempre, la teologia si fonda su un'antropologia. È diverso il concetto di uomo: da una parte quello, appunto, fondato sulla volontà — uomo come centro di volizioni, di appetiti, di desiderio, tutto proiettato nel molteplice e nel sensibile, fuori del quale non v'è soddisfazione, anzi, non v'è realtà —, dunque il concetto di uomo carne ed anima, intesa proprio come principio di movimento, principio di vita. Dall'altra un concetto di uomo che è sì corpo ed anima, ma è anche e soprattutto Logos: «Per quanto tu percorra l'anima, mai non ne troverai i confini, tanto profondo è il suo Logos», scrive ancora Eraclito (fr. 45) - e il Logos, a tutti comune, ovvero non mio opposto a tuo, non di Marco opposto a Luigi, è Logos di Dio e dell'uomo insieme.
2. La domanda di Giobbe, il problema del male, contiene già la sua risposta all'interno della concezione dell'uomo e di Dio che si ha: data quella, sono poi possibili solo insignificanti variazioni sul tema. La domanda di Giobbe, così come è posta, ha senso solo in un contesto idolatrico come quello biblico, dove Dio è l'Altro (si veda nel De non-aliud del Cusano il significato dell'alterità di Dio e la sua radicale confutazione), che serve a un altro, entrambi connotati necessariamente nell'ordine della potenza. Di fronte a questo Altro Potente, e solo di fronte ad esso, ha senso chiedersi perché mi "manda" questo o quello — e in questo "mandare" è già tutta contenuta la risposta. Ma perché pensi che "mandi"?
C'è un Altro solo perché c'è un ben radicato soggetto personale, un io con la sua affermatività, opposto ad altri, nei confronti dei quali il sentimento elementare è l'invidia.
Eckhart scrive che solo quando il bene degli altri ti è assolutamente caro come il tuo, per niente di meno, solo allora sei come devi, ed ha senso cominciare a parlare. Significa solo quando sei giusto, assolutamente uguale in tutte le cose, ed allora non più altro dalla giustizia. Tale l'affermazione più radicale del maestro tedesco: il giusto e la giustizia sono la stessa cosa.[3] Non devi pensare che una cosa sia il giusto e un'altra la giustizia: questa, diremmo con termini moderni, è alienazione, e, dal punto di vista religioso, superstizione e idolatria, giacché ti saresti costituito un oggetto-altro al tuo servizio. Nei confronti di tali persone, Eckhart dice che «seguono Dio come il nibbio segue una donna che porta frattaglie o salsicce, come i lupi seguono la carogna, come la mosca segue la pentola»: per essi c'è il male. Ma «cosa può riuscire molesto o amaro a colui il cui essere è Dio, il cui essere è l'essere divino, il cui essere è l'essere in Dio?». E prosegue: «Bisogna notare che queste persone sono beate anche in questo mondo. Infatti sempre avviene quel che vogliono, sempre gioiscono, perché gioiscono ugualmente in tutte le cose» (In Ioh. 231-233).[4]
Quando scompare l'io come centro di affermatività, Dio appare non più altro, e non più come qualcosa di determinato, connotato principalmente nell'ordine della potenza, bensì come «quoddam indistinctum, quod sua indistinctione distinguitur», «Dio è infatti un oceano di sostanza infinita, e perciò indistinta» ( In Sap . n. 154); Dio è l'essere di tutte le cose, ed anche il nostro essere; «Dio è tutto in tutte le cose», come scrive l'Apostolo (1 Cor 15,28), ed «opera tutto in tutti" (1 Cor 12,6), e perciò "in omasi opere, etiam malo, malo inquam tam poenae quam culpae, manifestatur et relucet aequaliter gloria dei» (In Ioh . n. 494). Niente è male per il giusto: se qualcosa ti pare male, è perché sei altro dalla giustizia, cioè ingiusto — ti chiami Giobbe o altro.
Il male è radicato nell'io, ovvero in ciò che ti pone come altro rispetto agli altri ed a Dio (hic est radix omnis mali et peccati, amor sui, amor privati boni: In Ioh. n. 484). È in realtà un io accidentale, fatto di relazioni sociali (nota bene come Giobbe sia in fondo d'accordo con Marx: l'essenza dell'uomo è data dalle sue relazioni sociali, cioè, in ultima analisi, dal suo potere). Ma i greci e il pensiero del logos, da Eraclito a Platone, hanno ben chiaro che il sociale, che è accidentale (il proprio, opposto al comune), costituisce il negativo per eccellenza, l'elemento della forza, non mai della giustizia. Simone Weil nota con finitezza come l'infelicità sia sempre qualcosa di sociale, in rapporto al "grosso animale", senso di impotenza, di umiliazione, di non potere — tolto il grosso animale, tolto anche il male.[5]
Questo infatti hanno pensato sempre i santi di tutte le religioni: che da Dio viene tutto (non una cosa sì e un'altra no), e che tutto è bene.[6] Non lo si comprende solo perché Fio fa da ostacolo: allora, per il potere, si assumono dei contenuti, che variano a seconda delle circostanze, delle persone e delle cose, ma che tutti — ivi compresi quelli religiosi — servono all'affermatività dell'io. Perciò la giustizia, la strada di verità, passa per il distacco, ovvero per la fine dell'affermatività dell'io: la triplice morte dell'anima della tradizione mistica, come si ritrova fin in Hegel.[7] Questa è la pàsan dikaiosynen di cui parla il Vangelo (Mt 3,15), dopo la quale soltanto appare il vero io, cioè l'universale, la vera natura umana [la scintilla, il fondo, ove non è niente di determinato, quel nous poietikòs che è perciò separato, unico, divino: cf. Aristotele, De anima III 430a], e questo è l'essere giusti.
Ciò che è prima, o diverso, non è propriamente umano, ma animale (nel senso etimologico, legato ad anima), dove non compare logos, dove non è spirito — e dunque dove tutto è male e dolore, la cui cifra essenziale è il desiderio, ciò che aliena dal presente, ciò che aliena, etimologicamente, dalle stelle, ovvero da Dio.
3. Il pensiero del logos è dunque innanzitutto distacco, la nobiltà dello spirito che si ritrae per non lasciare spazio alla forza, ma che tutto disprezza (l'uomo giusto tutto disprezza, scrive ancora Eckhart in In Ioh. n. 244), e perciò cancella rio, la cui essenza è affermatività. Essa disgusta l'uomo nobile, in quanto oscura l'universale, l'essere a tutti comune, ovvero il divino. Solo una forza più forte cancella la passione, insegna Aristotele nella Nicomachea, e dunque solo un animo nobile, che molto ama, non rimane legato al determinato, vittima, come un servo (Platone, Convito 210) della situazione. Tutto il positivo va rimosso, ogni forma di dipendenza: solo allora scompare il piccolo, meschino e stupido io e ci si immerge nell'universale, dove non si pensa più al soggetto come causa, ma come parte di una catena, di un flusso di eventi (atomi, onde, o che altro), in cui tutto è bene [Dio è in tutti i luoghi e in tutte le cose in quanto essere, In Ioh. n. 971.
Qui scompare anche l'immagine determinata di Dio come altro: Dio è un ente solo per i peccatori, scrive Eckhart (nel Commento alla Genesi, n. 211).[8] Niente come la metafisica dell'Esodo esprime idolatria — concetto di un Dio potenza, volontà assoluta — in stretto rapporto con l'idolatria sociale del "popolo eletto" e con l'utilizzazione personale di un Dio che "serve". Il suo segno distintivo è il dualismo, ma, ancora una volta, la lingua si incarica di mostrarci le cose: il due (dys) è il male; ove è due, lì è male e peccato, scrive Eckhart, che pure non sapeva il greco.
"Deus unus est",[9] ed anche l'uomo deve riconoscersi uno nell'Uno — altrimenti tutto sarà male e dolore.
Conseguenza importantissima: se le Scritture sono ciò che sostiene il dualismo, ovvero l'alienazione; se diventano la pietra tombale che copre il mistero della divinità e umanità di Cristo (cioè il superamento dell'alterità, di cui, non dimentichiamolo, il cristianesimo consiste), come scrive Giovanni Scoto nell'Omelia sul prologo di Giovanni,[10] allora anch'esse vanno rimosse. Noi dobbiamo diventare Logos, noi dobbiamo diventare la Parola vivente, essere la Scrittura e l'essenza, come canta Silesius,[11] dando voce poetica alle parole di Eckhart.
La grande riflessione greca sul Logos, cui abbiamo solo accennato, si salda con quella cristiana, in cui il Logos è Cristo/Dio, tramite cui tutto è stato fatto (Gv 1,3), e che è divenuto carne e passato nell'uomo, Logos anch'esso. Tutto ha dunque una ragione, tutto ha una causa — non v'è l'irrazionale, non v'è il male.
Il pensiero del male è infatti il pensiero che qualcosa non abbia una causa, dunque non abbia ragione, spiegazione: è pensiero del male, nel senso che è pensiero cattivo. Esso deriva dal dualismo biblico Dio-mondo, cui si contrappone il Vangelo di Giovanni, con il suo concetto di una eterna presenza dell'uomo e del mondo in Dio. Il pensiero del male è un pensiero servile, un pensiero della dipendenza, nel senso che l'essere e l'agire dell'uomo è sempre visto come soggetto ad altro. La libertà dell'uomo è, in esso, menzognera, perché ha l'unico scopo di liberare Dio dalla responsabilità del "male", cioè da quel che non si comprende, secondo uno schema che potremmo riassumere in tre punti:
- legame a se stesso, incomprensione, invidia, ressentiment, pensiero del male;
- pensiero di Dio a servizio dell'uomo, determinato positivamente in modo vario, comunque idolo che incarna quella giustizia che non si è;
- affermazione della libertà dell'uomo, che esenta Dio dalla responsabilità del male.
Quanto a quest'ultimo punto però bisogna dire che si tratta di una libertà fallace, una sorta di libertà condizionata, vigilata, perché sempre sotto giudizio, e che siamo in piena opposizione alle parole dell'Evangelo [il Padre non giudica, ma ha rimesso ogni giudizio al Figlio; il Figlio non giudica; l'uomo spirituale tutto giudica, e da nessuno è giudicato].[12]
Siamo qui all'opposto di un agire libero, creatore, che non sta mai a porsi problemi di dipendenza da questo o da quello [l'episodio di giustizia, che Lutero racconta del duca di Borgogna],[13] ma che trova gioia nell'agire, nella scelta e nella rivendicazione per sé della responsabilità (Nietzsche), dimentico di ogni utilitarismo (Machiavelli: amo la patria mia più dell'anima).[14]
4. Ogni tradizione spirituale, non solo cristiana, riporta tutto a Dio, non come tiranno capriccioso, ma come impersonale giustizia e necessità, e perciò rifiuta ogni moralismo, ogni giudizio di merito o di colpa. L'azione esteriore non ha alcuna importanza, non è di per sé né buona né cattiva — non vi sono né vi possono essere opere buone, sostiene Eckhart nel sermone "Mortuus erat et revixit",[15] e neppure ha senso condannare, come ben chiarisce il mistico sufi:
«Quando Ahmad ibn Hanbal fu avanzato negli anni e molto fragile, un gruppo di eretici si impadronì del potere a Baghdad e cercò di ottenere da lui una dichiarazione che stabilisse la giustezza delle loro opinioni. Imam Hanbal si rifiutò e gli furono inflitte mille frustate, poi fu messo alla tortura. Prima di morire, il che avvenne molto presto, dato come lo si torturò, gli fu chiesto cosa pensasse dei suoi assassini. Egli disse: "Posso dire soltanto che mi hanno colpito perché credevano di essere nel giusto e che io fossi nel torto. Come posso invocare giustizia contro chi è convinto di essere nel giusto?"».[16]
Si potrebbe però pensare al problema del male non in quanto male morale, ma solo in quanto dolore, e così al bene solo in quanto felicità. A ben vedere però, si tratta della stessa cosa: non si sa cosa siano dolore e gioia quando non si sa cosa siano bene e male. Di contro a una concezione volgare, che vede il bene e la felicità nelle cose (ancora Eraclito: «se la felicità si identifica con i piaceri del corpo, dobbiamo chiamare felici i buoi quando hanno cicerchie da mangiare» — fr. 4), il pensiero del Logos vede che il bene è nell'intelletto, non nelle cose (In Ioh. n. 518), così come nel solo intelletto è la grazia gratum faciens . La gioia è una sola: l'attività dello spirito — non il pensiero determinato dallo stato d'animo, e da mille altre condizioni, ma la considerazione, contemplazione dell'essere, sub specie aeternitatis, in ogni situazione, qui ed ora. In questo atto di amore/distacco viene superata l'alterità di Dio: il cristiano Eckhart e il laico Spinoza esprimono nell'identico modo il superamento dell'alterità: Idem amor et spiritus sanctus, quo pater filium diligit et filius patrem, quo deus nos diligit et nos deum (In Ioh. n. 506); «L'amore intellettuale della mente verso Dio è l'amore stesso di Dio, col quale egli ama se stesso, non in quanto egli è infinito, ma in quanto può essere spiegato mediante l'essenza della mente umana, considerata sub specie aeternitatis; cioè l'amore intellettuale della mente verso Dio è una parte dell'amore infinito col quale Dio ama se stesso» (Ethica, V, )(XXVI).
Qui le cose sono assolutamente indifferenti — solo dalla condizione soggettiva dipende il poterle sostenere, proprio come cinque chili sono troppi per un bambino, ma non troppi in sé. Che io non sia in grado di comprendere la bontà di una cosa non significa che essa non sia buona, come il fatto che non sono capace di risolvere un'equazione non significa che essa non abbia soluzione. E qui si tratta soltanto di togliere l'interesse personale, togliere l'io: allora si riconosce nella malattia che ci uccide lo stesso ordine universale, lo stesso bene, che ci ha dato vita. Questa considerazione, e solo questa, è il bene; e solo qui è gioia — la felicità dell'uomo divino, dei-forme perché uni-forme (In Ioh. n. 112), identica in tutto [Al termine della sua Etica, Spinoza parla giustamente di beatitudo e di salus]. Il -resto è solo dolorosa alternanza di speranza e timore: cupiditas e timor, le due porte per cui entra il demonio (In Ioh. n. 532).
5. Non è questo il luogo per tracciare una storia del pensiero del Logos da Eraclito al mondo cristiano — troppe sarebbero le tappe su cui dovremmo soffermarci, relativamente al problema del male. Certo una parte importante andrebbe riservata a quel grande, spesso dimenticato personaggio che fu Boezio, senza di cui la storia dell'Occidente avrebbe preso chissà mai quali strade, e al suo straordinario capolavoro, la "Consolazione della filosofia".
Vogliamo però segnalare, portando un piccolo contributo storico-filosofico, le eccezionali affinità su questo punto tra Eckhart e Spinoza, accomunati dal rigoroso rifiuto di pensare il male. Pensare il male è pensar male, in quanto significa pensare che qualcosa non abbia una causa — a questo, infatti, si riconduce in fondo il concetto di male —, e dunque a un pensiero assurdo. L'uomo pensa il male perché è egli stesso malus malvagio/malato —, ossia perché ingiusto, legato a un soggetto, opposto agli altri e alle cose. Perciò non è più capace di riconoscere nell'impersonale necessità il bene, la ragione, la voce stessa di Dio: l'interesse personale prende il sopravvento e tutte le cose vengono distorte da esso e per esso. Dato che tutte le cose sono regolate in conformità a ciò che richiede il fine, vero o stimato, ne consegue che, sovvertito e pervertito il fine, venga pervertito tutto ciò che si riferisce al fine: così Gerson sinteticamente esprime un principio valido sia sotto il profilo teorico, sia sotto quello pratico, riassumendo secoli di esperienza spirituale[17] . "Il male esiste solo per gli iniqui, ovvero per coloro che non hanno in mente Dio, ma soltanto le idee di cose terrene, alle quali sono dirette le loro opere e i loro pensieri" — scrive Spinoza nella lettera XXIII a G. de Blyenbergh.
«Se il Logos è nato in te, non ti turbi neanche vedendo uccidere tuo padre»: così Eckhart esprime il fatto che l'uomo giusto, l'uomo nobile, che è Logos, è in grado di superare il dolore legato alla soggettività, e il pensiero del male che fa tutt'uno con quel dolore[18] . Il maestro domenicano e il filosofo olandese insistono nel far rilevare quanto profondamente il pensiero del male, ovvero quello dell'alterità del bene, sia connesso con quello dell'alterità dell'essere e, a livello di rappresentazione religiosa, con quello di un Dio capriccioso che invia beni o mali, a piacere. Contro questa immaginazione, Eckhart non si stanca di ripetere che da Dio giunge solo il bene, e dunque, in altre parole, tutto quel che avviene è bene: non dobbiamo chiederci se è volontà di Dio quel che è accaduto, giacché, proprio perché è accaduto, è sicuramente volontà di Dio.
Conseguenza importantissima di questo pensiero è la radicale negazione delle attese o dei rimpianti: l'assoluto è nel presente, è il presente. Nel Commento alla Sapienza, n. 10, Eckhart scrive: «Pensiero senza intelletto è ogni pensiero malvagio, o relativo al male, o anche al passato o al futuro, o comunque relativo a un ente che racchiude il nulla, cioè la negazione. Infatti tutto ciò esprime il non-ente, o l'ombra dell'ente. Ma oggetto dell'intelletto è l'ente. Ente siffatto o pienezza dell'ente è lo Spirito santo».
Qui il pensare il passato o il futuro — la alienazione nella nostalgia o nell'attesa — è assimilato al pensare il male: entrambi sono pensieri vani, sine intellectu, perché non riguardano l'essere, e questo non è soltanto un errore intellettuale, o una innocua fantasia, bensì una sorta di peccato elementare — l'uscita dall'essere e il cadere nel nulla. Pensare il male, così come pensare il passato o il futuro, significa abbandonare il riferimento all'essere, cioè a Dio come causa prima e fonte dell'essere, ed allora il pensiero non è più intellectus, nel senso forte del termine, ma solo cogitatio vana . Intelletto vuol dire spirito: il solo "luogo" dove scende la grazia gratum faciens, dove abita Dio, che è egli stesso intelletto.[19] Perciò nel giusto - anzi, nell'uomo divino" - pensare ed essere sono lo stesso, così come l'intelletto, sempre separato dallo hoc et hoc, ha per oggetto Dio in assoluto, e in lui sono una cosa sola pensante e pensato.[20]
Pensiero senza intelletto significa dunque assenza di spirito, assenza di Dio, in noi, e poco conta che quel pensiero comprenda una qualche rappresentazione di un Dio: tale rappresentazione ha significato e fine utilitaristico, a servizio di beni che sono altri da lui, lontani dal presente, lontani dall'essere. Ma chi sta fuori dal presente come assoluto, chi sta fuori dall'essere, è comunque un bestemmiatore: «fa di Dio una capra, e la nutre con le foglie delle sue parole: fa anche di Dio un buffone, cui regalai propri vestiti vecchi e di poco valore» (In Sap . n. 61). La riprova di ciò è la preghiera come richiesta, verso la quale Eckhart ha parole durissime: chiedere il questo e il quello significa chiedere il male, chiedere la negazione di Dio, e che Dio si allontani da noi (Cf. In Ioh. n. 313. 605 s. 611. 613).
La parola conclusiva ci sembra però pronunciata dal filosofo in cui si conclude la riflessione classica e cristiana, cioè in Hegel. Nel suo capolavoro, la Fenomenologia dello spirito, contro ogni teoria utopica - ma in effetti diabolica, che vorrebbe riportarci a quel paradiso terrestre che non era altro che un giardino zoologico - scrive:
«La morte, se vogliamo così chiamare quella irrealtà, è la più terribile cosa; e tener fermo il mortuum, questo è ciò cui si richiede la massima forza. La bellezza senza forza odia l'intelletto, perché questo le attribuisce dei compiti che essa non è in grado di assolvere. Ma non quella vita che inorridisce dinanzi alla morte, schiva della distruzione; anzi, quella che sopporta la morte e in essa si mantiene, è la vita dello spirito. Esso guadagna la sua verità solo a patto di ritrovare sé nell'assoluta devastazione. Esso è questa potenza, ma non alla maniera stessa del positivo che non si dà cura del negativo: come quando di alcunché noi diciamo che non è niente o che è falso, per passare molto sbrigativamente a qualche cos'altro; anzi lo spirito è questa forza sol perché sa guardare in faccia il negativo e soffermarsi presso di lui. Questo soffermarsi è la magica forza che volge il negativo nell'essere».[21]
Il male non è altro che il positivo, il terreno di partenza su cui si eleva lo spirito. Il filosofo di Stoccarda non sapeva di star ripetendo, nell'essenziale, quanto scritto cinque secoli prima dal suo compatriota Eckhart, ad esempio nel sermone "Mortuus erat et revixit". Ma non occorre scomodare i cristiani: per rispondere alla domanda sul male basta Plotino, o comunque ogni filosofo che sia davvero tale, ovvero che eserciti il filosofare dopo il compimento delle virtù, senza menzogna, senza farsi intimidire da false autorità o presunti libri sacri, giacché "solo la virtù giunta a compimento e vivente nell’anima, insieme con la saggezza, mostrano Dio: senza la vera virtù, Dio è un mero nome”.[22]
Note
[*] Relazione tenuta a Trento, il 26 novembre 1992, per il Convegno "La domanda di Giobbe e la razionalità sconfitta".
[1]. S. WEIL, "L'Iliade, poema della forza", in : La Grecia e le intuizioni precristiane, tr. it., Borla, Torino 1967, 40.
[2]. Cf. W. BEIERWALTES, Platonismo e idealismo, tr. it., Il Mulino, Bologna 1987, cap. I, "Deus est esse, esse est Deus".
[3]. Cf. ad es. il "Libro della consolazione divina", in: Dell’uomo nobile, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1999. Sul tema del giusto e della giustizia è però da vedere soprattutto il Commento al vangelo di Giovanni ( In Ioh .), per cui cf. nota seguente.
[4]. Cf. Commento al vangelo di Giovanni, a cura di M. Vannini, Città Nuova, Roma 1992, 171 s.
[5]. Cf. i saggi raccolti sotto il titolo L'amore di Dio (tr. it., Borla, Torino 1968), soprattutto "L'amore di Dio e l'infelicità", 161 ss.
[6]. Una figura non sospetta di tendenze platonizzanti, come la beata Angela da Foligno, detta nel suo "Memoriale" frasi di questo tipo: «Sento Dio presente e capisco come sia in ogni creatura, in qualsiasi cosa che è, sia diavolo sia angelo buono, sia in inferno che in paradiso, sia nell'adulterio e nell'omicidio che nelle opere virtuose, in qualsiasi cosa fornita di essere, tanto se è bella quanto se è turpe... Non lo intuisco meno presente in un demonio che in un angelo buono. Perciò quando sto fissa in questa verità, non mi diletto meno di Dio guardando un diavolo o un adultero che un angelo buono, un'opera buona». (ANGELA DA FOLIGNO, II libro dell'esperienza, a cura di Giovanni Pozzi, Adelphi, Milano 1992, 205).
[7]. Cf. THEO KOBUSCH, Freiheit und Tod. Die Tradition der "mors mystica" und ihre Vollendung in Hegels Philosophie, in "Theologische Quartalschrift" 164, Stuttgart 1984, 185-203.
[8]. Ed. it. a cura di M. Vannini, Marietti, Genova 1989, 121.
[9]. Gal 3,20.
[10]. Cf. GIOVANNI SCOTO, Il Prologo di Giovanni, a cura di Marta Cristiani, Fondazione Lorenzo Valla, Mondadori editore, Milano 1987, 13: «Il sepolcro di Cristo è la divina Scrittura, nella quale i misteri della sua divinità ed umanità sono protetti dallo spessore della lettera come da una pietra tombale».
[11]. «Amico, basta oramai. Se vuoi leggere ancora, Va', e diventa tu stesso la Scrittura e l'Essenza». (Il Pellegrino cherubico, VI, 263; ed. it. a cura di G. Fozzer e M. Vannini, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo 1989).
[12]. Gv 5,22; Gv 8,15; 1 Cor 2,15.
[13]. «Si racconta del duca Carlo di Borgogna che un giorno un nobile prese un suo nemico. Venne allora la moglie del prigioniero per riscattare il marito; il nobile le promise di consegnarglielo se essa avesse consentito a giacere con lui. La donna era casta, ma molto desiderosa di liberare il marito: recatasi quindi da lui gli chiese se doveva far ciò per liberarlo. L'uomo, molto desideroso di essere libero e rimanere in vita, le diede il permesso. Ma dopo che il nobile si fu giaciuto con la donna, il giorno seguente fece mozzare il capo al marito di lei e le restituì così morto l'uomo. Allora la donna ricorse al duca Carlo e questi, chiamato a sé il nobile, gli ingiunse di prendere in moglie quella donna; trascorso il giorno delle nozze gli fece mozzare il capo e insediò la donna nei suoi possedimenti, e la riportò nuovamente in onore, e insomma seppe castigare davvero da principe la cattiva azione.
Ora, vedi, un giudizio simile né papi né giuristi né libri avrebbero potuto darglielo; esso uscì dal suo libero spirito al di fuori di ogni libro di diritto, e così avveduto che chiunque deve approvarlo, e chiunque trova scritto nel proprio cuore che proprio così era giusto. La medesima cosa scrive anche sant'Agostino commentando il sermone della montagna [ De sermone domini in monte, P.L. 34,1254]. Perciò le leggi scritte devono essere considerate inferiori allo spirito, dal quale tuttavia come dalla fonte della giustizia sono uscite; ma non si deve legare la fonte al suo fiumiciattolo e tener prigioniero lo spirito con la lettera» (MARTIN LUTERO, Sull'autorità secolare, in " Scritti politici ", Utet, Torino 1959, 441-442. Trad. leggermente rivista).
[14]. Lettera a Francesco Vettori, inviata da Forlì il 16 aprile 1525.
[15]. Cf. Sermoni tedeschi, a cura di M. Vannini, Adelphi, Milano 1991.
[16]. Cf. IDRIES SHAH, La strada del sufi, tr. it., Ubaldini, Roma 1971, 137.
[17]. Cf. JEAN GERSON, Teologia mistica, ed. it. a cura di M. Vannini, Ed. Paoline, Cinisello Balsamo, 1992.
[18]. Cf. sermone "Videte qualem caritatem" ( Sermoni tedeschi, cit., 229).
[19]. Cf. In Ioh . n. 500, nonché la Quaestio parisiensis, Utrum in deo sit idem esse et intelligere, in: M. VANNINI, Meister Eckhart e il fondo dell'anima, Città Nuova, Roma 1991.
[20]. Cf. In Ioh. n. 508.669.
[21]. Cf. G.W.F. HEGEL, Fenomenologia dello spirito, tr. it. di E. de Negri, La Nuova Italia, Firenze 1960, 26.
[22]. Enneadi, II, 9.