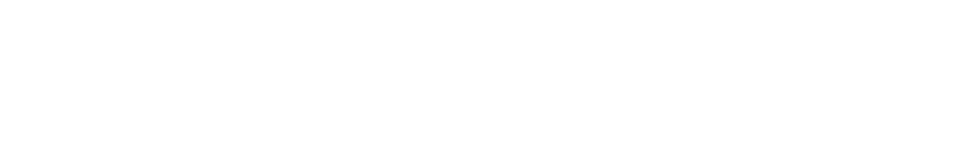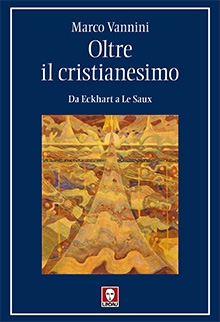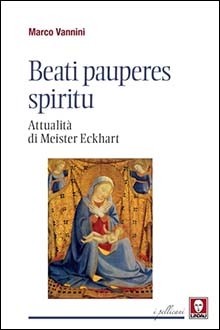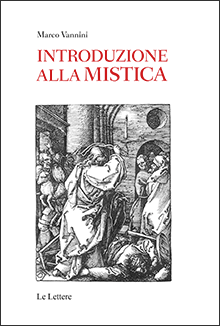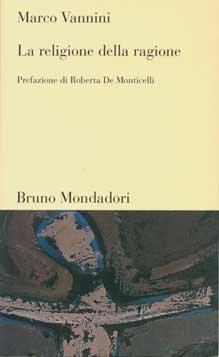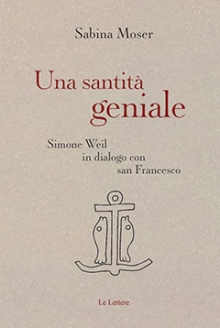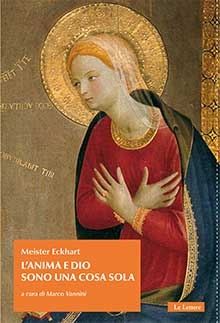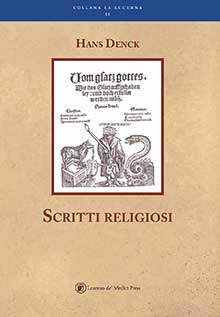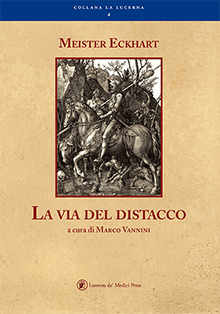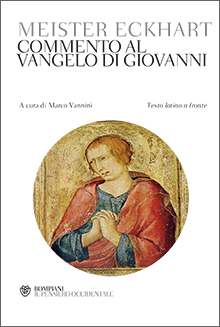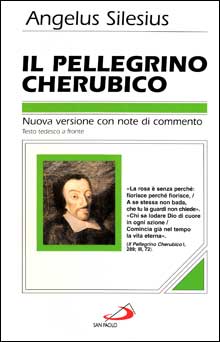L’anima, Dio e l’ansia del “nulla” in Eckhart
Francesco Roat, in: <Il Sussidiario.net>, mercoledì 17 febbraio 2021.
Risulta davvero pregevole, ben tradotta e assai puntualmente commentata, l’antologia di testi del grande mistico medioevale Meister Eckhart dal titolo L’anima e Dio sono una cosa sola (Le Lettere, 2020) a cura di Marco Vannini, che, grazie al suo impegno pluridecennale di traduttore e interprete, ha consentito ai lettori italiani la conoscenza dell’intera opera di Eckhart. Mi pare comunque opportuno precisare subito, per quanti giudicassero azzardata la suddetta titolazione/definizione, che il magister tedesco si rifà giusto a San Paolo, il quale afferma in modo inequivocabile: “chi si unisce al Signore forma con lui un solo spirito” (1Cor 6,17). Quindi, prendendo le distanze dal dualismo di origine vetero-testamentaria, per il quale la divinità è altra e altrove rispetto all’uomo, Eckhart sottolinea invece l’unità spirituale ( unitas spiritus), cioè l’equivalenza, tra l’anima ‒ o meglio ancora: tra quello che egli chiama il “fondo” (grunt) di essa ‒ e Dio.
I brani maggiormente esemplari qui presentati sono soprattutto tratti dai Sermoni tedeschi ‒ scritti in volgare alto-medio tedesco, o Mittelhochdeutsch ‒ che appaiono di maggiore interesse per la loro valenza mistica. Essi sono altresì testimonianza d’un intento senz’altro meritorio/provocatorio da parte di Eckhart: rinnovare il modo d’esser cristiani. In primo luogo aborrendo ogni pratica mercantilistica che veda il rapporto tra uomo e Dio basato sulla trattativa del do ut des: del faccio questo o mi comporto in un certo modo per ottenere qualcosa in cambio/premio dalla divinità.
Semplificando alquanto, si potrebbe asserire che la tematica basilare affrontata in questi sermoni sia l’esigenza di una condotta all’insegna dell’abnegazione e del “distacco” (abegescheidenheit) da ogni attaccamento mondano quali prerequisiti indispensabili a un approccio esistenziale/esperienziale di tipo mistico; ciò onde ottenere la generazione interiore del Logos nell’anima. Solo così ogni uomo giusto o nobile, per usare un termine caro a Eckhart – può divenire un essere divino, alla pari del Cristo.
Ma se si intende far sì che il Figlio abbia a nascere nell’anima è necessario predisporla in modo che essa sia priva d’ogni forma di brama o egotismo, mediante un abbandono che è insieme magnanimità e non-dipendenza dall’inessenziale.
Come a dire: non c’è intervento esterno, salvatore divino che possa elargirti alcuna redenzione se non fai tua la kenosis cristica, se non sacrifichi l’ego, mortificandolo. Non è bene infatti, secondo il magister, desiderare alcunché per sé: neppure la realizzazione spirituale, agognare la quale non sarebbe che una diversa modalità d’ambire comunque ad una acquisizione egocentrica, al possesso. Possesso che in ogni caso mai si potrebbe ottenere, poiché la “divinità” (gotheit) non è un oggetto e neppure un ente. Per questo, afferma Eckhart nel Sermone 52: “prego Dio che mi liberi da Dio”; esortazione niente affatto blasfema, in quanto esprime l’auspicio d’essere affrancato da ogni forma idolatrica e da ogni pretesa acquisitiva.
Nell’ottica eckhartiana il distacco si coniuga dunque all’accettazione serena della realtà/esistenza, anche (soprattutto) quando essa comporti privazioni, pene, lutti. Un’accettazione non certo masochistica, che non ha nulla della passività o dell’apatia ma che si configura come una sorta di noluntas , di abdicazione alla propria volontà/egoità che appunto più niente vuole. Eppure, paradossalmente, nulla volendo si ottiene assai: in ogni circostanza dimorando quietamente, imperturbabilmente. Solo così, secondo il Meister renano, gli uomini possono divenire ‒ qui e ora, non già in un futuribile/ineffabile eden ‒ “beati” (saelic).
A proposito di beatitudine nella quotidianità/accoglienza del presente senza aspettative d’alcun genere, emerge con grande evidenza la prossimità tra Eckhart e il buddhismo ‒ come peraltro già da tempo sottolineato da D.T. Suzuki ‒, resa ancora più accentuata dalla presa di distanza nei confronti d’ogni dualismo, ad esempio il consenso ad astratte o infondate dicotomie, quali: immanenza-trascendenza, naturale-soprannaturale, io-altro-da-sé. Vere trappole concettuali da cui, secondo la lezione del filosofo renano ‒ chiamato da Heidegger Lebemeister: maestro di vita ‒, è bene liberarsi. Perciò, appunto, l’uomo pneumatico: “niente vuole, niente sa, niente ha” (Sermone 52).
Va precisato tuttavia che questa serie di nulla si riferisce alla hybris (tracotanza) dell’egocentrismo e alla sua perenne tensione/smania desiderante, la quale non cessa con la soddisfazione d’alcun conseguimento; alla pretesa, inoltre, di comprendere intellettualmente ciò che valica i limiti dell’umano sapere (Dio); infine alla fame insaziabile di possesso/primato: in primo luogo quello, apparentemente encomiabile, costituito dal proposito di acquisire giusto la piena realizzazione spirituale.
Tornando al tema centrale dell’abbandono-distacco, mi sembra opportuno un ulteriore chiarimento. La posizione di Meister Eckhart non esprime certo rifiuto/disprezzo del mondo o disinteresse verso quello che cristianamente è indicato come il nostro prossimo. Qui non si tratta di mera apatia, bensì di un salutare non-attaccamento a cose, ambiti o persone: sorta d’indipendenza che implica un modo di essere libero dalla soggezione nei confronti di alcunché. Il vocabolo abegescheidenheit, utilizzato dal mistico tedesco, corrisponde peraltro al termine sanscrito anabhīnivesa, che significa non-attaccato/non-aggrappato.
Ancora in relazione al motivo/fine basilare dell’insegnamento eckhartiano, va aggiunta una puntualizzazione: molte sue prediche insistono sull’invito, rivolto a uditori e/o lettori a prender le distanze da una religiosità meschina, tipica dei commercianti, di chi insomma si rivolge a Dio onde ricavarne ausilio, protezione o giovamento di qualsivoglia genere. Ma non basta: lo stesso desiderio di Dio alla fin fine non si scosta di molto dalle altre ambizioni mondane, più o meno nobili esse siano. Va ribadito dunque che rinunciare a sé stessi, ovvero alla propria egoità, è condizione prima e indispensabile per la mistica d’ogni tempo e luogo. In tale prospettiva non abbiamo pertanto a che fare con la rinuncia tout court al sapere rispetto alle cose (quello della scienza, per intenderci), ma piuttosto col venir meno d’ogni supponenza di poter giungere alla com-prensione di Dio: a farlo nostro, racchiudendolo in una determinata teologia o anche solo nell’intelletto.
In quest’ottica Meister Eckart paradossalmente auspica che Dio lo affranchi persino dalla stessa sete di nutrimento ultraterreno e/o dalla velleità di avere sublimi esperienze contemplative; lo prega insomma di liberarlo/liberarci da false idee/immagini di Dio e da qualsivoglia vana tesaurizzazione spirituale. Solo così si potrà accedere autenticamente all’ambito divino, e ‒ svuotatisi di tutto: nulla volendo, sapendo, avendo ‒ godere di tutto.